Una terapia intensiva per gli organi espiantati, il chirurgo Cillo: «Così inizia la rivoluzione dei trapianti»
Il chirurgo e professore dell’Università di Padova è il nuovo presidente elect di Esot: «Il futuro è già qui: ho pubblicato uno studio sperimentale in cui abbiamo tenuto in vita un fegato per 17 giorni. In questo modo un organo non utilizzabile può diventarlo. Nel nuovo ospedale di Padova una terapia intensiva dedicata agli organi espiantati»
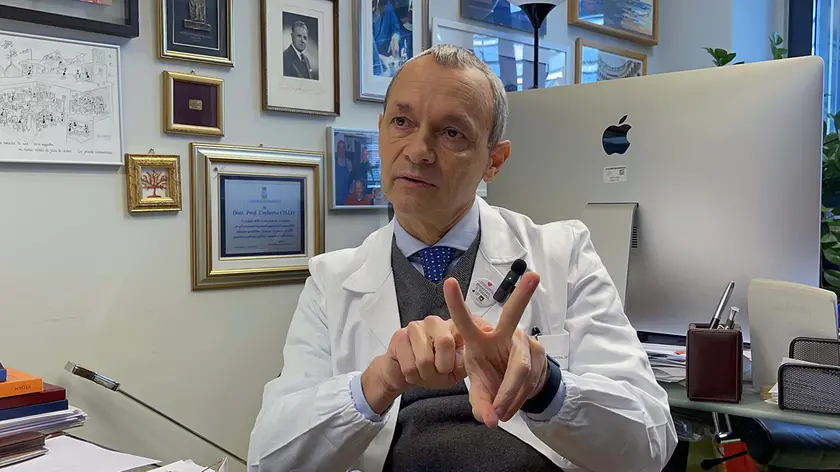
Professor Cillo, lei è stato nominato presidente elect di Esot, la più grande società trapiantologica europea e probabilmente mondiale. Un riconoscimento anche per la sanità italiana e veneta?
«Vivo a Padova, ho fatto qui le scuole e l’Università. Poi sono stato negli Usa e in Giappone, ma sono nato e cresciuto nella sanità veneta e mi sento una sua espressione.
La nomina è personale, ma è anche una gratificazione a questa realtà: se figure che vengono da qui trovano riconoscimento a livello europeo, vuol dire che è un sistema in grado di far crescere e lavorare ad alto livello. Per il futuro il mio desiderio è di coinvolgere la regione e i suoi professionisti, in tutti i modi possibili. Oggi la ricerca funziona anche attraverso il networking».
La nomina avrà ricadute sulla ricerca in Veneto?
«Mi impegnerò a far da volano alla ricerca e alle capacità e dei professionisti di questa regione e delle sue università. Come coordinatore del CERTEV, il centro di ricerca traslazionale della Regione Veneto che si occupa di studi avanzati sui tumori del fegato, promuoverò scambi internazionali per creare sinergie. Le grandi Società scientifiche come ESOT rendono più accessibile il milieu culturale europeo e fanno crescere le potenzialità di ricerca e i risultati».
Si può pensare a un’unione europea in materia di donazione di organi e trapianti?
«L’Europa è un grande continente, ma con molte disomogeneità normative e procedurali. Consideriamo l’allocazione degli organi: c’è Eurotransplant che riunisce diversi Paesi, soprattutto del Centro-Nord Europa, ma molti, tra cui l’Italia, altri hanno un’allocazione nazionale. Gli Stati del Sud Europa, si sono consorziati nel South transplant alliance che permette una certa integrazione e una grande sinergia, ma è una cosa diversa dalla condivisione. C’è comunque una forte esigenza di uniformare le leggi europee sulle donazioni».
Com’è la situazione liste d’attesa?
«L’integrazione tra stati può aiutare, per esempio per le urgenze, anche se tutte le liste dei paesi europei sono strabordanti di pazienti. C’è un’enorme richiesta che l’offerta non riesce a coprire. Con ESOT stiamo lavorando ora per implementare le attività di trapianto in alcuni Paesi dell’Est che sono un po’ più indietro: se in Francia e in Italia ci sono 28-29 donatori per milione di abitanti, in Romania siamo a 4,1. C’è forte disomogeneità perché non tutti i Paesi europei hanno attivato la tecnica del donatore a cuore non battente (DCD). Anche noi siamo arrivati tardi a questa tecnica perché i tempi di osservazione del donatore senza battito cardiaco sono tra i più lunghi del mondo, 20 minuti. Sembrava impossibile, poi sono arrivate le macchine da perfusione ed è stato fatto un enorme salto in avanti, con un aumento imponente della donazione. Se nel 2023 abbiamo avuto 444 donatori a cuore fermo le proiezioni per il 2025 sono di 844.
Chi guida la donazione a livello europeo?
«La Spagna è prima nel mondo e questo grazie a leggi e a una trasformazione culturale passata anche attraverso i film di Almodovar che hanno reso la donazione “un gesto importante”. Ci sono oltre 50 donatori per milione di abitanti, l’Italia ne ha 29. Da noi ha influenzato il caso di Nicholas Green, il bimbo americano morto in Italia nel ’94: i genitori diedero il via libera alla donazione sensibilizzando sull’argomento. Eravamo agli ultimi posti in Europa e siamo molto risaliti, oggi siamo quarti. La cultura e le legislazioni diverse hanno prodotto risultati diversi. E questo vale anche all’interno delle regioni italiane».
Com’è il Veneto?
«È tra le migliori regioni d’Italia. Probabilmente finiremo il 2025 al secondo posto dopo la Lombardia. I donatori utilizzati sono 49 per milione di abitanti in proiezione, sovrapponibili alla Spagna. L’anno scorso eravamo a 43,9».
Nuove tecnologie, come ci aiuteranno?
«Stiamo vivendo una rivoluzione concettuale, tecnica e clinica: l’introduzione delle macchine da perfusione per fegato, cuore, polmone. Da una parte migliorano la qualità degli organi e dall’altra permettono di prolungare i tempi di ischemia, ogni organo “trattiene il respiro” quando viene espiantato finché non viene trapiantato nel ricevente. Questa rivoluzione è alla base dell’aumento di alcuni trapianti. Da qui parte una nuova Medicina».
Di cosa si tratta?
«Una Medicina mai esistita fino ad oggi: quella degli organi fuori dal corpo. Siamo abituati a pensare alla cura della persona, ebbene oggi c’è anche quella dell’organo isolato. Perché l’organo tenuto fuori dal corpo, perfuso con sangue, collegato a un sistema di dialisi e di nutrizione, è un piccolo essere vivente che si può “curare”. Con Federico Rea abbiamo preteso che nel nuovo ospedale di Padova venisse integrata tra le sale operatorie una sala di 400 mq, completamente dedicata all’organ recovery.
Sarà una terapia intensiva, si vedranno, come nei film di fantascienza, polmoni che ventilano, fegati che producono bile, reni che producono urina, cuori che battono. È un futuro che è già qui: ho pubblicato uno studio sperimentale in cui abbiamo tenuto in vita un fegato per 17 giorni. In questo modo un organo non utilizzabile può diventarlo, si può cambiarne il gruppo sanguigno e in futuro lo si potrà modificare geneticamente per renderlo più accettato dal ricevente prevenendone il rigetto».
«I tempi?
«Per il fegato credo cinque anni. Nel frattempo stiamo ancora aspettando il riconoscimento delle DRG per le macchine, cioè la rimborsabilità che attualmente non c’è. È una delle situazioni in cui la normativa non riesce a star dietro alle evoluzioni della ricerca e della clinica. Nel frattempo, due anni fa, la Regione ha messo a disposizione alcuni milioni per questa implementazione tecnologica e il risultato è sotto gli occhi di tutti: facciamo molti più trapianti e con migliori risultati. I nostri pazienti stanno meno in terapia intensiva e vanno a casa prima».
Un traguardo già raggiunto quindi.
«Siamo agli albori, siamo i pionieri e molto deve venire. Ci sono per esempio gli xenotrapianti, un’altra frontiera straordinaria. Cina e Usa stanno trapiantando organi di animali geneticamente modificati in pazienti in morte cerebrale, un setting completamente sperimentale la cui fattibilità in clinica non è ancora sul campo, le macchine sono invece già in uso. Un’altra delle frontiere d’avanguardia è quella della medicina rigenerativa con stampanti 3d o organi bioingegnerizzati con l’AI che rivoluzionerà tutto. Abbiamo presentato un progetto, AI e trapianti di fegato, con il nostro centro veneto».
Gli ostacoli?
«Quando parliamo di trapianti, parliamo solo di numeri di interventi e di donazioni. Ma quello che non si vede, è il sommerso, l’accesso al trapianto e alle sue liste, accesso che è diverso nei diversi Paesi europei ma anche nel nostro Paese. ESOT ha l’obiettivo di aiutare a renderlo più equo per tutti. In Italia c’è un forte problema di under referral: il riferimento non fatto o tardivo ai centri di alta specialità e ai centri trapianto. Temiamo ci possa essere una sottostima dei pazienti che realmente abbisognano del trapianto. E’ necessario promuovere una più stretta comunicazione tra territorio e centri di riferimento specialistico».
Riproduzione riservata © il Nord Est








