Caccia ai veleni: ecco il sensore triestino che individua i Pfas in soli dieci minuti
Il dispositivo è in grado di rilevarne minime concentrazioni nell’acqua grazie a un rivestimento molecolare capace di catturare gli inquinanti

Mentre il tribunale di Vicenza, con una sentenza che fa storia, condanna 11 dirigenti Miteni per il disastro ambientale da Pfas che ha coinvolto 300 mila persone in Veneto, dall’Università di Trieste arriva una notizia che potrebbe rivoluzionare il futuro del monitoraggio ambientale: un sensore portatile, economico e capace di rilevare in pochi minuti la presenza di Pfas nelle acque.
La ricerca, coordinata da Marcello Berto dell’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con Pierangelo Metrangolo del Politecnico di Milano e Lucia Pasquato dell’Università di Trieste, è stata pubblicata su Advanced Functional Materials nell’ambito del progetto Prin-Nifty.
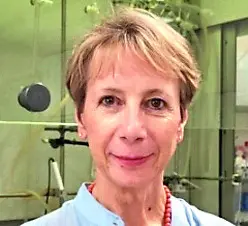
Un “mantello molecolare”
Il colpo di genio della scoperta sta nel rivestimento molecolare progettato dal team di Pasquato. Immaginate un elettrodo d’oro – il “cuore” del sensore – ricoperto da uno speciale “mantello” fatto di molecole disposte in un solo strato.
«Abbiamo creato un rivestimento con due tipi di molecole – spiega Lucia Pasquato, docente di Chimica organica di UniTs –: le prime riconoscono questi inquinanti grazie alle interazioni fluoro-fluoro; le seconde migliorano la bagnabilità della superficie».
Quando l’acqua contaminata entra in contatto con il sensore, i Pfas vengono “catturati” dalle molecole fluorurate, mentre quelle idrofile facilitano il contatto con l’acqua. Il risultato è un cambiamento nella conduttività elettrica che il dispositivo rileva immediatamente.
«Il nostro dispositivo individua i Pfas e ne misura la concentrazione nell’acqua», precisa Pasquato. «La preparazione del campione è molto semplice e bastano meno di dieci minuti per fare l’analisi. Riusciamo a determinare quantità molto piccole, al di sotto dei limiti imposti dall’Ue».
Per ora il sensore è stato testato con tre diverse sostanze perfluorurate con catene lineari di atomi di carbonio. «Per riconoscere altri tipi di Pfas andremo a ingegnerizzare il monostrato auto-assemblato con molecole diverse», evidenzia la ricercatrice.
La differenza con i metodi attuali
Per capire l’importanza della scoperta, basta guardare come vengono oggi rilevati i Pfas. Il metodo standard si basa sulla cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa tandem: una tecnica sofisticata, costosa e che richiede laboratori specializzati. I campioni devono essere trattati con estrema cautela per evitare contaminazioni e l’intero processo può richiedere giorni tra prelievo, trasporto in laboratorio e analisi.
I “forever chemicals”: dove li troviamo e quali danni comportano
I Pfas – acronimo di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche – sono una famiglia di oltre 10.000 composti chimici che una volta dispersi nell’ambiente, non si degradano mai. Li troviamo nelle padelle antiaderenti, nei tessuti impermeabili, negli imballaggi, nei cosmetici, nelle schiume antincendio. Ciò che li rende preziosi per l’industria – la resistenza all’acqua, ai grassi e alle alte temperature – è esattamente quello che li trasforma in un incubo ambientale.
Ma sono un incubo anche per la salute umana: tra questi composti, che si accumulano nel nostro organismo, alcuni sono stati classificati come cancerogeni, altri possono provocare danni al fegato, alterazioni del sistema immunitario, problemi alla tiroide, difficoltà riproduttive.
Una rivoluzione nel monitoraggio
Il sensore triestino potrebbe cambiare completamente lo scenario sul fronte del monitoraggio: rendendolo molto più rapido ed economico, i controlli potrebbero essere molto più frequenti e capillari, soprattutto nelle aree a rischio.
Ma la vera rivoluzione potrebbe arrivare dalla prossima sfida del team triestino: una ricerca di frontiera per passare dall’individuazione alla bonifica.
«Sui Pfas c’è molto da fare e noi vogliamo riuscire anche a rimuoverli», sottolinea Pasquato. «Stiamo lavorando per avere materiali semplici ma efficaci nel sequestrare queste molecole dall’acqua: i principi usati per realizzare questo dispositivo possono essere impiegati per ingegnerizzarli».—
Riproduzione riservata © il Nord Est








