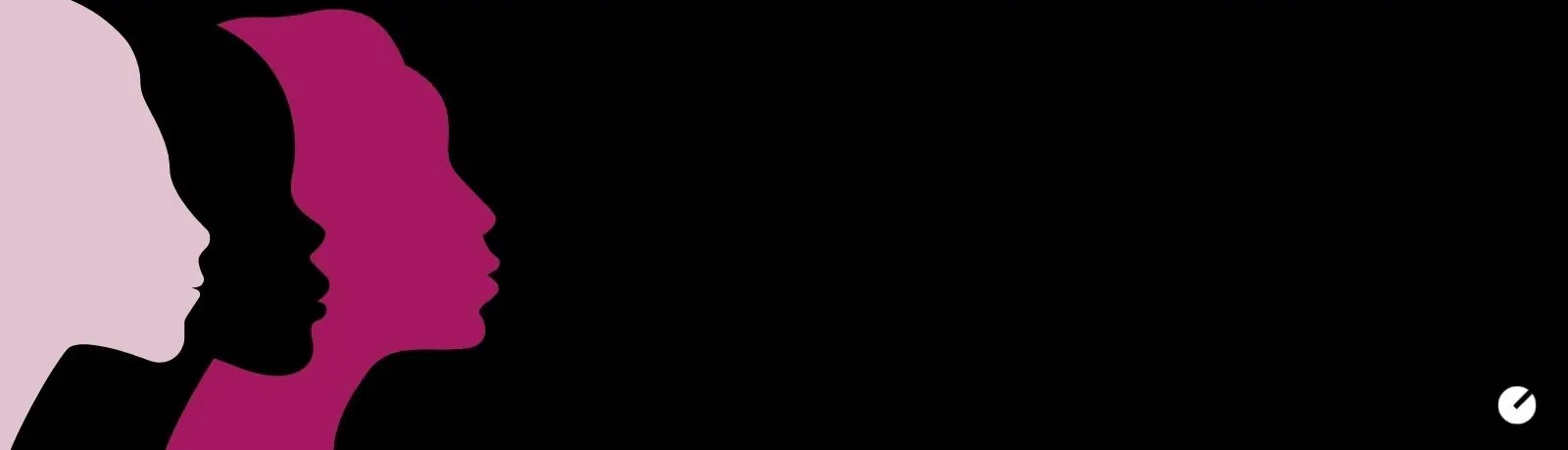Ottomila scelte di vita nel museo di Nova Gorica
Cuoche, cameriere, balie, governanti, sarte migrate in Egitto: un museo ricorda la storia delle Alessandrine. Da Gorizia, dal Friuli, dalla Slovenia, terre di un impero asburgico in declino, si spostarono nelle terre del Canale di Suez

Dal porto di Trieste si navigava su piroscafi per almeno tre giorni per arrivare ad Alessandria d'Egitto. Dalle campagne e dai paesi friulani e sloveni, dove fra 1800 e 1900 abbondavano povertà e mancanza di futuro, a una città cosmopolita in fermento e crescita di ricchezza con capitali provenienti da tutta Europa per l’apertura del Canale di Suez, connessione di traffici e merci fra Mediterraneo e Oceano Indiano. Dalle terre dell’Impero asburgico, prossimo al disfacimento, a una società in espansione vertiginosa, nelle case e palazzi della classe dominante europea e ebrea.

Il viaggio della ragazze
A compiere questo viaggio verso un mondo e una vita nuovi erano giovani donne alle quali le famiglie chiedevano di sacrificarsi, abbandonando figli spesso lattanti, case e affetti per andare ad accudire e crescere i pargoli di donne ricche che non avevano tempo né inclinazione per essere madri e casalinghe.
Oltre il Mediterraneo venivano chiamate les goricienne, les slovenes, les friulans; era un vanto averle in casa. Nelle terre di origine erano soprannominate aleksandrinke, alessandrine. La memoria delle loro vite è stata rimossa per oltre mezzo secolo, ma si sa la polvere copre, non cancella. Sono riemerse e oggi si studia questo fenomeno sottostimato della migrazione femminile che divenne anche movimento di emancipazione.
La Casa delle Alessandrine
Lo racconta in Slovenia a Nova Gorica, località Prvačina 48 nella valle del Vipacco, una quindicina di chilometri dall’ex confine passando per Šempeter-Dornberk, il museo “La Casa delle Alessandrine”, www.aleksandrinke.si, www.vipavskadolina.si, info@aleksandrinke.si, visite su prenotazione.
Un allestimento vivo perché tutto è originale, donato dalle protagoniste di questa epopea per il pane. Un museo nato nel 2010 per fare emergere le loro vite e memorie attraverso oggetti personali, vestiti ed accessori, documenti e fotografie, ninnoli e libri che queste donne portavano con sé, partendo verso una terra lontana e sconosciuta. Ma anche il nuovo, raffinato, ricercato e introvabile che riportavano quando tornavano a casa per poi ripartire.
Cuoche, cameriere, bambinaie, sarte
Questo fenomeno di massa ebbe inizio nella seconda metà del XIX secolo. Successivamente, all’apertura nel 1869 del canale di Suez, crebbe la presenza dell’alta borghesia soprattutto ad Alessandria e al Cairo. Le ragazze e le donne, per lo più d'origine contadina ma anche della piccola borghesia impoverita dalle guerre del Novecento, trovavano lavoro come cuoche, cameriere, bambinaie, balie, governanti, sarte. Erano molto apprezzate in quando disciplinate, ordinate e pulite, sapevano crescere bene figli e nipoti, non erano dure e rigide come le svizzere e le britanniche, erano materne e solari.

Inoltre molte conoscevano le lingue, sapevano leggere e far di conto e imparavano molto velocemente le buone maniere delle case dove servivano. Nelle terre di provenienza portavano la raffinata moda di Parigi, il piacere del te inglese, della lettura e della conversazione nei salotti. Furono loro a mantenere le famiglie, soprattutto negli anni dopo le guerre.
Una realtà non accettata nella società patriarcale e per questo forse il ricordo del loro sacrifico è stato rimosso e a volte derubricato a denaro facile, guadagnato contravvenendo alle regole della morale imperante. Tornarono in molte delle migliaia partite, ma dovettero mettere da parte l’autonomia e l’indipendenza che avevano conosciuto ad Alessandria d’Egitto.
Circa ottomila partirono dai territori dell’Impero asburgico, oggi Veneto, Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Carniola. Un supporto venne offerto delle Suore slovene francescane di Cristo Re, presenti in Egitto già nei primi anni del '900. Le religiose davano sostegno di carattere spirituale ma anche un rifugio in caso di problemi con la famiglia datrice di lavoro.

1906: l’amore tra Josa e Oswald James
A Trieste nel 1906 nacque la storia d’amore tra una ragazza di Santa Croce del Carso e un magnate inglese delle ferrovie e cotone. Un colpo di fulmine per il trentenne Oswald James Finney per la bella Josa Sedmach esploso mentre era per affari nella città giuliana. Si sposarono ad Alessandria al compimento del suo diciottesimo anno; e vissero a lungo felici istituendo una fondazione per aiutare le persone bisognose.
Due letture consigliate
Letture consigliate: “Le Alessandrine. Storia di emigrazione femminile tra Ottocento e Novecento” di Ivana Tomasetti (Ciesse edizioni) racconta del clima di libertà e spregiudicatezza che a quel tempo si respirava ad Alessandria, dove le balie italiane furono un emblema di modernità. Il denaro del baliatico permise di mantenere intere famiglie, ma le segnò a dito per la loro intraprendenza. Affascinante il romanzo di André Aciman “Ultima notte ad Alessandria” (Guanda).
Riproduzione riservata © il Nord Est