Pennacchi: «Il mio Shakespeare a Venezia»
Esce il secondo romanzo dell’attore padovano, il protagonista è ancora Will. Accanto a lui una galleria di figure destinate a diventare personaggi teatrali

Andrea Pennacchi è vulcanico. Mentre nella campagna romana gira alcune scene del film diretto da Mel Gibson, per il teatro prepara “Alieni in Laguna” e in televisione propone le avventure del Pojana e dei suoi fratelli. Non contento, in libreria arriva “Una foresta di scimmie” (Marsilio, p. 304, 16 euro), la seconda avventura di un William Shakespeare reinventato, arrivato in Veneto in missione segreta e coinvolto in una serie di avventure tra il comico e il giallo che coinvolgono personaggi reali, come il maestro di scherma Vincenzo Saviolo, e altri destinati a diventare personaggi delle sue opere teatrali.
Nel primo libro, “Se la rosa non avesse il suo nome”, accanto a “Will” e alla sua banda di amici c’erano Romeo e Giulietta, qui Shylock, Antonio, Porzia, Bassanio.
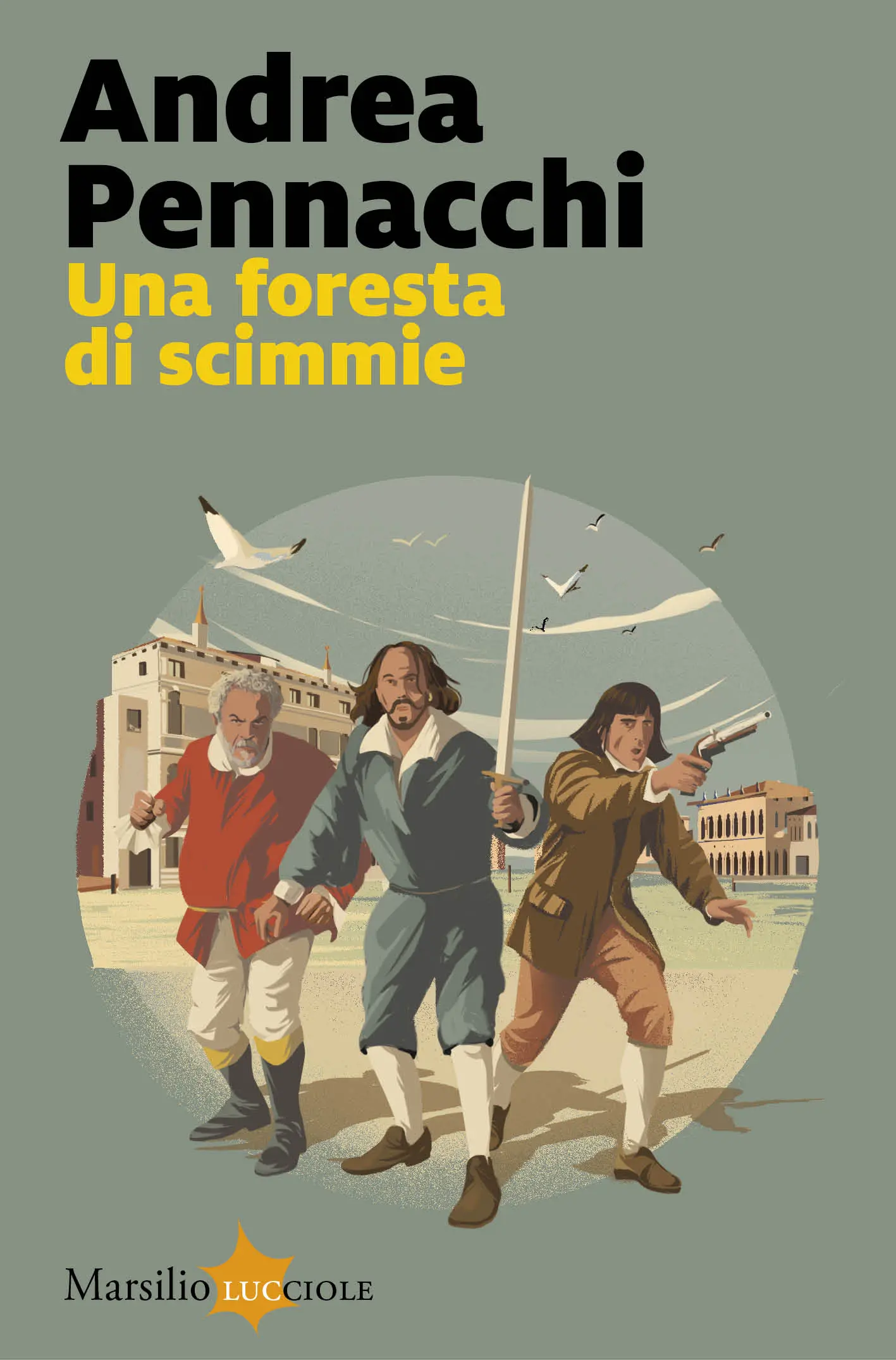
Il nuovo libro sarà presentato lunedì 24 novembre alle 18.30 alla libreria Lovat di Villorba.
Seconda avventura: più facile o più difficile?
«Come dice Caparezza, il secondo album è sempre più difficile. Mentre scrivevo il primo però avevo già in mente un percorso: una volta esaurita l’avventura padovana, William doveva cercare di tornare a casa, passando per Venezia. Lì si trattava di scegliere quale opera shakespeariana ambientata a Venezia potesse essere uno spunto. Ho trovato “Il mercante di Venezia”».
Con questi libri lei si inserisce in un “buco” effettivo nella biografia di Shakespeare, immaginando una sua possibile presenza in Italia.
«Ho letto molti libri sugli “anni perduti” di Shakespeare. Purtroppo, non ci sono prove che sia stato in Italia e la bilancia pende verso uno Shakespeare rimasto sempre in Inghilterra. Ma anche questo è affascinante, perché a Londra incontrava persone da tutto il mondo, incrociava notizie dal Nuovo Mondo e da Venezia, che era allora molto legata alla regina Elisabetta».
Anche le fonti di “Il mercante di Venezia” sono in qualche modo misteriose.
«Ci sono aspetti molto interessanti. Nel mio libro compare il personaggio di Lopez, medico che quasi certamente studiò a Padova e poi divenne medico della regina Elisabetta. Era ambizioso, intelligente, ma finì giustiziato, accusato anche di essere un marrano, cioè un falso convertito. Questa figura è quasi certamente una fonte per Shakespeare. Poi c’è la fonte sicura: “L’ebreo di Malta” di Marlowe, che Shakespeare ribalta completamente, dipingendo l’ebreo con tratti umani profondi, emozionanti. Era impossibile non usare questa ricchezza».
Però ha sovvertito la trama.
«Ho rubato, ma con consapevolezza di cosa mi serviva rubare. Mi piaceva giocare sulla dicotomia di Venezia in quel periodo: tra nuovi mercanti che cercano di rompere la chiusura economica e vecchi soldi che si ritirano nelle ville. È una dinamica che vediamo anche oggi. E volevo una Porzia più attiva, intelligente, non relegata al solo desiderio di matrimonio».
Il libro trasmette un grande senso di divertimento. Si è sentito più libero rispetto al primo libro?
«Nel primo avevo due pesi: volevo dire tutto e avevo ansia da prestazione, perché era il mio primo romanzo e io da grande lettore ho rispetto per la letteratura. Qui ero più tranquillo: non volevo mettere tutto, ma centellinare le cose per dare loro il giusto valore: volevo divertirmi di più, sperando che si diverta anche il lettore».
Il successo del primo libro è andato oltre il Veneto nonostante il dialetto.
«Funziona, facendo un esempio molto più illustre, come il siciliano in Camilleri: ci sono cose che vanno dette in una certa lingua. A volte alta, a volte bassa. Non si può omogeneizzare tutto in un’unica lingua idealizzata: è una montagna russa, si sale e si scende».
In realtà lei reinventa il dialetto. C’è la lezione di Scabia?
«Sicuramente. Amo molto “Nane Oca” che è per me fondante. Ma anche Meneghello, Zanzotto e Rigoni Stern per altri aspetti sono importanti per la mia scrittura. Fino ad arrivare ai colleghi che stimo e conosco bene, come Paolini e Balasso, che mi hanno insegnato la potenzialità narrativa del mio dialetto».
C’è anche il tentativo di capire come da una storia reale possa nascere un testo teatrale?
«Certamente. È affascinante pensare a che tipo di esperienza possa aver generato un racconto. È qualcosa che viviamo tutti: facciamo un’esperienza e poi troviamo il racconto che le si attaglia».
Will è protagonista ma ad agire è in realtà una banda di personaggi.
«Mi piacciono i racconti corali: una banda è spesso più interessante del singolo eroe. C’è anche un elemento di idealità: trovarsi insieme di fronte alle difficoltà. Sono felice di vedere che i personaggi crescono e che si possono innestare altri nel gruppo».
Vede le scene prima di scriverle o è la scrittura che gliele fa vedere?
«Bulgakov in “Romanzo teatrale”, uno dei miei libri preferiti suggerisce: “Vedi il teatrino davanti a te e scrivi quello che vedi”. E io faccio così». —
Riproduzione riservata © il Nord Est








