Analizzando la mente dell’assassino
Stefano Nazzi in “Predatori” ripercorre l’epoca dei cacciatori Fbi di serial killer. I casi che fecero più scalpore negli Usa, da Ted Bundy a John Wayne Gacy
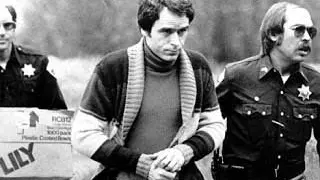
«Immaginate la savana. Ora pensate a un leone, fissatelo nella mente. Guardatelo mentre osserva un gruppo di zebre o di antilopi. Le prede sembrano tutte uguali. Eppure, il leone ne sceglie una. Percepisce qual è la più debole, la più fragile. Lo sente».
Non è affatto una lezione sul mondo animale, ma l’inizio del percorso di formazione per i giovani agenti dell’Fbi incaricati di dare la caccia ai serial killer. In cattedra i mindhunters John Douglas, Robert Ressler e Ann Burgess che, per primi, iniziarono ad analizzare i profili degli assassini seriali e poi a parlare con loro. Tra gli anni Sessanta e Novanta da quelle conversazioni nacque negli Stati Uniti il profiling: la catalogazione di centinaia di profili psicologici. Tra le pagine di “Predatori” (Mondadori, 2025), Stefano Nazzi ripercorre quell’epoca buia, accompagna i lettori nelle menti di alcuni dei più spietati assassini e di chi ha provato a fermarli.
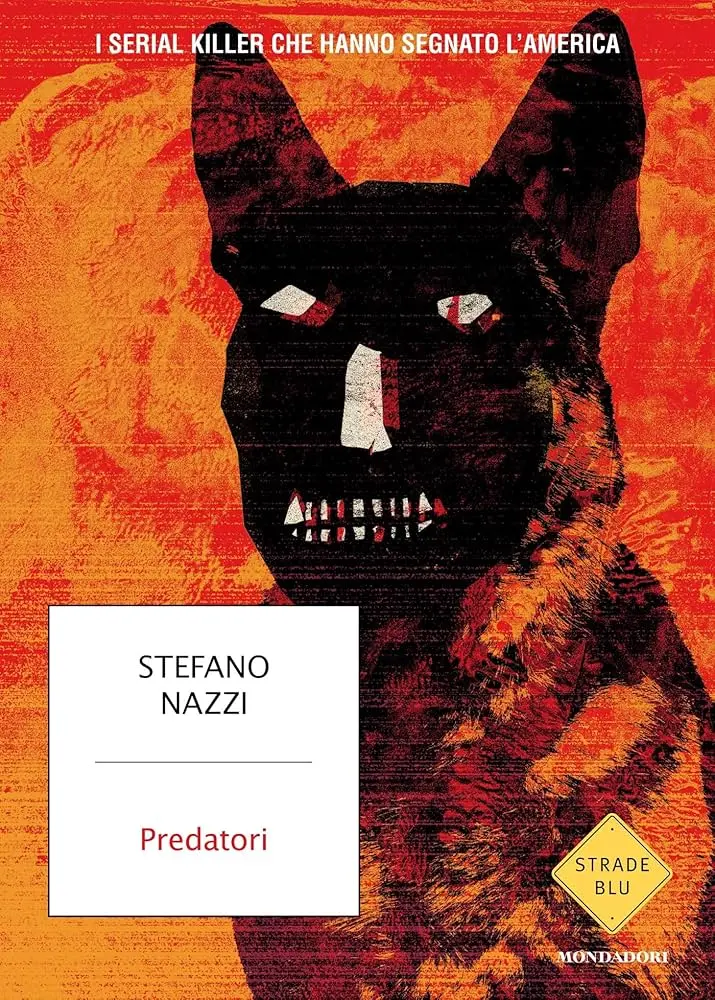
I mindhunters sono riusciti nel loro intento di prevedere l’imprevedibile?
«Hanno cercato di dare una forma a qualcosa che fino ad allora non era mai stato studiato a fondo. Hanno individuato elementi ricorrenti, connessioni nei comportamenti di queste persone, per riuscire —quando possibile — ad anticiparle».
Perché la cosiddetta “epidemia” dei serial killer si è diffusa proprio tra gli anni Settanta e Novanta?
«La società americana in quel periodo era attraversata da profondi conflitti sociali. Molti di quelli che poi sarebbero diventati serial killer erano figli di reduci di guerra. Alcuni raccontarono che i loro impulsi peggiori erano alimentati dalla diffusione massiccia della pornografia. E poi c’era la guerra del Vietnam: la violenza entrava ogni sera nelle case con il telegiornale».
Secondo i dati raccolti dal criminologo Ruben De Luca, il 57,9% dei tremila assassini seriali dell’epoca moderna sono americani. Come se lo spiega?
«È una società costruita sulla legge del più forte. Parliamo di un Paese in cui è semplice procurarsi armi e molti di questi killer le utilizzavano nei loro delitti».
Perché ha sentito il bisogno di tornare su queste storie?
«Le ho scelte perché rappresentano gli incubi più profondi degli americani, ma anche i nostri. Alcune erano molto note, altre meno, ma volevo raccontare i protagonisti di quel periodo che l’Fbi definì l’epidemia: 665 serial killer catalogati negli anni Settanta, 768 negli anni Ottanta, 669 negli anni Novanta».
C’è un caso che continua a tormentarla?
«Anche se è notissimo, quello di Ted Bundy. Sovvertì completamente l’idea che si aveva allora del serial killer come individuo isolato, tagliato fuori dalla società. Lui, invece, era bello, intelligente, rassicurante e ben inserito nel tessuto sociale. Fu lui stesso a dire, quando gli chiesero “Chi siete voi serial killer?”, “Siamo i vostri figli, siamo i vostri mariti, siamo dappertutto”. Aveva ucciso trentasei persone».
Dunque i serial killer di quel periodo hanno ribaltato l’immaginario comune?
«Assolutamente. Pensiamo a John Wayne Gacy: un imprenditore stimato, che si vestiva da clown per intrattenere i bambini alle feste, ed era richiestissimo dalle mamme. Eppure, era un assassino seriale: ha ucciso 33 adolescenti. Non a caso ha ispirato Stephen King per il suo killer clown nel romanzo “It”, simbolo assoluto della paura».
Perché i serial killer esercitano tanto fascino?
«Ci attraggono le storie che percepiamo più lontane da noi. Quelle che racconto io sono spesso incredibili per la crudeltà e per il numero delle persone uccise. Proviamo empatia per le vittime e sperimentiamo una sorta di paura controllata. Le viviamo da lontano, per questo ne siamo attratti».
Ha parlato di un «cortocircuito tra cronaca e fiction» nel modo in cui i media raccontano questi casi. Lei come fa a evitarlo?
«Cerco di attenermi ai fatti, a ciò che è verificabile. Evito aggettivi, giudizi, descrizioni superflue. Provo a guardare tutto con freddezza e distanza». —
Riproduzione riservata © il Nord Est








