Il gemello digitale cambia il nostro stare nel mondo
Roberto Masiero, storico dell’Architettura dell’IUAV, parla di come gestire una complessità che impone un riordino dei saperi e un innalzamento dei livelli di protezione degli asset digitali
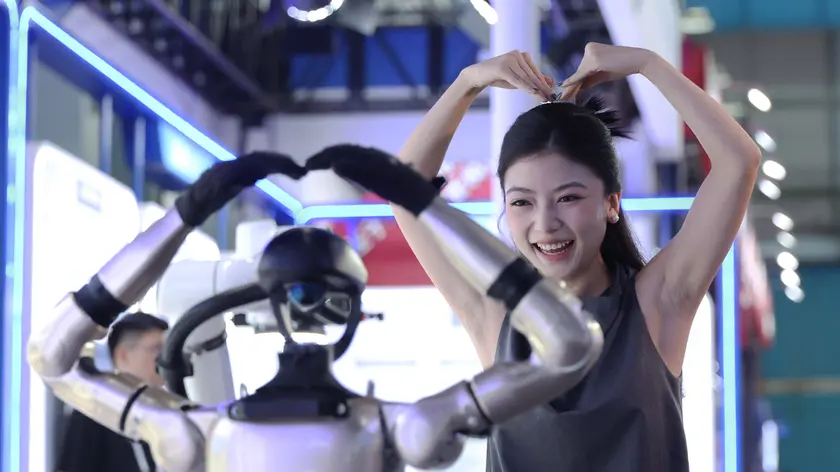
“Possiamo immaginare il gemello digitale come un simbionte, un quasi organismo, dotato di memoria, capacità di apprendere e valutare, che ci aiuta a decidere al meglio. Tutto con il digitale, prende la forma del dati che possono essere tra loro confrontati e addirittura essere resi interoperabili… In questo contesto il tema della sicurezza informatica è indubbiamente cruciale, ma non va affrontato, come accade fin troppo spesso, demonizzando il digitale e alimentando la paura di ciò che è nuovo…”.
Roberto Masiero, Storico dell’Architettura dell’IUAV, si sofferma sui molteplici fattori di trasformazione che impongono una corretta governance della complessità che impone un riordino dei saperi, e un innalzamento dei livelli di protezione degli asset digitali.
Professore, quando parliamo di gemello digitale cosa dobbiamo intendere?
Possiamo immaginare il gemello digitale come un simbionte, un quasi organismo, dotato di memoria, capacità di apprendere e valutare, che ci aiuta a decidere al meglio. Uso il termine simbionte per indicare il passaggio in atto con il digitale dal predominio della meccanica a quello della biotica. Immaginiamo la mappa di una città e tutto ciò che una città è: la vegetazione, le strade, i servizi, le abitazioni, i monumenti e i luoghi pubblici, gli abitanti, ognuno con le proprie caratteristiche (età, stato della salute e quant’altro), e perchè no? anche i turisti. E per non farci mancare nulla anche tutto il denaro che muove questa città, quello nelle banche come quello che rende vivo il mercato, o i saperi che in questa città si diffondono in vario modo ovunque, scolarità, mostre, iniziative culturali, musei. Ora tutto questo può, con il digitale, prendere la forma del dati che possono essere tra loro confrontati e addirittura essere resi interoperabili.
Siamo a un’ulteriore tappa della “mutazione” digitale che investe ogni ambito della società?
Certamente sì, soprattutto se consideriamo gli scenari di innovazione che si stanno aprendo. Il gemello digitale è l’insieme (pressoché infinito) dei dati su fenomeni materiali quanto immateriali raccolti come un processo continuo che possono riguardare tutto ciò che può accadere in un determinato contesto. Posso fare il gemello digitale di tutto ciò che accade in una scuola, in un territorio, in una fabbrica e l’elenco potrebbe continuare. L’insieme di questi dati e la loro elaborazione può permetterci di comprendere, controllare e governare i processi ed elaborare sistemi decisionali, verificandone nel tempo l’efficacia. Oggi siamo in grado di analizzare e valutare possibili decisioni in merito al rapporto tra dati ambientali e malattie distribuite variamente tra gli abitanti, o valutare i dati sulla scolarità e il rapporto tra le conoscenze acquisiate nel sistema scolastico rispetto all’organizzazione produttiva espressa dal territorio.
La governance dei territori si sta modificando. Il presente e il futuro delle città (di cui lei sei ampiamente occupato da architetto) stanno mutando mutano il loro profilo. Nel saggio (Il gemello digitale territoriale cfr. spazio recensioni di questo numero n.d.r) si parla di "spazio intermedio" e di una platmorfizzazione della società. Siamo oltre le categorie kantiane, a che cosa stiamo andando incontro?
La rivoluzione in atto è soprattutto di natura epistemica cioè riguarda il modo nel quale possiamo fare e decidere del nostro rapporto con il mondo. Dobbiamo cambiare modo di pensare. Dal punto di vista filosofico si dovrebbe ri-partire da questa semplice ma radicale affermazione: gli enti, materiali e immateriali, sono stati di relazione, quindi dovremmo ripensare proprio i “trascendentali kantiani” accettando la generale relativizzazione che ci viene oramai da più di un secolo proposta dalla fisica quantistica. Si tenga presente che non esiste una civiltà se non si dà una cosmogonia (vera o falsa che sia) e la civiltà del digitale ha come propria cosmogonia la quantistica. Se tutto è stato di relazione è assolutamente evidente che i rapporti sociali non possono che essere pensati, gestiti governati attraverso piattaforme digitali che rendono il tutto connesso e interoperabile.
I dati “nuovo petrolio” dell’era digitale
I dati sono il nuovo petrolio. Michele Mezza in una recente pubblicazione "Connessi a morte" ne parla diffusamente per esemplificare le conseguenze sul piano esistenziale e non solo produttivo che l'IA e gli algoritmi stanno generando. Malgrado questo il salto di qualità nella PA tarda a venire. Come si spiega questo ritardo, dati, persone e territori trovare una sintesi, sarebbe compito della politica?
E’ vero che i dati sono il nuovo petrolio, ma come il petrolio è l’esito di processi di raffinazione, così i dati hanno bisogno di elaborazione e interpretazione. Da anni molte regioni in Italia hanno provveduto a raccogliere in modo sistematico ad esempio i dati riguardanti la salute dei cittadini, ma il tutto si è risolto con un ulteriore processo di burocratizzazione e non certo con la trasformazione possibile con il digitale da una medicina universale a una medicina singolare, cioè un cambiamento sia nella diagnostica che nella terapeutica. Da anni nelle scuole dell’obbligo del nostro paese tutto, ripeto tutto, è digitalizzato ma la didattica è sempre la stessa di molti anni fa. Da anni tutte le fatturazioni e le transazioni finanziarie sono digitalizzate, eppure non riusciamo ad avere in questo settore cruciale trasparenza e controllo. Esiste un ritardo generalizzato del sistema paese che é di natura epistemologica e quindi anche culturale. Di tale ritardo la politica si alimenta, spesso perché è essa stessa parte di quel ritardo, ma sovente anche per semplice esercizio di cinismo.
Smart city, smart land, digital twin, sono tutti “orizzonti” del digitale. Quali sono le implicazioni sul piano della sicurezza informatica di questi “nuovi piani di realtà” con cui ci misuriamo ogni giorno?
Il tema della sicurezza informatica è indubbiamente cruciale, ma non va affrontato, come accade fin troppo spesso, demonizzando il digitale e alimentando la paura di ciò che è nuovo. Una paura che nasce perchè ci costringe a cambiare in maniera profonda il nostro stesso modo di pensare e questo è indubbiamente profondamente inquietante sino ad apparire demoniaco. Mi permetto di fare sulla questione della sicurezza una considerazione: il digitale nel suo insieme è predisposto e predisponibile per auto correggersi; può produrre i propri anticorpi visto che nelle sue configurazioni attuali procede anche in costante feedback ed è animato sistemi di machine learning.
Tutto è cyber security
Tutto sembra esser cyber security, la connettività è divenuta logistica militare, come la guerra che ha un codice ibrido, per nulla convenzionale. Algoritmi e automazione dei processi hanno dato forma a un potere computazionale. Finita l'era dei contenuti tayloristici, si assiste a una riorganizzazione antropologica. Le imprese in questo stravolgimento non solo organizzativo, ma culturale di quali strumenti devono dotarsi per reggere la sfida della competitività?
La risposta a questa domanda pretenderebbe una analisi attenta e molto articolata del sistema produttivo italiano non solo in chiave economica ma soprattutto culturale. Quello che per l’industria dovrebbe essere fondamentale è comprendere che il modo di produzione digitale (che integra quello industriale, avendo però logiche di produzione di valori sia economici che di sistema completamente diversi) é fondamentalmente disruptive e quindi è necessario cambiare completamente i modi e le forme della programmazione, dell’organizzazione e del marketing. Un grande cambiamento di visone delle cose del mondo che non viene assolutamente non dico alimentato ma nemmeno immaginato dai sistemi formativi tradizionali. Inoltre il digitale tende (a differenza di quello industriale) a ridurre al minimo le distanze tra teoria e prassi, cioè tra pensiero e decisione e si sa quanto importante sia la decisione nell’azione produttiva.
Per i manager una sfida non da poco, non crede?
Per esemplificare la figura del manager dovrebbe essere scelta non in base alla sua capacità di prevedere il possibile, ma valutando la sua capacità di rispondere all’inaspettato. Inoltre in questo contesto cambia l’idea tradizionale sia di innovazione che di sviluppo. La questione fondamentale per capire e agire nel digitale è che si alimenta costantemente non tanto di dati, quanto di saperi che rielaborano i dati. Per queste ragioni il mondo della imprenditoria dovrebbe chiedere alla politica una radicale trasformazione dell’intero sistema scolastico purtroppo ancora strutturato secondo logiche funzionali al modo di produzione industriale (separazione teoria/prassi, organizzazione gerarchica di saperi divisi, con una ragione sottesa: la divisone sociale del lavoro e dei suoi conflitti, etc, etc, etc.). Con il digitale è pensabile un continuo, aperto, diffuso, fluido trasferimento dei saperi verso una intelligenza e creatività collettiva. Questo serve ad un assetto industriale inteso come processo sociale di emancipazione collettiva
“Etica il nome nuovo da dare al pensiero”, come sostiene Edgar Morin in numerosi scritti recenti. Di "Algoretica" parla con insistenza padre Benanti, c’è anche tutta una saggistica, penso agli scritti di Luciano Floridi che si stanno occupando di questo tema. Qual è la sua idea in merito?
Siamo già nella connessione tra intelligenza biologica e intelligenza digitale e sappiamo con certezza che quest’ultima è estremamente più potente di quella biologica che ci caratterizza in quanto specie. L’intelligenza artificiale non prova tremore e timore per ciò che sta pensando; non si stanca mai di pensare, accumulare dati e mettere in relazione informazioni e concetti e ha una memoria pressoché illimitata, mentre la nostra è selettiva. Il conflitto tra le due intelligenze è indubbiamente il pericolo. Ma come dice il poeta “ … solo nel pericolo ci si salva” (Holderlin).
La questione etica è quindi la seguente: l’intelligenza biologica deve adattarsi a quella digitale o viceversa? Se non vogliamo o non possiamo diventare più simili all’intelligenza artificiale dobbiamo trovare il modo per renderla più simile a noi. Questo è comunque il nostro compito etico: ripensare la nostra stessa umanità
Riproduzione riservata © il Nord Est








