Falsi obiettivi, giudici a sorteggio: la riforma Nordio stride con la Costituzione
Sbagliato ricondurre tutto alla separazione delle carriere. Qui si ripudia ogni valutazione di merito e di idoneità, svilendo la funzione degli organi. Parlamento svuotato delle sue prerogative
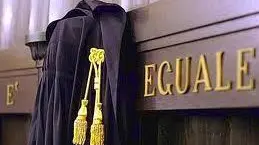
Negli scorsi giorni si è concluso il cammino parlamentare della legge di modifica della Costituzione che, in maniera troppo semplicistica, è stata chiamata di “separazione delle carriere” tra i magistrati del pubblico ministero e quelli giudicanti.
Non essendo stato raggiunto il quorum dei due terzi dei parlamentari favorevoli, la riforma sarà sottoposta al giudizio degli elettori attraverso un referendum, come previsto dall’articolo 138 della Carta fondamentale.
La riforma, presentata come necessaria per dare efficienza alla giustizia e per ottenere la parità delle parti nel processo penale, contiene tecnicismi di non semplice lettura per coloro che pure avranno il delicato compito di deciderne l’esito. D’altra parte, gli interventi a cui finora abbiamo assistito non hanno certo contribuito a un sereno dibattito sulle modifiche introdotte perché caratterizzati da contrapposizioni partigiane prive del reciproco rispetto e poco sensibili alla necessità di spiegare il contenuto della riforma che, comunque, modifica i rapporti tra poteri dello Stato.
Il testo è stato approvato senza alcuna discussione, con una sostanziale sterilizzazione dell’apporto del dibattito parlamentare certamente criticabile, tanto più per una riforma costituzionale e di provenienza governativa, perché svilisce il ruolo del Parlamento e dei singoli parlamentari.
Una attenta valutazione delle novità introdotte deve necessariamente considerare da un lato il diritto del potere legislativo a modificare gli assetti organizzativi della magistratura, dall’altro i limiti di tale potere che, come insegna la Corte costituzionale (sentenza n. 114/1988) deve comunque rispettare i principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure con il procedimento aggravato di revisione. Tra questi sicuramente si trova il principio della separazione dei poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) la cui reciproca indipendenza costituisce il fondamento di ogni democrazia liberale.

Come si è accennato, infatti, definire la riforma come “separazione delle carriere” non coglie la profondità dell’intervento legislativo che modifica profondamente l’assetto ordinamentale della magistratura.
La separazione delle carriere tra magistrati del pubblico ministero e magistrati giudicanti è stata già effettuata dal decreto legislativo n. 106/2006 e dalla successiva legge n. 71 del 2022 (cosiddetta legge Cartabia) che ha previsto che il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa possa essere effettuato una sola volta nel corso della carriera, entro nove anni dalla prima assegnazione delle funzioni. In tal modo si è creata una divaricazione pressoché totale dei percorsi professionali di giudici e pubblici ministeri confermata dalla circostanza che negli ultimi cinque anni il passaggio da una carriera all’altra è stato ampiamente inferiore all’uno per cento.
Il vero nucleo della riforma è, invece, la previsione di due Consigli superiori, uno per i magistrati del pubblico ministero e uno per i magistrati giudicanti, con una stringente limitazione delle competenze istituzionali dei nuovi organi che verranno non più eletti, ma sorteggiati.
Questo “innovativo” criterio di individuazione dei componenti dei due Consigli, come è stato autorevolmente evidenziato, risulta in contrasto con il principio per cui «la regola dell’elettività delle cariche pubbliche costituisce un principio supremo dell’ordinamento costituzionale, cioè un fattore identitario della nostra Repubblica» non modificabile neppure con il procedimento di cui all’art. 138. Si pone anche in contrasto con le regole europee, per le quali almeno la metà dei membri dei Consigli di giustizia dovrebbero essere magistrati scelti dai loro pari e con garanzia di pluralismo interno all’ordine giudiziario (Raccomandazione CM/Rec (2010)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, art. 27).
Il contrasto tra la scelta del sorteggio con il concetto di «scelti» e «con garanzia del pluralismo» è stato ampiamente segnalato nella Relazione sullo stato di diritto nella Ue della Commissione europea del 2024. Risulta del resto del tutto evidente che il sorteggio comporta un radicale ripudio di ogni valutazione di merito nei confronti di persone che sono chiamate a svolgere importanti e delicate funzioni.
Se certo l’elezione dei membri del Csm da parte dei magistrati non ha alcuna finalità rappresentativa, è altrettanto evidente che il sorteggio non consente alcuna valutazione dell’idoneità al ruolo, senza che peraltro venga meno l’altro obiettivo che viene affermato e cioè l’eliminazione delle “correnti”. Le aggregazioni all’interno di un numero elevato di magistrati continueranno di certo a esistere con il rischio, semmai, di eliminare ogni dialettica di idee e di conseguenti proposte organizzative, con svilimento della stessa funzione dei Consigli e del ruolo del Presidente della Repubblica che li presiede, ridotti a meri organi burocratici con sostanziale trasformazione del rapporto tra poteri dello Stato di dubbia costituzionalità.
Anche la creazione di un’Alta Corte di giustizia per i giudizi disciplinari suggerisce dubbi di legittimità in quanto in contrasto con l’art. 102 della Costituzione che vieta la creazione di giudici speciali, principio cardine dello stato di diritto. La circostanza che sia prevista per la sola magistratura ordinaria e non anche per le altre magistrature amministrative (Tar, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Corti tributarie) come pure era stato anche proposto, potrebbe fare pensare a intenti punitivi.
La riforma, come pure evidenziato da numerosi studiosi e avvocati, non conseguirà neppure l’obiettivo dichiarato di porre pubblico ministero e difesa su un piano di parità di fronte al giudice, rischiando invece di creare, per eterogenesi dei fini, una corporazione di pubblici ministeri che dentro e fuori del processo abbia poteri ben più ampi di quelli che una parte privata, come l’avvocato, inevitabilmente, anche in sistemi processuali diversi dal nostro, sia concretamente in grado di esercitare.
Fuori dai facili slogan, la parità delle armi tra accusa e difesa non dipende dalla distinzione delle carriere dei magistrati, ma da un rafforzamento del ruolo e della figura del difensore e dalle garanzie processuali previste per le parti. Peraltro, è facile accertare come, già ora, l’analisi dell’attività dei giudici dimostra che non vi sia alcun appiattimento sulle richieste dei pubblici ministeri, come provato dalla quantità di decisioni prese, durante le indagini preliminari e in dibattimento, diverse dalle richieste della procura in termini di rigetto di misure cautelari, di diverse valutazioni sulle richieste di archiviazione e delle sentenze di proscioglimento e di assoluzione rispetto alle richieste di condanna.
Se poi davvero l’autonomia valutativa dei giudici dipendesse dal percorso unitario delle carriere, perché mai non separare le carriere dei giudici di primo grado da quelli d’appello e di cassazione, che fisiologicamente annullano o confermano le sentenze pronunciate nei precedenti gradi di giudizio.
A fronte delle frizioni con i principi costituzionali, la riforma risulta inefficace a raggiungere gli obiettivi, almeno quelli dichiarati, e non tocca minimamente gli inaccettabili tempi della giustizia e l’inefficienza dei sistemi processuali.
L’auspicio è che il corpo elettorale possa valutare compiutamente la riforma per quello che davvero prevede al di là dei proclami e, all’esito di un sereno dibattito che eviti contrapposizioni urlate, ne decida la legittimità rispetto ai principi di democrazia liberale e la reale efficacia nella quotidianità della giustizia. —
Riproduzione riservata © il Nord Est



