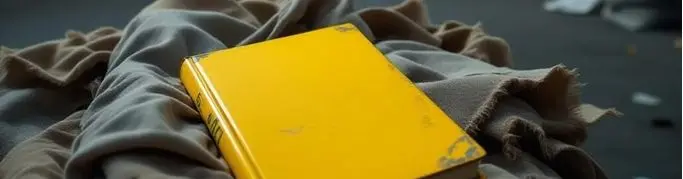Una volée in tuffo di Panatta quel giorno a Wimbledon
Giugno 1979, vacanza studio in Inghilterra, una Kodak con rullino da 16 pose. Entro a sorpresa e arriva uno scatto speciale. Su una clamorosa volée di Panatta
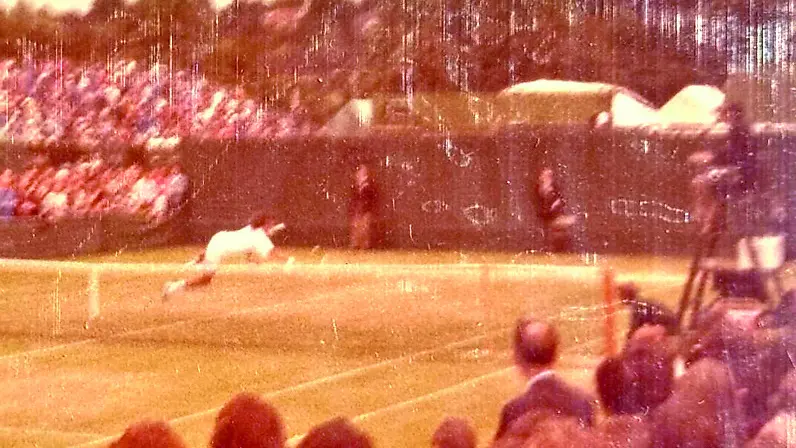
Era il giugno 1979, quarta superiore, vacanza studio in Inghilterra, a Brighton, neanche un’ora di treno da Londra. Lezione la mattina, pomeriggi liberi, e campi da tennis gratuiti nei parchi, una meraviglia per me e Enrico, il mio compagno di banco, ore e ore di dritti e rovesci, oltre a un’esperienza fallimentare su un campo in erba, un quarto d’ora di tentativi di colpire la pallina che rimbalzava veloce e bassissima, imprendibile per due imbranati come noi, meglio tornare al cemento, che all’epoca era asfalto, più o meno. Ed erano anche i giorni di Wimbledon, l’edizione in cui Adriano Panatta ha perso l’occasione della vita.
Lo avevo detto subito, già all’aeroporto, alla prof che ci accompagnava. Io un giro a Wimbledon me lo sarei fatto, anche se sapevo che i biglietti o li compravi un anno prima oppure dovevi farti ore e ore, giornate intere, addirittura, di coda. Lei non era d’accordo, ma io, per via di una bocciatura – meritata – un paio di anni prima, ero già maggiorenne, ero stato promosso, e i miei li avevo convinti, con mio papà giocavo a tennis la domenica mattina. Con Enrico invece non c’è stato niente da fare. Inutile, diceva, andare fin lì e non poter entrare. Porto con me la mia sgangherata Kodak Pocket Instamatic. Dentro, un rullino da 16 pose, qualità indefinibile.
La mattina del 29 giugno, sveglia all’alba, Daily Mirror in edicola e tensione e emozione tali che dimentico il portafoglio sul banco e la signora mi rincorre agitandolo in aria. Non ricordo niente del viaggio in treno e poi in metropolitana, ma benissimo invece la coda, che incomincia poco dopo l’uscita. Convinto che non sarei mai riuscito ad entrare al The All England Lawn Tennis and Croquet Club, spreco ben due scatti per fotografare la coda e un altro per un pezzo del perimetro verde che circonda il club. Mi sarebbe bastato questo per raccontare a tutti che c’ero stato, io, quel giorno, a Wimbledon. Sarei rientrato a Brighton presto, non fosse stato per quel tizio in impermeabile che, mentre risalivo la coda, mi si para davanti e mi chiede se ho bisogno di un biglietto, mette mano alla tasca interna dell’impermeabile e tira fuori un biglietto verde, in cartoncino. Accesso a tutti i campi, mi dice. Centrale compreso. How much?, chiedo. Cinque sterline, che Google, oggi, mi dice fossero circa novemila lire di allora. Venti, forse trenta euro attuali.
Ero a Brighton da due settimane e avevo risparmiato su tutto per arrivare a questa giornata con un bel gruzzolo. Tiro fuori le cinque sterline dal portafoglio, il tizio si guarda intorno, le prende e mi allunga il prezioso cimelio. Già, perché pur pensando subito di essere stato fregato, quello sembrava un vero biglietto, nonostante quella strana scritta in rosso che, obliqua, lo attraversava per intero, “Complementary”, e non avevo la minima idea di cosa significasse; qualcosa di falso, ne ero certo. Significava omaggio, invece. Mi aveva indicato da dove sarei dovuto entrare e un’ora prima dell’apertura dei cancelli ero là davanti, primo della fila degli aventi diritto all’entrata nel tempio assoluto del tennis mondiale e scatto la quarta foto a quelli in fila dopo di me. Alle 12 in punto, un tizio in divisa apre e io, con le gambe che fanno giacomo giacomo, gli allungo il biglietto chiudendo gli occhi, sento lo strap della contromarca e sì, sono dentro. A Wimbledon. Il programma del giorno costa una sterlina, è un libro, e so già che lo conserverò per sempre. Entro al Centrale. Prima fila dello stand. Quello dei poveri, certo, ma vuoi mettere. A pochi metri da me – altro clic – James Hunt, campione del mondo di Formula 1 tre anni prima. È il giorno degli ottavi di finale e, come al solito, sono gli incontri femminili a aprire il programma. Vedo tutta la partita vittoriosa di Billie Jean King contro Hana Mandlikova, poi un set fra Marc Cox e Jimmy Connors (un paio di scatti per lui, nel primo mette il manico della sua Wilson T2000 in metallo sotto al rubinetto del distributore di Coca cola, appeso sul retro della sedia dell’arbitro, immagino lo facesse per migliorare con l’appiccicaticcio la presa della racchetta. Sì, bevevano anche Coca cola al cambio di campo, a quell’epoca) e quando sento il coro “Adriano, Adriano” arrivare dal campo numero 3, mi avvio. Adriano Panatta stava incominciando, contro lo statunitense Sandy Mayer, la più bella partita da lui mai giocata sull’erba di Wimbledon. Trovo un posto comodo sulla piccola tribuna, accanto alla sedia dove il nostro campione ha sistemato le sue racchette, le gloriose Wip Panatta, prodotte a Bassano del Grappa. Ma non dura molto.
Gli ultimi due set mi è toccato vederli dal terrazzo esterno del Campo centrale. Dopo una splendida volée di rovescio in tuffo di Panatta – che sono riuscito a fotografare – il mio vicino, uno studente romano, ha gioito a tal punto che sono stato cortesemente trascinato fuori dal campo da un solerte signore in divisa sbucato dal nulla. Non faccio discussioni, e lo seguo. Da lassù, con il catorcio che avevo a disposizione, ho continuato a fotografare colui che nelle foto si intuisce essere Panatta. Anche una sua proverbiale veronica. Che fatica, due giorni dopo, insieme a Enrico, convincere la famiglia che ci ospitava di lasciarci a disposizione salotto e tv per il quarto di finale che Adriano Panatta perse contro lo scarso Pat Dupré. Viveva davanti alla tv, la famiglia Watson: ho dovuto addirittura inventare una lontana parentela fra me e Panatta per fargli dire di sì. Che sofferenza, quella partita. Avrebbe proprio potuto vincerlo Wimbledon, quell’anno, Adriano Panatta, lui, che Borg – quell’anno al quarto titolo consecutivo – lo batteva spesso.
Poco dopo, sono lì, piazzato giusto alla convergenza fra il North stand e l’East stand del campo numero 1. Non era facile inquadrare con la Kodak entrambi i giocatori, e i tre scatti che mi sono rimasti li consumo le soltanto quando Björn Borg ha il turno di due giochi sul lato sud del campo. Soltanto in uno si riesce a vedere anche Brian Teacher sceso a rete dopo il servizio mentre Borg risponde con un rovescio a due mani.
L’ultima foto l’ho riservata al servizio che immaginavo essere quello del punto conclusivo. Ho visto Borg dentro al mirino avvicinarsi al centro della linea di fondocampo, battere la pallina con la racchetta per tre volte sull’erba, fermarsi avanzando di poco il piede sinistro rispetto al destro, far rimbalzare una volta la pallina con la mano e guardare di là solo un attimo prima di incominciare il movimento. Game, set and match, e mica lo sapevo, quel giorno, che Borg sarebbe diventato, anni dopo, un personaggio del mio primo romanzo, Terra rossa.
Sono uscito dal tempio con la consapevolezza di avere vissuto una giornata speciale, rassegnato, nei decenni successivi, all’idea che mai un italiano avrebbe vinto a Wimbledon. Ecco, immaginate adesso cosa possa avere provato, il 13 luglio di quest’anno, il ragazzo di quel giorno. Quali e quante emozioni, inaudite, davanti al trionfo di quel fenomeno di Jannik Sinner.
L’autore

Roberto Ferrucci è nato a Venezia (Marghera) nel 1960. Ha esordito nel 1993 con Terra rossa (Transeuropa). Nel 2007 Marsilio pubblica Cosa cambia, rieditato nel 2021 da People con prefazione di Antonio Tabucchi. Nel 2022 pubblica il memoir Storie che accadono (People), incentrato sulla figura di Tabucchi, libro che con Il mondo che ha fatto (2025, La nave di Teseo), memoir su Daniele Del Giudice, forma un dittico; Claudio Magris ha voluto candidarlo al Premio Strega. Scrive per i quotidiani NEM e su La Lettura del Corriere della Sera. Dal 2002 insegna Scrittura creativa alla facoltà di Lettere dell’Università di Padova, Conduce laboratori di scrittura in Italia e Francia.
Riproduzione riservata © il Nord Est