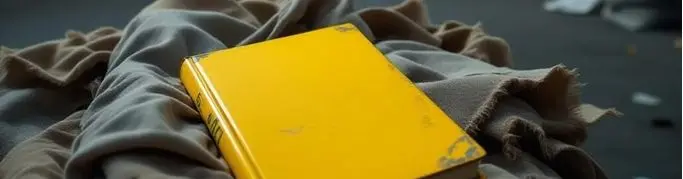Fiori al confine onde di memoria e respiri di libertà
Germania: sul margine della vecchia Cortina di Ferro, due donne si incontrano. Tra storie divise e cieli limpidi, la natura ricuce ciò che l’uomo separò

Un alito di vento muove macchie di fiori gialli, le loro corolle sembrano i colletti di tanti invisibili coristi che si muovono all'unisono per seguire l'onda di un canto. Sono cresciuti ai margini delle lastre in cemento che formavano la strada di servizio dove transitavano i mezzi militari della DDR per il controllo del confine. Accanto ecco i cippi confinari con lo stemma sbiadito del “compasso e martello” e brandelli di recinzione “armata”, testimonianze muti della divisione. Un passato da incubo che qui tutti vorrebbero rimuovere. Un colpo di brezza più forte degli altri agita i fiori, sullo sfondo di un cielo plumbeo che vena di inquietudine un orizzonte da cartolina.
Strano questo tardo pomeriggio di un'incipiente estate, a Geisa: si sa, al Nord, la bella stagione stenta a manifestarsi. Ma oggi qui, sul confine di Punto Alfa, sotto un cielo che di notte è fra i più puliti del mondo - quello del Parco della Rhön, meta di astrofili di ogni dove - è fissato un incontro.
Eccole arrivare le due donne: Monika si avvicina a piedi, è nata a Ovest e da piccola a scuola, oltre al tedesco, ha studiato l'inglese: «Piacere di conoscerti!». Brigitte, che aspettava al Centro Visite, è nata a Est e alle elementari ha imparato il russo ea scrivere in cirillico: “Spasiba”, ovvero “Grazie”. Ma entrambe dicono “Danke”, nella loro lingua.
Destini diversi, segnati fin dalla nascita, 70 anni fa, da quel confine fra genti uguali che col tempo per le due bambine, originarie di due paesini vicini (uno in Assia vicino a Rasdorf e l'altro in Turingia, nei pressi di Geisa), è diventato una barriera, un crocevia di vita, lo spartiacque fra due mondi, anche psicologici, lontanissimi fra loro. L'alito di vento si fa più forte: che sia uno spiffero della Guerra Fredda?
«Piacere, Monika»… «Piacere, Brigitte». «Siamo nate qui, ma non ci siamo mai viste prima…». Convenevoli per rompere il ghiaccio e quel po' di imbarazzo: la curiosità è tanta. Stretta di mano in un ambiente surreale, laddove fino al 9 novembre 1989 correva la Cortina di Ferro, all'ombra di una delle torri di guardia dove i Vopos, le temute guardie di frontiera della Repubblica Democratica Tedesca, controllavano in modo ossessivo il confine.
Guardie disposte anche a sparare, perché qui i tentativi di fuga dall'Est non cessarono mai. Alcuni finiscono in modo tragico, come documenta il vicino Museo di Punto Alfa, che ribadisce l'assurdità di tutti i “muri” del mondo. Un incontro inatteso quello fra le due donne, nell'ex campo militare americano, intorno al tavolino all'aperto di un bar chiuso. Lo stesso dove un tempo muscolosi ragazzotti in divisa verde mandati fin qui dalle periferie urbane degli States, ingannavano il tempo fra birre e hamburger in perenne attesa, come il tenente Drogo del “Deserto dei Tartari”, di un nemico che non sarebbe mai arrivato.
Il confine è il convitato di pietra di questo inatteso incontro fra due ragazze, non ancora del tutto sfiorite, figlie del tormentato dopoguerra tedesco: il confine non c'è più, ma qui ne rimangono i fantasmi. Quando Monika e Brigitte erano piccole, la linea che separava le due Germanie era nel bosco e chi voleva violarla con un po' di fortuna poteva ancora farcela.
Poi nell'estate del 1961 all'improvviso si spense la luce. Anche qui, come a Berlino, dove il 13 agosto iniziò la costruzione del Muro, apparvero i primi reticolati, poi le alte reti a maglie taglienti, poi le mie, la doppia recinzione elettrificata, i dispositivi di sparo automatici comandati da sensibilissime fotocellule, i valli anticarro. Confrontare persino i cani dall'infallibile fiuto anti fuggiasco. «Fino al 1961- ricorda Brigitte - famiglie intere passavano di là. Poi le mie ei cartelli “Pericolo di morte” seminavano la paura. Tentava di scappare solo qualche giovane».
«Potevamo spingerci fino a 500 metri, poi l'alt», ricorda Monika. Lei ha parenti a Est, Brigitte a Ovest. Non potranno più incontrarli. Brigitte mostra i passaporti della DDR che negli ultimi anni della divisione fra le due Germanie (quelli dell'Ost Politik con cui il cancelliere Brandt ammorbidì il collega Honecker) conobbero l'inchiostro “amico” dei visti, seppur rilasciati col contagocce. La malattia di un familiare dall'altra parte diventava, per assurdo, una benedizione, perché valeva il permesso di una visita. «Ecco l'ultimo visto - indica Brigitte ma non è mai servito: il Muro cadde prima».
Siamo nel cuore dell'Europa, dove la natura ha vinto, da terzo incomodo, fra le tensioni alimentate dagli uomini. Lungo i 1393 km dell'ex confine fra le due Germanie ora c'è la Green Belt, una cintura verde diventata rifugio di biodiversità: piante cresciute spontaneamente e uccelli rari come l'averla cinerina. Qui oggi si intrecciano tanti sentieri verdi, all'insegna dell'amicizia tra i popoli.
La Turingia, regione dell'Est, è una delle culle del pensiero europeo. Qui l'ideale unitario maturò prima che altrove, profetizzato in secoli diversi da Martin Lutero con la sua Riforma – che rivelò a Wittemberg nel 1517, dopo la laurea a Erfurt e rifugiandosi poi, scomunicato dal Papa, nella fortezza Wartburg di Eisenach - , da Bach con la sua musica barocca il secolo dopo e soprattutto da Goethe, a fine '700, quando arrivò a Weimar, alla corte illuminata di Carlo Augusto che stava trasformando una città di provincia in un centro culturale di prima grandezza, tanto da diventare 150 anni dopo, nel 1920, capitale della prima Germania democratica.
Weimar dove Walter Gropius dette vita all'alta scuola della Bauhaus che innovò il '900 in tutto: arte, artigianato, design, architettura, idee. Goethe contribuisce con l'ampiezza del suo pensiero, la sua opera letteraria, i suoi incarichi politici ei suoi viaggi verso orizzonti europei (memorabile il suo “Italienische Reise”) ad avvicinare il continente.
Ha dell'incredibile una lettera conservata nel Goethe - Archivio Schiller di Weimar: la scrisse il 16 gennaio 1802 un ancor giovane Ugo Foscolo. Chiedeva con garbo a Goethe, poeta già affermato ea cui si era ispirato proprio per quell'opera, di potergli inviare il manoscritto del suo romanzo epistolare “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, semplicemente per una valutazione… Goethe non gli rispose mai, ma la sua nuora Ottilie anni dopo trovò la missiva e la conservò gelosamente.
Perché anche il Foscolo nel frattempo era diventato famoso e come Goethe credeva nella libertà. Un valore che anche dall'incontro al confine fra Brigitte, nata a Est, e Monika, nata a Ovest, affiora con la purezza dell'acqua di sorgente. La stessa che “nutre” quelle macchie di fiori gialli sull'ex confine accarezzate la sera dal vento d'estate, le cui corolle ondeggiano come un coro che Inneggia alla natura ea un futuro senza più spifferi gelidi...
Riproduzione riservata © il Nord Est