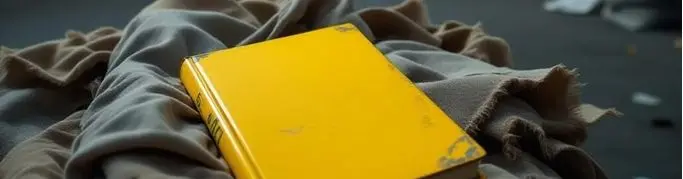Vita, dipinti e amori della dama dal cappello rosso
Sono quella che non passa inosservata, nel museo Revoltella di Trieste. Ho sempre precorso i tempi. E non è stato facile essere capita

Sì, sono quella che non passa inosservata nel museo di Trieste, la città della mia gioventù. Mi chiamo Leonora Fini, per tutti Leonor o Lolò. Sono nata a Buenos Aires nel 19…, non svelerò l’anno. In fondo, che importanza ha. Ho sempre vissuto nel presente.
Imparai a leggere e a disegnare molto presto. Fin da bambina adoravo le matite colorate, ne avevo tante, perché mia madre, Malvina Braun, era orgogliosa del mio talento.
Sono cresciuta a Trieste in un mondo di adulti: mia madre, mia nonna e mio zio Ernesto Braun, uomo austero, avvocato e appassionato di libri. Nella sua libreria mi sono formata più che a scuola, dove andare a lezione mi pesava.
Se penso alla casa della mia fanciullezza rivedo vasi di Gallé, libri ovunque e nelle stanze un profumo di mele cotogne e cannella.
Mio padre non l’ho mai conosciuto ma, dai racconti di mia madre, triestina dalla cultura mitteleuropea, seppi che era un uomo all’antica, retrogrado e lei ben presto, con me di appena diciotto mesi, lasciò l’Argentina per non farvi più ritorno. Mi è stato riferito che durante la mia infanzia Herminio Fini tentò più volte di rapirmi per riportarmi a Buenos Aires, ma non gli riuscì. Mia madre mi nascose, si allontanò da Trieste e alla fine si risolse a vestirmi da bambino per celare la mia vera identità. Forse iniziò allora la mia passione per i travestimenti, i costumi, le stoffe, le maschere…
I miei dipinti sono una misteriosa autobiografia. Per chi sa osservarli. Smascherano mondi arcani e a volte sono proiezioni nel futuro. Questo è capitato col mio amico Kot, Constantin Jelenski, scrittore polacco. Ci siamo incontrati a Roma nel 1952 e io gli dissi che l’avevo già ritratto in un quadro dipinto poco prima. Quando lui vide l’opera rimase sconvolto. Da allora non ci siamo più lasciati, fino al 1987 quando morì. Che tristezza, mi manca ancora!
***
Ma andiamo per ordine: ho già detto che andare a scuola non mi piaceva, mi annoiavo, mi divertivo solo quando insieme alle compagne riuscivo ad architettare e mettere in atto birichinate e stravaganze, tant’è che mi sospesero per ben tre volte.
Un’altra delle mie stranezze da ragazzina era che mi piaceva andare all’obitorio a osservare i morti, divenni amica del custode e lì vidi per la prima volta un giovane uomo nudo, ne rimasi colpita. In seguito, mi interessarono anche le ossa e gli scheletri come nell’Angelo dell’anatomia che dipinsi nel 1949. Reminiscenze delle passioni della mia adolescenza. Per un certo periodo seguii le lezioni del pittore triestino Edmondo Passauro e mi impratichii nell’eseguire figure e ritratti. Feci un Doppio autoritratto. Lolò da giovane e da vecchia. Ancora una volta il futuro che visitava il mio presente. Ma a darmi notorietà furono il Ritratto del giudice Alberti, la Vecchia signora e il Ritratto di Italo Svevo. Mi inserii con facilità nell’ambiente artistico locale, divenni amica di Arturo Nathan e di Carlo Sbisà, con loro esposi in una galleria milanese.
***
Vivere a Trieste mi piaceva, frequentavo Bobi Bazlen, Gillo Dorfles, Leo Castelli, Italo Svevo ed ero di casa da Umberto Saba. Non mi annoiavo. Ma il richiamo della grande città era più forte, così mi trasferii per alcuni anni nella capitale lombarda e conobbi i pittori Funi, Sironi, Carrà, De Chirico, allora già affermati. Alcuni mi piacevano altri no, perché non credevano nel talento artistico delle donne. Loro facevano parte della corrente Novecento. Milano era in fermento, ma non mi lasciai incantare dai proclami e manifesti. Ho sempre scelto la libertà piuttosto dell’appartenenza a un gruppo, non ho mai voluto essere etichettata. La pittura è per me un atto creativo individuale.
Tuttavia Milano ancora non mi bastava, sognavo Parigi. Ci andai. Iniziai a frequentare il gruppo dei surrealisti, le mie stranezze li colpirono. Un giorno ebbi l’ardire di presentarmi in un caffè vestita con calze da cardinale, comprate a Roma in un negozio di paramenti ecclesiastici. Mi piaceva il rosso e loro trovarono la mia performance molto surreale.
Adoro vestirmi in costume, trovo che l’atto in sé amplifichi la personalità del mascherato. Ma soprattutto amo l’ingresso tra il pubblico, quando il mio travestimento genera sorpresa, stupore.
***
Non volli far parte dei surrealisti: eccessive leggi e divieti. Breton era autoritario e misogino (mi legai a Ernst, Eluard e pochi altri). Non mi sono mai piaciute le persone troppo maschili o troppo femminili. Penso che se tutti fossero più liberi sceglierebbero di essere androgini. Nei miei quadri ne ho dipinti diversi.
Dopo varie mostre a Parigi, fui invitata a esporre a New York insieme a Max Ernst e realizzai per la stilista Schiaparelli una boccetta a forma di busto per il suo profumo “Shocking”, ispirata all’attrice Mae West. La mia fama aumentava. Di pari passo la mia vita sentimentale continuava frenetica con diversi incontri e amori. Allo scoppio della guerra mi sposai con Federico Veneziani più per proteggerlo, visto che era ebreo. Ma la nostra unione non durò a lungo. A Montecarlo, dove ci eravamo rifugiati per sfuggire all’occupazione tedesca della Francia, incontrai il console italiano Stanislao Lepri, con lui iniziai la relazione più importante e duratura della mia vita, si concluse solo con la sua morte, avvenuta nel 1980. Ricordarlo mi addolora. E nel 1952 venne a vivere con noi anche Kot. Eravamo una famiglia molto affiatata e allargata.
Nel 1951, a Venezia ci fu un grandioso ballo in maschera a Palazzo Labia. Mi presentai travestita da Angelo nero; il grande fotografo Ostier mi immortalò in tutto il mio fascino e mistero di femme fatale. Ma l’Italia del dopoguerra non gradì questi sfarzi e da allora la stampa italiana mi fu piuttosto ostile, mescolando la mia arte con le mie scelte esistenziali fuori dagli schemi, impensabili per la cultura bacchettona del tempo.
***
Non è stato facile essere capita. Forse ho sempre precorso i tempi. Oggi molti si sorprenderanno della mia arte così contemporanea e indissolubilmente legata alla mia vita: libera, oscura, trasgressiva, inquietante, misteriosa…
Sono io stessa un’opera d’arte. O forse sono un’attrice nata: un angelo o una strega, ma se di strega si parla mi piace pensare alle streghe descritte da Jules Michelet, donne con presentimenti e folgorazioni, donne speciali, donne veggenti e fuori dal coro. Donne dal cappello rosso e gli occhi di un gatto. Adoro i gatti, sono creature magnifiche e coraggiose. Da sempre hanno accompagnato la mia lunga vita: Moutchi, Siam, Zingarella… venite qua.
L’autrice: Raffaella Cargnelutti
Raffaella Cargnelutti (Tolmezzo, Udine, 1957) è critica e storica dell’arte. Esordisce in narrativa con “Il ritratto di Maria” (Kappavu, 2010). Ha pubblicato numerosi libri di narrativa. Tra i più recenti, nel 2021, con Mursia editore, esce il romanzo “Le spiritate di Verzegnis”; nel 2023 con Santi Quaranta Editore “La pulce e altre storie della Carnia”.
E in questo 2025, sempre con Mursia Editore, è in libreria “L’altra guerra”, un romanzo storico ambientato durante l’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale. Una storia vera, ispirata al diario di una giovane ragazza della Val Pesarina, in Carnia.
Riproduzione riservata © il Nord Est