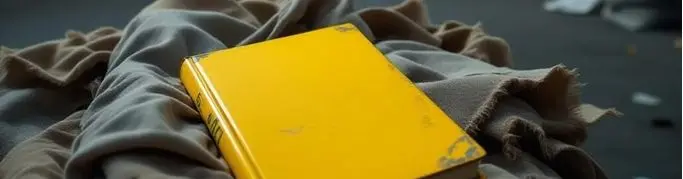Comodini svedesi, frange e velluto, ricordi in broccato
Una casa nuova e moderna scatena il confronto con un passato fragile. Tra stufe in maiolica e swing anni ’30, riaffiora la nostalgia di sé

Io non ho nulla contro il mio amico Leonardo, non fosse per quel senso pratico che lo assedia da sempre. L’altra estate ha acquistato una nuova casa: «In giugno è più facile traslocare» aveva detto. Così si era trascinato nel gorgo l’intera famiglia. Moglie e figli. Per esperienza sapeva che i bimbi distruggono qualsiasi cosa gli piazzi davanti, per cui le sue scelte erano cadute su mobili robusti, di poche pretese estetiche.
***
Il 5 agosto ero stata invitata a cena, proprio per farmi apprezzare la nuova dimora. Entrando in camera il mio sguardo si era ancorato per due secondi al comodino color pus da cui emergeva qua e là qualche nodo del legno. «Ti piace?» aveva chiesto Elena, la sposa di Leo, «viene dalla Svezia», disse. In quel momento avevo solo messo a fuoco che la Svezia era quel posto gelido dove immaginavo persone infreddolite chiuse in casa accanto a un camino, intente a progettare la morte dei comodini. Il punto è che era tutto troppo robusto e troppo moderno. Non potevi che pensare al lavoro, in una casa come quella. Pure d’estate. Io invece sono sempre stata attratta dalla fragilità degli ambienti, diciamo pure fatiscenza.
Ricordo come scelsi la mia prima camera in affitto, quando ancora studiavo all’università e mi mantenevo facendo la cameriera. Ci ero passata davanti, una piccola villa Liberty in via Bramante, a pianta rettangolare, talmente sbiadita da non indovinare il colore. Ciò che importava era il cartello affisso al portone “Affittasi stanza”. Non avevo neanche varcato la soglia quando dissi alla signora che stava venendo verso il cancello che prendevo la camera. Era una donna adulta, non più giovanissima ma naturalmente più giovane delle mura alle sue spalle e si chiamava Bianca.
***
Bianca era una vedova di carattere, ma a conquistarmi fu l’aspetto della casa, qualcuno l’avrebbe trovata decadente, «una topaia» l’avrebbe definita mia madre. Ma mia madre non è tipo da nostalgie per i periodi che non ha vissuto. Mi misi d’accordo per un prezzo più che ragionevole, forse avrei pagato qualcosa di più se mi fossi accorta prima del salottino illuminato da lampade a colonna francese, con tante di quelle frange da superare i costumi di Joséphine Baker, la più grande ballerina di charleston. Le tende erano di velluto, la carta da parati rifletteva il ricordo di piccoli gigli verdi e rosa. E c’erano soprammobili ovunque, vecchi portasigarette con le iniziali, minuti vasi Chamberlain’s, piccole statuine Biscuit, per lo più decapitate. Era magnifico. Sui tavolini art nouveau non potevi appoggiarti neppure un chicco di caffè.
Come secoli dopo avrei fatto da Leonardo, anche lì il mio sguardo era andato in sosta per più di due secondi: «Vedo che ti piace la mia poltrona antica», era rossa con microscopiche decorazioni in oro, «è un’autentica Josef Hoffmann. Non ne trovi più», disse Bianca. E lì misi a fuoco che l’Austria, a differenza della Svezia, era stato quel luogo dove vecchi designer infreddoliti progettavano la bellezza delle cose, di molte cose. Adoravo nutrirmi pure dai piatti di Bianca, dei Seltmann Weiden che secondo me poteva mangiarci pure Sissi: «Macché» diceva lei «non sono importanti, prodotti solo dal 1957». La mia vita diventò molto più regolare, proprio perché mi piaceva tornare a casa, quel villino che pareva caduto dal cielo potevi trovarlo solo nel Mago di Oz. O in via Bramante.
***
D’inverno Bianca mi aspettava nel piccolo salotto riscaldato da una stufa in maiolica, in genere leggevamo delle riviste e più spesso mi mostrava gli oggetti che aveva acquistato qua e là, Trieste è piena di mercatini e botteghe dell’usato. Dal salotto si poteva accedere anche alle sue stanze, “i miei alloggi”, li chiamava, ma erano sempre chiusi. A volte percepivo la musica di una radio che lei mi assicurava essere d’epoca. I nostri guardaroba erano simili, datatissimi, a parte i cappellini a cupola, che io non me la sentivo di indossare.
D’estate la trovavo in veranda, seduta su una delle due sedie fruibili, alla terza mancava il sedile ma erano tutte uniformemente vecchie. «Eccoti qua, ragazza», la sua voce mi raggiungeva appena varcato il cancello. Dopodiché tirava fuori qualche vecchio cimelio in seta e mi insegnava come riconoscerlo: «Devi osservare il rovescio del broccato, i fili del disegno devono staccarsi nettamente dal fondo». Avevamo trent’anni di differenza, ma io non me ne accorgevo.
***
Era l’estate del 1994 e a unirci era l’idea che entrambe fossimo diverse dal resto d’Italia, con i suoi centri commerciali e i suoi vasconi idromassaggio Jacuzzi. Andai a vivere lì all’inizio del 1993 e fino ad allora la vita mi pareva un sogno bellissimo. Talvolta, quando era in vena, Bianca infilava nel vecchio stereo uno dei miei motivi preferiti: «Vuoi la versione di Buti o Morricone?» chiedeva. Io sceglievo sempre Buti, solo perché piaceva a mio padre. Così, in quello spazio da Eugene O’Neill, partivano le prime note di Amapola.
L’Italia iniziava la sua lenta rovina, di cui mi importava poco, speravo che le nostre vite continuassero così all’infinito. Ma inesorabilmente il presente venne a bussare. E non il presente migliore, quello che in futuro si sarebbe potuto collezionare come una lampada Kartell. Il Piano Regolatore Generale Comunale prevedeva di valorizzare il patrimonio storico integrando nuove costruzioni. A loro non importava dell’edificio, volevano il terreno.
Bianca era stata molto brava a fare resistenza, finché il prezzo aveva raggiunto il suo apice. Venne a comunicarmelo una sera di settembre. Io ero stesa sul pavimento della mia camera per lasciare una traccia di sudore mentre gli 883 avevano vinto il Festivalbar con una canzone orribile. Era inevitabile che mi sentissi triste. Ma c’era un’altra parte di me che iniziava a farsi strada, quella che amava il climatizzatore e un comodino – possibilmente non svedese – esile ma intatto.
***
Dopo quella notizia, non so bene perché, iniziai a guardare le stanze per quelle che erano, una casa piena di cianfrusaglie. Non saprò mai se fu una reazione emotiva per lenire il distacco o il mio personale saluto al romanticismo. Non ho mai capito quale fosse il vero valore che attribuivo a tutti quegli oggetti rovinati. Probabilmente davano solo la sensazione di condividere il gusto per il passato e la cosa mi piaceva. Ogni tanto c’è bisogno di un rifugio.
Non ho più sentito Bianca, ma talvolta, se per caso percepisco uno swing americano anni ’30, mi pare di sentire la sua voce che dice: «Alza il volume».
L’autrice
Mary B. Tolusso è nata a Pordenone e vive tra Milano e Trieste. Laureata in Lettere, lavora come giornalista. È autrice dei romanzi “L’imbalsamatrice” (Gaffi, 2010), “L’esercizio del distacco” (Bollati Boringhi eri, 2018) e delle raccolte poetiche “L’inverso ritrovato” (Lietocolle, 2003), “Il freddo e il crudele” (Stampa, 2012), “Apolide” (Mondadori, 2022) e di numerose altre pubblicazioni di saggistica e poesia. È stata finalista al Premio Strega 2023. Ha vinto il Premio Pasolini (2004), il Premio Fogazzaro (2012) il Premio Internazionale Città di Moncalieri (2023) e Il Premio Acqui Terme (2023).
Riproduzione riservata © il Nord Est