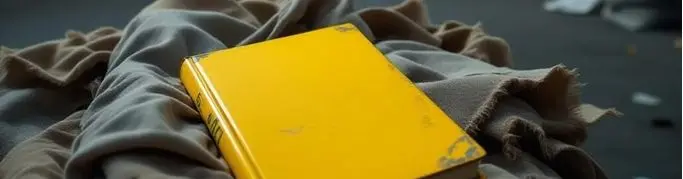Nel bosco vivo i torrenti ribelli chiedono ascolto
Ci parlano di origine, energia, ribellione e libertà naturale. A Dubai ricreano le piste da sci nei centri commerciali. Ma non tutto va costruito

Il torrente di montagna è fragore, salto, turbinìo, forza; ed è composto solo di piccole gocce d’acqua, un elemento primario moltiplicato all’infinito: la piccola goccia inodore-incolore-insapore; qualcosa che ci porta all’inizio della vita sul pianeta, e che oggi possiamo riscoprire ancora vitale e ribelle nei torrenti di montagna.
Per raggiungere, sulle Dolomiti d’Ampezzo, Malga Fedèra – il cui nome suggerisce l’antica presenza delle pecore-fede –, c’è una strada asfaltata da percorrere in automobile o in bicicletta; ma c’è un sentiero che si può fare solo ed esclusivamente a piedi e si chiama Ra Gores de Fedèra, le gole del torrente. È un camminamento che s’inerpica accanto al corso d’acqua, e fa pensare che le prime vie di penetrazione alla montagna dei nostri antenati raccoglitori e cacciatori, siano state proprio le valli ricche d’acqua, l’elemento necessario per dissetarsi e attendere le prede, seguendo un percorso inequivocabile come il segno di una mappa, molto prima che l’idea di mappa esistesse. Le gocce d’acqua, nell’aggregarsi continuo, casuale e potentissimo diventano la forza impetuosa del mulinello, la quiete dello sfioro sui sassi, l’ebbrezza festosa degli spruzzi; sono lo slalom tra enormi massi a forma di scaglie, lastre, cubi: corpi pesanti, disseminati, poggiati in un equilibrio precario e destinati allo scivolamento, alla caduta, alla frana.
***
Il sentiero procede nel bosco sempre accompagnato dal fragore dell’acqua che a volte è vicino, a volte più lontano: in certi momenti la voce non basta a farsi comprendere da chi ci sta davanti o dietro e si devono fare dei gesti ai compagni di cammino.
Si attraversano passerelle di ferro, si sale su gradini formati da tronchi che contengono pietrisco, si costeggiano dirupi – alcuni attrezzati con un cordino metallico –, e ci si inoltra in gole asciutte e strettissime, dove si può immaginare scorresse lo stesso torrente migliaia di anni fa, e si fa quell’esperienza inebriante del corpo al lavoro, della fatica, del sudore e della breve sosta che rigenera e consente di riprendere fiato.
Fermarsi un momento è l’occasione per bere, e capire immediatamente cosa sia quel legame indissolubile della vita con l’acqua, il suo valore assoluto. Lo stordimento dell’affanno si attenua nei brevi tratti in piano dove anche il torrente sembra acquietarsi dopo la folle corsa e si avverte l’unicità di ciò che sta sotto ai piedi, di fianco, intorno e su fino al cielo, attraversato da nubi bianche e veloci nelle mattine d’estate.
Le brevi soste permettono anche di cercare uno slargo tra gli alberi, un affaccio sull’ampia e ariosa conca ampezzana e su Cortina, la Perla delle Dolomiti; la città della moda, dello sport, dei personaggi, della cultura, del turismo d’élite, che vi soggiorna, e del turismo di massa, che vi transita: una realtà urbana in mezzo alle montagne che non ha eguali; edificata in una terra di confine che a ben vedere ha sempre posseduto una dote, la ricchezza, anche quando era una realtà rurale.
***
Così scriveva Giovanna Zangrandi nel romanzo I Brusaz: “Si parte dai poveri villaggi delle valli che stanno di qua, dai paesetti con le case nere appollaiate sui pendii magri, senza campi, senza terre; si parte, si valica, si può andare a Hoden a fare la stagione dei fieni”.
E Hoden-Cortina ha il suo torrente speciale, il Boite, citato come inizio folgorante delle straordinarie scoperte del ricercatore Rinaldo Zardini: “Nel 1935 trovai casualmente una pietra insolita nel Rio Boite. La misi in un armadio e chiesi a tutti di che tipo di pietra poteva trattarsi. Un botanico inglese mi spiegò che poteva trattarsi esclusivamente di un corallo fossilizzato” (note biografiche del Museo Paleontologico Rinaldo Zardini). Anche di queste meraviglie, che datano milioni di anni, è custode un torrente di montagna nel cuore delle Dolomiti.
Così chi sale accanto ai torrenti, lasciandosi alle spalle l’afa estiva ormai intollerabile della pianura e la calura del fondovalle, ha la sensazione di essere dentro una grande abbondanza di terra, luce, ossigeno, fotosintesi e acqua, e sa che sono beni comuni. Una ricchezza da amministrare con cura e parsimonia soprattutto quando bussano alle porte della montagna le sirene luccicanti e pazzoidi del consumo sfrenato di suolo, quel suolo che è valle, conca prativa, pendio, bosco e sempre più su fino al passo, alla forcella, alla vetta.
***
Consideriamo questo: costruzioni e impianti stupefacenti possono essere edificati in tutti i luoghi del mondo, bastano solo investimenti e progetti. Per esempio: a Dubai c’è un grande centro commerciale al cui interno c’è una pista da sci: è lunga quattrocento metri, alta 85 e larga 80: è questo il tipo d’intrattenimento che vogliamo davvero? È questa la bellezza, lo svago? La meraviglia? Con calcoli, cemento, ferro, vetro, plastica, nuovi materiali siamo potenti, si è capito, è stato dimostrato. Ma possiamo costruire la Croda da Lago o il Becco di Mezzodì? E perché non proviamo ad attrezzarci con grandi proiettori per accendere l’enrosadira anche di notte? O almeno, riusciamo a costruire un piccolo torrente di montagna con tutto ciò che vive dentro?
La risposta è semplice, non possiamo “fabbricare” certe cose che esistono intorno a noi. E quindi si tratta di riconoscerne il valore ambientale, paesaggistico, culturale ed economico. Sì, economico, perché è la bellezza della montagna a rendere pregiato un luogo, non quanto di eccessivo e stravagante riusciamo a costruirci dentro. E ciò che trasmette un torrente di montagna, e non lo può fare un oggetto fasullo – come una pista da sci dentro un centro commerciale –, è una specie di fresco desiderio di far parte di quello scorrere, di quella vita, di quella quieta e inarrestabile ribellione che non si può fermare.
L’autore
Antonio Giacomo Bortoluzzi è nato nel 1965 in Alpago, Belluno. Finalista nel 2008 e 2010 del premio Italo Calvino, nel 2010 ha pubblicato Cronache dalla valle, nel 2013 Vita e morte della montagna, nel 2015 Paesi alti, con cui ha vinto il premio Gambrinus-Giuseppe Mazzotti nella sezione Montagna - cultura e civiltà; i tre romanzi (Ed. Biblioteca dell’Immagine), sono raccolti nell’antologia Montagna madre, trilogia del Novecento (2022).
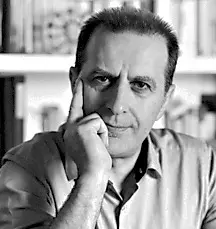
Con Marsilio ha pubblicato nel 2019 il romanzo Come si fanno le cose, da cui è stata tratta l’omonima commedia teatrale e nel 2023 Il saldatore del Vajont, con cui ha vinto il Premio Coop Alleanza 3.0 della Giuria dei lettori del Premio Latisana per il Nordest 2024: entrambi i romanzi sono ripubblicati nell’UE Feltrinelli. È ora in libreria, in collaborazione con il fotografo Manuel Cicchetti, con il nuovo volume fotografico dal titolo: Dolomiti, un paesaggio tutelato (Marsilio Arte e Regione del Veneto). Membro accademico del Gruppo italiano scrittori di montagna (Gism), i suoi articoli sono pubblicati su riviste nazionali e sulle pagine culturali dei quotidiani del Nordest.
Riproduzione riservata © il Nord Est