«Non sei portato per la matematica»: perché è sbagliato dire questa frase ai bambini
Uno studio dell’Università di Trieste, tra le prime tre al mondo per ricerca sul tema, spiega perché quelle parole sono dannose e offre strategie concrete a genitori e insegnanti
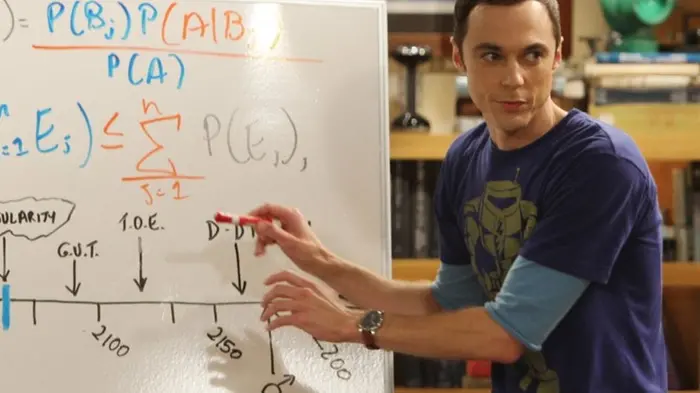
«Non sei portato per la matematica»: quattro parole che possono rovinare per sempre il rapporto dei bambini con i numeri. E che, secondo la scienza, andrebbero bandite dal vocabolario di genitori e insegnanti.
A certificarlo è l’Università di Trieste, appena salita sul podio mondiale della ricerca sull’ansia matematica come certificato da uno studio bibliometrico della rivista Frontiers in Psychology, che colloca l’ateneo giuliano tra le prime tre università al mondo per gli studi su questo fenomeno.
In questo contesto, si distingue la produzione scientifica del laboratorio di Psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento (Dipartimento di Scienze della vita di UniTs) che da anni si occupa di tali tematiche sotto la direzione delle professoresse Maria Chiara Passolunghi e Sandra Pellizzoni, con il contributo degli attuali collaboratori Alessandro Cuder, Eleonora Doz, Federica Granello, Giorgia Morosini, Lorena Perrotti e Martina Taruscia.
Dalla teoria alla pratica: cosa fare quando il proprio figlio si blocca davanti a un’operazione o scoppia in lacrime sui compiti? Con l’avvio del nuovo anno scolastico, abbiamo chiesto alla professoressa Passolunghi di tradurre anni di ricerca scientifica in consigli concreti per genitori e insegnanti.
«La frase da non dire mai è: “Non sei portato per la matematica”», esordisce Passolunghi: «È come fissare qualcosa di immutabile. Anche un apparentemente innocuo “Anch’io ero negata in matematica” può essere controproducente: equivale a trasmettere l’idea che se io sono negata, anche tu lo sarai». Il meccanismo di trasmissione dell’ansia scatta già a tre anni. «È l’atteggiamento stesso del genitore di fronte all’errore a sviluppare il problema. La matematica deve essere un piacere. Come si gioca con le parole, si può giocare anche con i numeri».
Il gender gap matematico in Italia è il più ampio tra i Paesi Ocse, e le bambine ne pagano il prezzo più alto. «Quando una bambina dice “Non sono portata per i numeri”, sta comunicando la paura di non dimostrarsi all’altezza», analizza Passolunghi. «L’ansia la porta a due comportamenti estremi: o non prova neanche, o sviluppa un perfezionismo ossessivo». Il meccanismo è perverso: «Se penso che il mio genere sia meno portato per la matematica, mi sento meno competente anch’io. E quando non so controllare la situazione nasce l’ansia».
Il metodo triestino ha un approccio pratico e immediato. «Di fronte a un bambino che si blocca, l’insegnante potrebbe chiedere: “Cosa ti impaurisce? ”», spiega la professoressa. «E poi potrebbe insegnare tecniche di controllo e autoregolazione. Infine, potrebbe fornire strategie specifiche per quel compito». L’obiettivo è spostare l’attenzione dall’effetto negativo futuro all’attività presente. Non “Cosa succederà se sbaglio” ma “Come posso affrontare al meglio questo compito qui e ora”».
«L’errore fa parte del processo di apprendimento – insiste Passolunghi –. In matematica è particolarmente visibile, ma deve diventare motivo di curiosità: perché ho sbagliato? Gli errori sono degli amici da cui imparare». È il concetto di “mente incrementale”: «Sbaglio, ma ci riprovo di nuovo e, passo dopo passo, gli errori costruiscono la mia conoscenza».
La pandemia ha lasciato cicatrici profonde. «C’è stata una caduta generale delle competenze di base» , conferma la ricercatrice. La matematica nelle prime fasi ha bisogno di attività di manipolazione degli oggetti, aspetti che la didattica a distanza ha fatto perdere. Ma il vero rischio è dimenticare il piacere: «Con minori competenze si tende a fare più esercizi, ma se dimentichiamo l’aspetto ludico del compito non andiamo da nessuna parte».
«Come esiste il progetto “Nati per leggere” – conclude Passolunghi – noi diciamo: siamo “Nati per contare”. La matematica può e deve diventare un’esperienza di flusso, come quando ci immergiamo in una lettura piacevole». L’obiettivo è che lo studente perda la cognizione del tempo, totalmente assorbito in un’attività matematica senza paura di sbagliare.
Riproduzione riservata © il Nord Est








