La montagna che si ripopola è una notizia. Con qualche problemino
Il rapporto Uncem identifica l’inversione di tendenza dopo anni di progressivo abbandono, ma mette in guardia sui rischi legati a terremoti, frane e alluvioni

Finalmente, fra tanto ciarpame mediatico, una Notizia con la maiuscola: la montagna si ripopola. Dopo un lungo esodo silenzioso, le terre alte tornano a richiamare le persone, segnala il rapporto 2025 dell’Uncem, l’Unione delle comunità montane. Ma proprio per questo, il documento segnala la necessità di intervenire con concreti investimenti su alcune criticità, per sostenere la riscoperta dei territori: lo fa con un capitolo che reca un titolo declinato in termini di paradosso, “Fragile come una montagna”, con riferimento a tre fronti-chiave: rischio sismico, rischio frane, rischio alluvioni.
Con il Nord Est che figura tra le aree più esposte, come riproposto ormai da decenni in chiave di cronaca: vedi il crollo di pezzi di montagna nella valle del Boite, che in questi giorni sta isolando Cortina.
Le cifre, innanzitutto
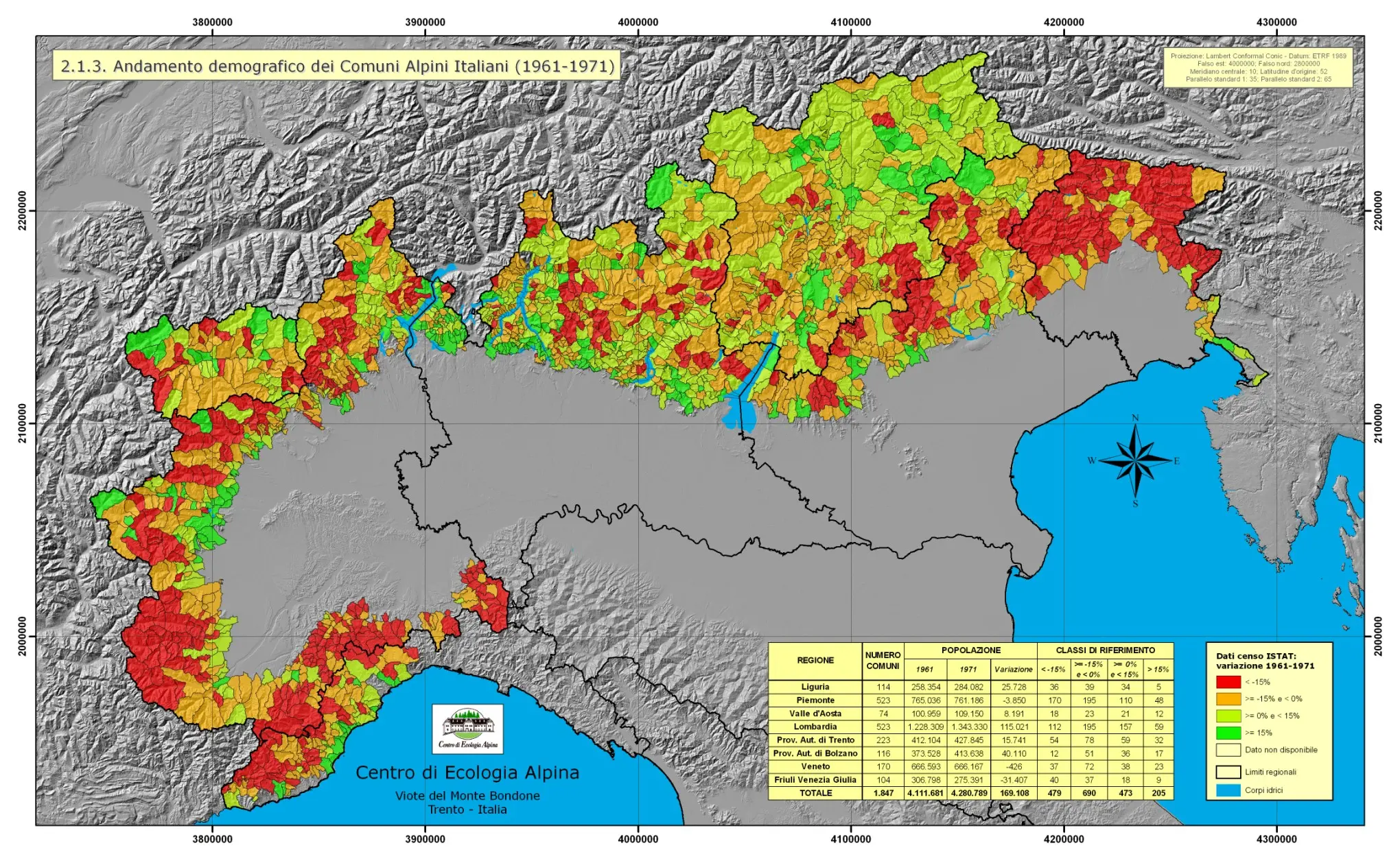
I numeri nordestini sono eloquenti. A livello sismico, i Comuni montani a rischio sismico alto e medio-alto sono attorno al 30 per cento in Veneto, per una popolazione complessiva di 161mila abitanti, il 52 per cento della popolazione residente; in Friuli Venezia Giulia arrivano addirittura all’88 per cento, per un complesso di 110mila residenti, pari all’84 per cento degli abitanti.
Sul piano delle frane, il rischio incombe su 74 Comuni veneti, il 64 per cento del totale dei Comuni montani; in Friuli Venezia Giulia riguarda 69 Comuni, pari all’82 per cento del totale. Infine, il rischio alluvioni si estende a 18 Comuni veneti, il 16 per cento di quelli montani; in Friuli Venezia Giulia a 41, pari al 49 per cento. Dunque, un’incidenza di calamità naturali particolarmente elevata nelle terre alte nordestine.
Per prevenirle, o quanto meno contenerle, servirebbero risorse importanti, segnala Uncem: almeno 10 miliardi l’anno per dieci anni; siamo molto lontani da questa cifra, se si pensa che gli stessi fondi previsti nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) ne destina soltanto due e mezzo per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Eppure le dimensioni del fenomeno su cui intervenire sono significative: in Italia, ci sono 11 milioni di ettari di boschi, pari a un terzo della superficie dell’intero Paese; e i tanti dissesti idrogeologici che la cronaca ci propone implacabilmente ogni anno dipendono in misura significativa anche da foreste non gestite.
Si è costruito troppo
Ma non soltanto: va aggiunta l’opera deleteria dell’uomo. Come denuncia il rapporto Uncem, si è costruito troppo, si sono verificati troppi abusivismi, ci sono stati troppi condoni. Tutto questo in un Paese fragile di suo: in Italia, la superficie a elevato rischio idrogeologico consiste in 20mila chilometri quadrati; e oltre sei milioni e mezzo di persone vivono in Comuni a rischio elevato, il 58 per cento dei quali in montagna.
Con tutta evidenza, è un virus che presenta ricadute di ampia portata anche e soprattutto sul piano economico. Il dossier Uncem sottolinea come il valore stimato dei danni materiali risulti sempre di gran lunga superiore ai costi di una seria attività di prevenzione o anche di riqualificazione dei territori coinvolti: il che, “ancora una volta richiama ad una responsabilità del sistema politico-ammnistrativo centrale e locale, affinché ponga definitivamente al centro delle proprie agende di governo il tema della prevenzione e della riqualificazione come priorità per la salvaguardia dei cittadini e dei territori”.
Sulla base dei dati concreti, il rapporto segnala che l’intensità e la frequenza degli eventi di dissesto idrogeologico è progressivamente cresciuta negli ultimi decenni, “principalmente a causa dell’eccessiva antropizzazione del territorio, spesso avvenuta in luoghi idrogeologicamente instabili o in forma abusiva, al di fuori o in assenza di progetti di pianificazione territoriale e urbanistica che tenessero conto della specifica esposizione al rischio di ciascuna area”.
La crisi climatica
A questa componente se ne sta aggiungendo ormai da anni un’altra, non meno pesante nelle conseguenze: il mutamento climatico, che ha determinato eventi meteorologici (precipitazioni, grandinate, siccità) sempre più intensi, se non estremi, a loro volta causa di smottamenti e frane.
Anche qui, Uncem sottolinea che “la particolare pericolosità dei fenomeni alluvionali è in larga misura ascrivibile a cause antropiche, quali l’edificazione in aree ad alto rischio e, più in generale, l’estensione dei centri abitati, l’urbanizzazione e la cementificazione spesso incontrollate, che hanno consumato porzioni sempre più ampie di suolo”. Un’incidenza è stata esercitata anche dalle carenze nella pulizia degli alvei fluviali e delle aree circostanti, che hanno di fatto ridotto la capacità di contenimento delle piene rendendo pericolosamente elevato il rischio di esondazioni.
Su questa base, il dossier Uncem prende in considerazione un periodo specifico, quello tra il 2000 e il 2016, in cui in Italia si sono verificati ben 41 disastri naturali di rilevante entità: 11 terremoti e 30 fenomeni idrogeologici quali frane e alluvioni; catastrofi che hanno provocato 742 vittime, e 141mila persone rimaste ferite o che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. Quanto ai costi, questi eventi hanno determinato una spesa complessiva di 63 miliardi di euro. Abbastanza per indurre a girare pagina.
Il podcast generato dalla AI
Domande e risposte sul rapprto Uncem*
Qual è la percezione generale degli italiani riguardo alle aree montane e quali sono le principali sfide che affrontano?
Gli italiani associano le montagne principalmente a concetti positivi come la neve, l'aria pura, la natura, i boschi, gli alberi, gli spazi aperti, la libertà e le cime. Vedono la montagna come un luogo incontaminato e ideale per il relax, l'apprezzamento del cibo tipico e le visite culturali. Tuttavia, la percezione non è priva di ombre: le principali sfide identificate sono lo spopolamento (52%), l'impatto dei cambiamenti climatici (45%) e l'incuria/abbandono del territorio (41%). Altri problemi rilevanti includono le difficoltà di collegamento e accesso ai servizi di base (26%), le scarse prospettive per i giovani (25%) e la carenza di posti di lavoro (21%). Nonostante il 56% consideri la montagna un ottimo luogo dove trasferirsi, solo il 38% immagina per essa un futuro prospero, riflettendo la consapevolezza delle sue fragilità economiche e ambientali.
In che modo la crisi demografica e i cambiamenti climatici stanno influenzando le montagne italiane e quali tendenze recenti si osservano nel ripopolamento?
Le montagne italiane sono particolarmente vulnerabili alla crisi demografica, manifestata da un invecchiamento della popolazione e una stagnazione economica a livello nazionale. Tuttavia, il periodo 2019-2023 ha mostrato un'inversione di tendenza inedita: un saldo migratorio complessivamente positivo, con quasi 100.000 ingressi netti, soprattutto nelle regioni del Nord e del Centro Italia. Questo "risveglio" è in parte dovuto a una nuova consapevolezza della popolazione, che valuta la distanza dagli agglomerati urbani come un vantaggio. Nonostante ciò, il fenomeno è asimmetrico: il Mezzogiorno continua a registrare un esodo di giovani e scolarizzati, evidenziando una "faglia" tra le diverse aree montane. Questa ripresa è comunque fragile e dipende dal mantenimento dei servizi pubblici di base, dalla creazione di nuove economie e dalla capacità di integrare diverse antropologie. I cambiamenti climatici aggravano i rischi naturali (dissesto, eventi estremi, incendi) e la perdita di biodiversità, ma paradossalmente spingono anche a nuove politiche territoriali.
Cosa sono le "Green Community" e qual è il loro ruolo nello sviluppo sostenibile delle aree montane?
Le "Green Community" rappresentano una novità importante nel panorama istituzionale italiano per le montagne. Non sono semplici confini amministrativi o enti pubblici, ma territori e alleanze di sindaci (spesso di un'intera valle o area omogenea) che coordinano gli sforzi della società civile, delle imprese e degli attori sociali. L'obiettivo è promuovere uno sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale, superando una logica di mera conservazione per favorire l'attivazione di nuove opportunità. Vengono implementate tramite piani di sviluppo che integrano diverse azioni, come la gestione sostenibile del patrimonio agro-forestale, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo sviluppo del turismo sostenibile e l'integrazione dei servizi di mobilità. Mirano a coniugare le esigenze di tutela ambientale con la creazione di valore e occupazione, spesso valorizzando risorse locali come il legno o il paesaggio.
Qual è il concetto di "governance catalitica" nelle Green Community e come si lega al partenariato pubblico-privato?
La "governance catalitica" descrive il ruolo dell'amministrazione pubblica nelle Green Community: non più un'amministrazione pianificatrice che detta regole dall'alto, ma un facilitatore che offre il "campo da gioco" e favorisce la trasformazione attraverso la collaborazione tra diversi attori. In questa prospettiva, l'attore pubblico è un'alleanza di sindaci che adotta un approccio strategico e reticolare. Il partenariato pubblico-privato (PPP) è uno strumento fondamentale per la realizzazione dei progetti delle Green Community, permettendo una progettazione e un dimensionamento adeguati delle attività, oltre a un supporto finanziario. Questo approccio consente di superare le rigidità burocratiche e di mobilitare risorse e competenze dal settore privato, accelerando l'implementazione di progetti ambiziosi per lo sviluppo sostenibile, anche se richiede una gestione attenta delle fasi e dei rischi.
Quali sono le principali iniziative e tecnologie che le Green Community stanno adottando per affrontare le sfide della montagna?
Le Green Community stanno adottando una varietà di iniziative e tecnologie per affrontare le sfide della montagna. Nel settore agricolo, si punta a forme di aggregazione come le Associazioni Fondiarie per recuperare terreni abbandonati e valorizzare le produzioni locali, spesso integrate con il turismo e le specialità enogastronomiche. La sensoristica e l'analisi dei dati sono impiegate per un'agricoltura di precisione, mentre la robotica e i droni supportano il lavoro agricolo. Per l'energia, si mira all'efficientamento degli impianti, all'uso delle biomasse locali e allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili. La gestione delle acque si avvale di tecnologie avanzate per il monitoraggio delle perdite e la riqualificazione multifunzionale dei bacini idrici. Nel settore forestale, si promuovono modelli di gestione sostenibile e certificazione, con piattaforme digitali per la tracciabilità e la valorizzazione del legno. Infine, l'interconnessione digitale tramite banda ultra larga è cruciale per ridurre il divario con le aree urbane, abilitando servizi innovativi come la telemedicina, lo smart working e piattaforme turistiche.
Come si stanno evolvendo i modelli economici e sociali delle montagne italiane, in particolare per quanto riguarda l'occupazione e l'imprenditoria?
L'economia montana si distingue per una densità inferiore di imprese agricole rispetto alla media nazionale, ma con una certa tenuta dei valori economici, specie negli Appennini, e una crescita di imprese e addetti, inclusi giovani operatori. L'imprenditoria artigiana è significativa (27,4% del totale), specialmente nel Nord Italia, mentre al Sud è meno diffusa. Sorprendentemente, l'imprenditoria giovanile in montagna è superiore alla media nazionale (9,4% contro 8,8%), concentrandosi nel Nord-Ovest, Trentino-Alto Adige e nelle regioni meridionali. Le imprese straniere sono meno presenti rispetto alla media nazionale (7,5% contro 11,5%). Il potenziale turistico è elevato, ma si sta evolvendo verso un turismo più esperienziale e legato al paesaggio, superando il modello incentrato esclusivamente sullo sci. Si cerca di creare filiere integrate e valorizzare le peculiarità locali. A livello di PIL pro capite, le Alpi mostrano valori superiori alla media nazionale, mentre gli Appennini sono ben al di sotto, evidenziando disuguaglianze.
Qual è il ruolo delle istituzioni locali e delle aggregazioni territoriali, come le Unioni di Comuni, nella promozione dello sviluppo montano?
Le istituzioni locali, in particolare i comuni montani e le loro forme associative, sono considerate cruciali per la rigenerazione e lo sviluppo delle montagne. Le "vecchie" Comunità montane hanno avuto un ruolo storico, ma oggi si punta alle Unioni di Comuni, che aggregarebbero i quasi 4000 comuni montani in 387 "Comunità Territoriali". Questo processo associativo, sebbene disomogeneo tra le regioni (più forte al Nord), è visto come essenziale per superare la frammentazione e sostenere processi di sviluppo efficaci, anche in relazione a strategie come la SNAI e le Green Community. Si propone che le Unioni montane diventino "enti di bonifica territoriale" per la prevenzione del dissesto e "agenzie di sviluppo" socio-economico, gestendo servizi e funzioni in forma associata. È fondamentale che queste aggregazioni non nascano solo per il risparmio, ma per ottimizzare e innovare la gestione del territorio, rafforzando la cooperazione e la coesione.
Qual è la visione a lungo termine per le montagne italiane e come si intende valorizzare il loro capitale naturale e umano?
La visione a lungo termine per le montagne italiane è quella di trasformarle da "margini" a "centri" strategici per lo sviluppo complessivo del Paese, soprattutto alla luce delle transizioni ecologica e digitale. Si mira a una "politica CON la montagna", che riconosca il suo ruolo di "serbatoio di beni comuni" (acqua, foreste, biodiversità) e di laboratorio per l'innovazione sociale. È fondamentale valorizzare il capitale naturale attraverso la gestione forestale sostenibile, il pagamento per i servizi ecosistemici e la promozione di filiere locali. Per il capitale umano, l'obiettivo è attrarre e trattenere giovani qualificati, anche attraverso nuove professioni legate al green e al digitale, e investire nella formazione e nei servizi essenziali (sanità, scuola, trasporti). Si punta a ricostruire una "coscienza di luogo" nelle comunità, favorendo la co-progettazione e l'ibridazione di saperi antichi e nuovi, per un "sviluppo sostenibile" che equilibri crescita economica, inclusione sociale e tutela ambientale.
(*scheda realizzata con Notebook LM)
Riproduzione riservata © il Nord Est








