Il Nord Est dei pontefici: dieci da inizio cattolicesimo, i nomi e le storie
Del primo non si conosce il nome, forse Tirannio Rufino; l’ultimo nel 1978. Nel Quattrocento vennero eletti tre Papi veneziani: Gregorio XII, Eugenio IV e Paolo II
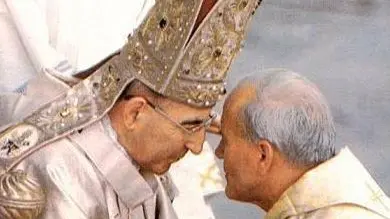
La vigna del Signore. Ha garantito una vendemmia copiosa di preti, frati, suore, abati, vescovi, cardinali, il cattolicissimo Nord Est; e ci ha aggiunto pure il dono a Santa Madre Chiesa, nei suoi duemila anni di storia, di ben dieci Papi.
La prima volta è già all’inizio, quando i cattolici sono ancora nelle catacombe, ferocemente combattuti dall’impero romano. Tocca a un sacerdote di Aquileia (che diventerà la chiesa-madre del Triveneto), di cui non conosciamo il nome all’anagrafe, forse Tirannio Rufino: prende il nome di Pio I, è il nono successore di Pietro, viene eletto nel 140, morirà nel 155. Malgrado la comunità cristiana sia ancora alle prime battute, deve far fronte a una serie di eresie, specie quella di Marcione, vescovo e teologo greco.
Passano secoli prima del bis, con un trevigiano, Nicolò Boccassini, dell’ordine dei domenicani: viene eletto all’unanimità, fin dal primo scrutinio, il 21 ottobre 1303, prendendo il nome di Benedetto XI; da cardinale, è stato testimone del celebre “schiaffo di Anagni”, l’oltraggio recato a papa Bonifacio VIII da un emissario di Filippo il Bello re di Francia a seguito di uno scontro feroce sui rapporti di potere tra Chiesa e Stato.
E’ un conflitto che Benedetto cerca di ricomporre, senza peraltro riuscirvi; anzi, sarà costretto a rifugiarsi a Perugia, dove muore nel 1304, a soli otto mesi dall’elezione. Bisogna attendere il secolo successivo per vedere un nuovo Papa veneto; ma saranno addirittura tre quasi di fila. Comincia il 30 novembre 1406 Angelo Correr, veneziano, figlio di nobile famiglia; già patriarca di Costantinopoli, viene scelto quasi all’unanimità, prendendo il nome di Gregorio XII. Ma si insedia nel pieno del cosiddetto scisma d’Occidente esploso da una trentina d’anni, dovendo vedersela perfino con un anti-papa, Benedetto XIII, che ha sede ad Avignone. Gregorio riesce a ricomporre la frattura; poi si dimette; muore a Roma nel 1417.
Dopo altri 14 anni al soglio di Pietro sale Gabriele Condulmer, veneziano doc, nipote per parte di madre di Gregorio XII: viene eletto il 3 marzo 1431, con il nome di Eugenio IV, ma ha tutt’altro che vita facile in una Roma divisa dalla lotta scatenata dalla potente famiglia dei Colonna; la quale nel 1434 costringe il Papa a una precipitosa fuga da Roma su una barca, travestito da monaco. Si rifugia a Firenze, dove vivrà in esilio per quasi dieci anni. Rientrato in sede, muore nel 1447 a seguito di una grave malattia.
Neanche vent’anni dopo tocca al terzo veneziano del secolo, Pietro Barbo, nipote di Eugenio IV, eletto il 30 agosto 1464 all’unanimità fin dal primo scrutinio con il nome di Paolo II. Tra i primi provvedimenti c’è quello di rinunciare alla sede tradizionale del Papato, facendo costruire palazzo Venezia, che poi diventerà sede degli ambasciatori della Serenissima. Muore nel 1471, a soli 54 anni.
Bisogna aspettare due secoli prima di trovare un altro papa veneto, veneziano anch’egli: Pietro Vito Ottoboni, pontefice a quasi 80 anni con il nome di Alessandro VIII, eletto il 6 ottobre 1689 all’unanimità del conclave: la Serenissima accoglie la nomina con grandi festeggiamenti presieduti dal doge Francesco Morosini; il pontefice ricambierà garantendo alla sua città sostanziosi aiuti nelle guerre del Peloponneso e di Morea contro il Turco. Peraltro abbonda a piene mani nel nepotismo, grande piaga del papato da secoli, elargendo abbondanti gratifiche ai parenti. Muore nel 1691 per cancrena a una gamba.
Il Settecento, secolo della fine della Serenissima, vede il quinto e ultimo papa veneziano: Carlo Rezzonico, già vescovo di Padova dove si è guadagnato l’alta stima di papa Benedetto XIV. Viene eletto il 6 luglio 1758, da un contrastato conclave che dura due mesi, e prende il nome di Clemente XIII. Risolve un lunghissimo e velenoso contrasto in atto tra la Chiesa e la sua Venezia; ma si trova a dover gestire la spinosa questione dei Gesuiti, di cui le grandi potenze dell’epoca chiedono lo scioglimento. Muore nel 1769, senza essere riuscito a evitare la drastica misura.
Nell’Ottocento tocca a un bellunese, Bartolomeo Alberto Cappellari, eletto il 2 febbraio 1831 dopo quasi due mesi di conclave, con il nome di Gregorio XVI; mantiene anche a Roma la sobrietà del suo stile montanaro; emana una severa condanna del liberalismo, da lui definito un pericolo per l’umanità. Muore nel 1846.
Agli inizi del Novecento si insedia uno tra i più popolari dei pontefici, Giuseppe Sarto, trevigiano di Riese, figlio di una famiglia del popolo; ordinato sacerdote, esordisce come cappellano a Tombolo nel Padovano; diventa vescovo prima a Treviso poi a Mantova, quindi viene nominato patriarca di Venezia. Da qui parte nel 1903 per partecipare al conclave che deve scegliere il successore di Leone XIII: dopo tre giorni tormentati, il 4 agosto i cardinali puntano su di lui, malgrado le sue energiche resistenze, domate da un confratello che gli dà un’energica strigliata. Prende il nome di Pio X, muore nel 1914 alla vigilia della Grande Guerra.

Infine, nel 1978 tocca ad Albino Luciani, “il Papa del sorriso”. Bellunese di Canale d’Agordo, figlio di povera famiglia, vescovo di Vittorio Veneto, assume a sua volta l’incarico di patriarca di Venezia, dove conquista le persone per la semplicità del suo stile di vita e l’approccio umano. Il 26 agosto del ’78 si apre il conclave che deve designare il successore di Paolo VI; i cardinali sono 111. Al quarto scrutinio Luciani viene eletto con consenso pressoché plebiscitario: “Dio vi perdoni per quello che avete fatto”, dirà ai suoi confratelli. Prende il nome dei suoi due predecessori, chiamandosi Giovanni Paolo I. Si distingue da subito per la sobrietà dello stile e la familiarità del tratto; rimane famoso un suo discorso in cui afferma che “Dio è papà, più ancora è madre”. Venerdì 29 settembre, appena 33 giorni dopo la nomina, lo trovano morto nel suo letto, a soli 66 anni. Gli subentrerà Karol Wojtyla, che riparte dal suo nome, scegliendo di chiamarsi papa Giovanni Paolo II.
Quel conclave a Venezia tra reazionari e veti incrociati

Ha ospitato anche un conclave nella sua lunga storia, Venezia, oltre ad avere dato ben cinque Papi alla Chiesa; tre dei quali in un solo secolo, il Quattrocento: Gregorio XII (1406), Eugenio IV (1431), Paolo II (1464); poi Alessandro VIII (1689), e infine Clemente XIII (1758). Nel 1799 muore Pio VI, e si apre l’iter della successione. Solo che in quel momento Roma è inagibile, perché governata dalla Repubblica giacobina, filo napoleonica. Il pontefice stesso, prigioniero dei francesi, è stato portato a Valence, nel Delfinato, dove è morto.
A quel punto, per procedere alla successione, il collegio cardinalizio si vede offrire l’ospitalità di Federico II di Asburgo-Lorena, che mette a disposizione Venezia (dopo la caduta della Serenissima il Veneto è passato all’Austria in seguito al trattato di Campoformio).
Sono 34, su un totale di 46, i cardinali che l’1 dicembre 1799 si ritrovano in laguna, accolti nel monastero benedettino dell’isola di San Giorgio, il cui progetto reca la firma di Palladio. In mattinata il decano, Giovanni Francesco Albani, celebra il canonico rito del “Pro electione futuri summi pontificis”; al pomeriggio si tiene la prima riunione, nel coro invernale della basilica. Ci vorranno peraltro tre mesi e mezzo prima di arrivare alla scelta. Subito emerge la spaccatura tra due correnti: una conservatrice, che chiede la restaurazione completa del potere temporale della Chiesa; l’altra più accomodante, disponibile a un compromesso ragionevole.
A complicare lo scenario interviene il meccanismo dei veti incrociati da parte delle grandi potenze: consuetudine plurisecolare, che si protrarrà fino al conclave del 1903, in cui costerà l’elezione al candidato super favorito, Mariano Rampolla del Tindaro, inesorabilmente cecchinato da Vienna dall’imperatore Francesco Giuseppe. Un “niet” che porterà alla nomina di Giuseppe Sarto, papa Pio X, nonostante fino all’ultimo avesse cercato di sottrarsi. Appena eletto, provvederà a revocare l’istituto del veto.
Ma quel giorno, a Venezia, i diktat sono più coriacei che mai. La mette giù dura da subito Francesco II, che da Vienna fa sapere di essere contro l’elezione di qualsiasi cardinale proveniente dai regni di Francia, Spagna, Due Sicilie, Sardegna, e perfino dalla repubblica di Genova; sostiene per contro la candidatura di Alessandro Mattei, giovane per il ruolo (55 anni), esponente di una famiglia vip dell’aristocrazia romana e papalina. Una parte consistente del collegio gli contrappone il pavese Carlo Bellisomi, 64 anni, arcivescovo di Cesena.
In una serie di scrutini, quest’ultimo ottiene la netta maggioranza di consensi, comunque al di sotto del quorum necessario per l’elezione. A questo punto viene stabilita una sospensione di una dozzina di giorni, per cercare di giungere a una mediazione; e i cardinali pro Austria si danno da fare per irrobustire i consensi a Mattei. Ci riescono, perché alla ripresa dei lavori i due contendenti si ritrovano pressoché affiancati ma comunque lontani dalla soglia prevista. Tra un tentativo e l’altro, passa tutto gennaio e pure metà febbraio; a metà mese, il 15, viene deciso di dar vita a una commissione composta da cardinali delle due fazioni, dando loro mandato di proporre ciascuna una rosa di cinque candidati.
Neppure questo è sufficiente: nessuno dei dieci nomi riesce a catalizzare un’adesione significativa. Per uscire dall’impasse, c’è chi mette in campo una soluzione per così dire istituzionale, proponendo il decano del collegio, Giovanni Francesco Albani, che tra l’altro è pronipote di un Papa, Clemente XI, morto nel 1721.
L’ipotesi si rivela da subito fragile; e a quel punto emerge la classica terza via, consistente nel cardinale Gregorio Barnaba Chiaramonti, 57 anni, cesenate, benedettino, vescovo di Imola. Raccontano le cronache che, quando gli viene comunicata la decisione, sbianchi letteralmente in volto e manifesti la volontà di non abbandonare la sua diocesi. Ma le sue resistenze vengono respinte, e la mattina del 14 marzo sale al soglio pontificio votato all’unanimità, prendendo il nome di Pio VII. Sarà un papa longevo: governerà la Chiesa per oltre 23 anni.
Riproduzione riservata © il Nord Est








