Un manifesto per rimettere il Veneto al centro dello sviluppo industriale
Lo studio elaborato per la Toscana mostra come le due regioni, pur diverse tra loro, soffrano di problemi analoghi. La programmazione è il solo strumento che può dare la vera autonomia
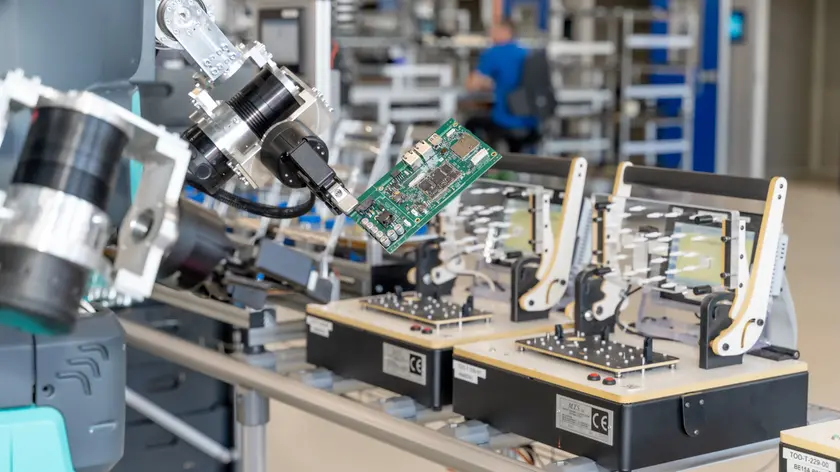
Il ritardo con il quale la coalizione di centrodestra sta (non) risolvendo la querelle interna per l’individuazione del candidato alla presidenza della Regione del Veneto sta impedendo di fatto che l’attenzione si sposti sul “che fare? ”, che si accenda un dibattito tra le parti che aspirano a guidare il Veneto nei prossimi dieci anni. Anni che tutti intuiamo essere cruciali nel contesto delle transizioni epocali tecnologiche, economiche e politiche che stanno già investendo l’Italia, l’Europa, il mondo.
Conviene allora far tesoro del dibattito che si sta svolgendo in casa d’altri. Utile per le molte possibili analogie di agenda la discussione avviata dalla pubblicazione all’Istituto Universitario Europeo di Firenze di “Reindustrializzare la Toscana. Un Manifesto”, firmato da Marco Buti, Stefano Casini Benvenuti e Alessandro Petretto. Confrontandoci con le dinamiche economiche toscane, emerge un quadro che impone anche al Veneto una riflessione strategica.
Veneto che pur partendo da una posizione migliore rispetto alla Toscana, non è immune dai rischi evidenziati dal documento fiorentino. Il primo campanello d’allarme riguarda “l’occupazione povera”, quella impiegata in settori con valore aggiunto per addetto inferiore al 75% della media nazionale – che rivela tendenze preoccupanti. «La Toscana ha effettivamente sviluppato una maggiore dipendenza da settori a basso valore aggiunto», conferma l’analisi. Ma anche il Veneto non può dormire sonni tranquilli: dal 2009 ad oggi l’occupazione povera è passata dal 12% al 21% attuale, seconda solo alla Toscana che è aumentata di 13 punti (dal 18% al 31%).
Entrambe le regioni condividono vulnerabilità strutturali che il manifesto identifica chiaramente. La crisi del modello europeo “export-oriented”, basato su energia a basso costo e catene lunghe del valore, colpisce sistemi produttivi aperti ai mercati globali come quello veneto. La “weaponisation” di commercio ed energia, accelerata dalle tensioni geopolitiche, mette sotto pressione distretti industriali che per decenni hanno prosperato nell’interconnessione globale. La frammentazione dimensionale rappresenta un altro elemento di convergenza. Il predominio di piccole imprese in filiere governate da altri caratterizza entrambi i territori, limitando il controllo sui prezzi e sui volumi produttivi.
Nel Veneto, come in Toscana, molte eccellenze manifatturiere rischiano la marginalizzazione quando le decisioni strategiche vengono prese altrove. Il Veneto parte da una situazione strutturalmente più solida. La diversificazione settoriale – con meccanica, alimentare, chimico-farmaceutico – offre maggiore resilienza agli shock settoriali rispetto alla concentrazione toscana su moda e farmaceutica. La distribuzione geografica dell’export, più equilibrata tra Germania, Francia e mercati emergenti, riduce l’esposizione ai dazi americani che colpiscono duramente la Toscana. La posizione geografica del Veneto favorisce l’integrazione con le catene del valore centro-europee e offre il vantaggio competitivo, anche se sottoutilizzato, del porto di Venezia per i collegamenti con Asia e Mediterraneo orientale. Vantaggi che la Toscana non possiede.
Ma, ed è qui che emerge il paradosso veneto, il policentrismo, storicamente punto di forza del modello di sviluppo regionale, rischia di trasformarsi in una “trappola strutturale”. La moltiplicazione dei centri decisionali genera inefficienze e impedisce politiche coordinate quando servono investimenti in Ricerca & Sviluppo, infrastrutture digitali e transizione tecnologica che richiedono scale maggiori. Quello che era un vantaggio nell’epoca della crescita estensiva dei distretti diventa un handicap nell’economia della conoscenza.
Un aspetto sottovalutato emerge anche dall’analisi del turismo. Nonostante la diversificazione geografica rispetto al modello toscano, anche il Veneto soffre di dinamiche estrattive simili. Le principali catene alberghiere di lusso appartengono a gruppi internazionali, le rendite immobiliari si concentrano (Venezia ne è l’esempio estremo), mentre i salari rimangono bassi anche nei segmenti premium. Ma c’è di più: il turismo veneto potrebbe diventare responsabile di uno “spiazzamento silenzioso” di talenti. Il settore assorbe laureati in economia, lingue, ingegneria gestionale in ruoli manageriali che, seppur apparentemente qualificati, offrono spesso percorsi di carriera limitati rispetto a settori tecnologici. Un ingegnere può preferire la direzione di un resort del Garda alla ricerca in biotecnologie, privando settori ad alto potenziale di risorse umane qualificate.
Le proposte del manifesto toscano richiedono significative calibrature per il Veneto. In tema di energia, per esempio. Senza la risorsa geotermica toscana, il Veneto dovrebbe puntare maggiormente su idroelettrico alpino, fotovoltaico in pianura e l’hub logistico-energetico del porto di Venezia. Le comunità energetiche rurali potrebbero sfruttare la diffusione territoriale delle imprese venete. Sul fronte della cosiddetta “import-substitution”, le politiche dovrebbero concentrarsi sui settori di forza regionali: tecnologie per l’automazione industriale, componentistica meccanica di precisione, biotecnologie agroalimentari. Il sistema universitario veneto richiede un approccio diverso da quello toscano: maggiore integrazione tra università tecniche e distretti industriali, rafforzamento dei poli di Padova e Verona nelle scienze applicate, sfruttamento della presenza di Ca’ Foscari per i servizi avanzati.
Ma la lezione più importante del confronto riguarda la governance. Mentre la Toscana può puntare su un coordinamento “naturale” attorno a Firenze, il Veneto deve affrontare la sfida di superare le resistenze localistiche per politiche regionali coordinate. Il Veneto ha bisogno più della Toscana di attrezzarsi per “un coordinamento verticale fra livello regionale, nazionale e comunitario”. Un approccio a “matrice” che leghi fra loro obiettivi e strumenti dovrebbe essere la base di un piano regionale di sviluppo che anticipi i piani nazionali e regionali richiesti dalla Commissione europea per l’utilizzazione delle risorse del futuro bilancio multiannuale comunitario: la sola fonte di finanza pubblica straordinaria nel dopo Pnrr.
La programmazione, piena di proposte anche per le politiche statali e comunitarie, sepolta nel Veneto dall’inizio del millennio, è il solo strumento che può dare al Veneto l’autonomia, il decidere dei propri destini, che ha inutilmente cercato gli venisse concesso dallo Stato negli anni trascorsi.
Il Veneto ha ancora i numeri dalla sua parte: diversificazione industriale superiore, geografia economica più equilibrata. Ma i trend sono chiari: senza interventi strutturali, anche la regione nordestina rischia di scivolare verso la “terziarizzazione povera” che già affligge altre aree del Paese. Il manifesto toscano non offre ricette prêt-à-porter, ma traccia un metodo: pensare strategicamente prima che i problemi diventino irreversibili. Per il Veneto, è ancora tempo di prevenire piuttosto che curare. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © il Nord Est



