La regina triestina dei nanosatelliti: «Le missioni spaziali serviranno a lanciare i distretti sostenibili»
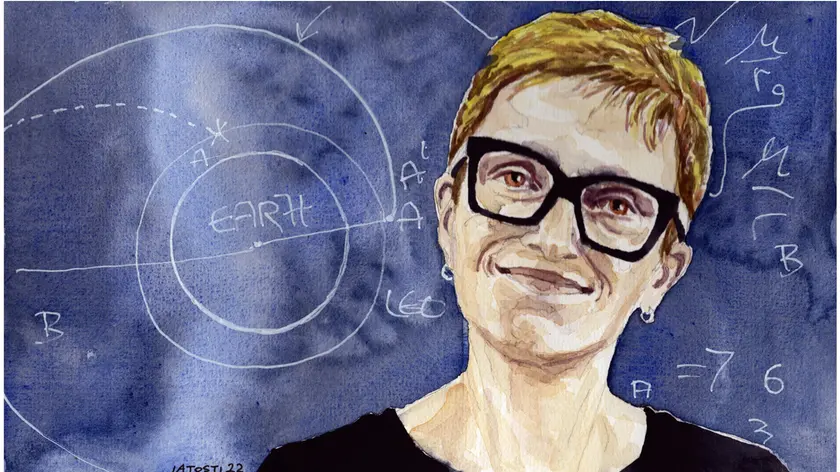
È la regina triestina dei nanosatelliti. Anna Gregorio, docente di Astrofisica spaziale all’Università di Trieste, fondatrice e ad di Picosats, è stata inserita tra le 50 donne più influenti nel mondo della tecnologia in Italia.
Gregorio ha fondato e guida Picosats, startup di successo ad alta tecnologia nata in Area Science Park, che sviluppa e produce piccoli satelliti pesanti 50 chilogrammi in grado di trasmettere dati a velocità molto elevate.
Dopo la laurea in fisica delle particelle e un dottorato di ricerca alla Normale di Pisa, ha vissuto una lunga esperienza al Cern di Ginevra guidato da Carlo Rubbia. In Olanda, all’università di Delft, ha preso un master in ingegneria dei sistemi spaziali. Gregorio, che molti hanno definito la “nuova Margherita Hack” di Trieste, appartiene all’eccellenza scientifica e manageriale triestina: uno dei suoi compagni di studi in fisica è stato Cristiano Borean, oggi Chief financial officer delle Assicurazioni Generali.
Gregorio, lei ha collaborato per diversi anni con l’Agenzia spaziale europea. La space economy muove oggi circa 450 miliardi di dollari di investimenti, destinati a diventare quasi 1 trilione di dollari nei prossimi anni. Come coniuga la sua attività di ricercatrice e imprenditrice?
«Dieci anni fa ho coordinato i gruppi che operavano sugli strumenti a bordo delle missioni Euclid e Planck dell’Agenzia Spaziale Europea. Fu una vera impresa che considero, da appassionata di montagna e velista, la mia vera scalata dell’Everest come scienziata. A quel punto ho pensato naturale concentrarmi su nuove sfide in altri settori diventando anche imprenditrice».
L’immaginazione corre alle grandi imprese spaziali che oggi hanno forse perso il fascino di una volta. Quali applicazioni industriali provengono dalle grandi missioni nello spazio?
«La crescita della tecnologia aerospaziale si traduce in diverse applicazioni industriali perchè non è più soltanto il prodotto di modernissimi e costosissimi laboratori di ricerca. A esempio oggi diverse componenti elettroniche concepite per i mezzi aerospaziali, che una volta avevano costi elevatissimi, possono essere prodotte anche nelle nostre filiere industriali, ad esempio in settori come l’automotive, e possono essere usate con molta efficacia anche nello spazio riducendo di molto i costi, accettando ovviamente una vita inferiore di questi prodotti, come i satelliti, accettando rischi come quello delle radiazioni».
La corsa allo spazio non è più confinata in luoghi come Cape Canaveral?
«Dallo spazio abbiamo una vista unica su tanti fenomeni e non solo l’effetto di terremoti e tsunami. Grazie all’osservazione dallo spazio sono riusciti a scoprire infiltrazioni durante gli scavi per l’ampliamento della metropolitana di Parigi. Pensi al fatto che durante il lockdown globale a causa della pandemia per la prima volta abbiamo potuto osservare la terra dallo spazio senza lo schermo scuro dell’inquinamento, dalle polveri sottili e del prodotto industriale delle attività umane. Abbiamo potuto scoprire come potrebbe essere più abitabile la terra».
Ci sarà una nuova corsa allo spazio per migliorare la nostra qualità della vita?
«Dobbiamo rendere la terra un posto migliore e la corsa allo spazio può avere questo obiettivo. Oggi l’avventura spaziale è diventata sinonimo di eco-sostenibilità. L’osservazione dell’atmosfera dallo spazio è di fondamentale importanza per prevenire ad esempio il problema del clima impazzito. La meteorologia spaziale, legata anche alle variazioni dell’attività solare, si basa proprio sull’osservazione dai satelliti. Da velista consulto spesso le previsioni del Consorzio toscano Lamma con il quale sto lavorando su un progetto che studia il contenuto di vapore acqueo nell’atmosfera alla base di molte ricerche sul clima».
Di recente un fondo italiano di venture capital focalizzato sulle tecnologie per la sostenibilità, ha condotto un round di investimento di tipo seed in Picosats per un 1 milione. Come pensate di crescere?
«Il settore aerospazio sta suscitando l’interesse dei grandi fondi stranieri e europei. Non abbiamo fretta. La nostra crescita deve avvenire in modo sano graduale. Siamo una azienda dinamica dove lavorano numerosi giovani appassionati e di talento».
In Italia investiamo abbastanza nel mondo della ricerca?
«Picosats è nata proprio per creare un ponte fra mondo imprenditoriale e mondo della ricerca. Ma penso anche agli importanti accordi siglati a Trieste fra la Sissa, l’università e l’Area di ricerca. Ricordo anche l’accordo fra i centri di ricerca del territorio per la creazione di un Data Science Hub con la regia del Cfo di Generali Cristiano Borean».
A cosa ambisce Picosats?
«Il nostro progetto vuole avere anche un ruolo di promozione e sviluppo dell’industria aerospaziale a Trieste, una città di eccellenza dal punto di vista accademico e della ricerca scientifica. Da qui può nascere un nuovo modello di sviluppo per la creazione di un’importante ecosistema industriale anche nel settore dell’aerospazio. Vedo un grande interesse anche da parte degli investitori. La stessa crescita del porto di Trieste può produrre importanti effetti di contaminazione fra scienza e industria».
Riproduzione riservata © il Nord Est








