Accade che il genius loci si nasconda nelle acque: storia di Venezia e Napoli
L’anima marina delle due città raccontata in un saggio: a confronto arte, passioni, immaginari che non ti aspetti, a firma di Egidio Ivetic e Luigi Mascilli Migliorini

Le tendenze editoriali delle più grandi case editrici italiane da tempo prediligono le opere di divulgazione alle grandi trattazioni scientifiche. Non fa eccezione la storia, per la quale vi è una forte attenzione in un’ampia fetta di lettori: per soddisfarne le esigenze si preferiscono opere di sintesi, agili, evocative, senza particolari rimandi bibliografici. Non si discosta da questa impostazione anche Il destino del mare. Napoli e Venezia, scritto a quattro mani da Egidio Ivetic e Luigi Mascilli Migliorini per il Mulino (€ 16). In questo divertissement i due studiosi mettono in parallelo i molti elementi di continuità, ma anche di discontinuità, che uniscono le due città, avvicinate anche nella cultura e nell’arte.
Che Napoli e Venezia abbiano avuto e abbiano il mare nel proprio destino è fuor di dubbio. Ma se ne differenziano molto nelle origini e nell’evoluzione odierna. Da un lato c’è Partenope e il mito della sirena, dall’altro i primi insediamenti di rifugiati che si perdono altrettanto nella leggenda, in mezzo però ci sono quindici secoli dalla Neapolis greca al medioevo di Rivo Alto e dintorni.
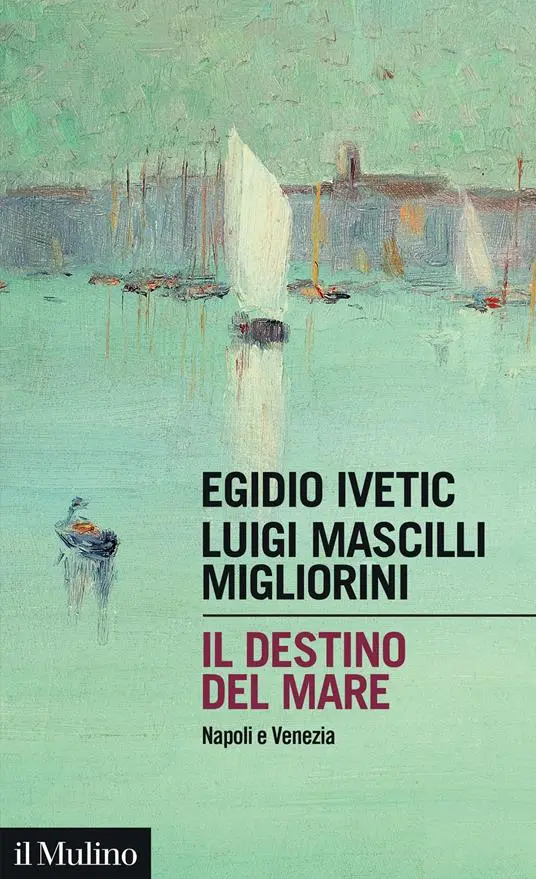
Il Mediterraneo è la cifra di entrambi, quando sono libere e sovrane, ma anche quando sono suddite e sottomesse. Alti e bassi, mai sincronici, come nei diversi esiti del Settecento, dove il riformismo borbonico fu superiore ai Lumi veneziani, ma la Serenissima offrì il vedutismo di Guardi e Canaletto, il teatro di Goldoni e della Fenice, il ruolo di capitale dell’editoria, la musica di Vivaldi, mentre la raffigurazione di Napoli entrava nell’immaginario europeo anche grazie al Grand Tour, trovando la sua massima espressione nel periodo napoleonico, quando Gioacchino Murat e sua moglie Carlotta mettevano la città e il golfo al centro delle rappresentazioni di una generazione di artisti uscita dalla rivoluzione francese, contribuendo a superare quel pregiudizio che già allora affiorava, per cui come scriveva un viaggiatore scontroso «L’Europa finisce a Napoli e vi finisce anche male».
Luigi Mascilli Migliorini, accademico dei Lincei, professore emerito all’Orientale, sa però che Napoli è anche spleen, e pur se il binomio vita & morte non tocca l’apice veneziano, i partenopei conoscono la nostalgia. Una malinconia che ha origini in Goethe e più ancora in Alphonse de Lamartine e Madame de Staël, che legano a Mergellina e al Vesuvio amori irrisolti e rimpianti che la scuola di Posillipo e i pittori che vi si ispirano nel corso dell’Ottocento fissano sulla tela. E poi c’è l’emigrazione del XX secolo, che all’inizio del secolo breve esploderà nella celeberrima “Torna a Surriento” dei fratelli De Curtis. Uno spleen e una vitalità che emergono oggi anche nel cinema di Mario Martone e Paolo Sorrentino.
Egidio Ivetic, origini istriane, docenza padovana e frequentazioni veneziane per studi e per la direzione dell’istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano della Fondazione Cini, ha una visione meno positiva del destino marino di Venezia di quanto abbia il collega Mascilli Migliorini per Napoli. Certo, anche Venezia ha avuto molti doni da Nettuno, il mare prima di tutto, che domina per sette, otto secoli. E poi la pace sociale, che ha preservato la Dominante da rivolte alla Masaniello. O essere quel punto di unione tra Oriente e Occidente, non appartenendo a nessuno dei due, attraverso «l’arco veneziano» che Ivetic tende da Venezia al Levante, passando per le coste istro-dalmate. Un sistema integrato, sul piano economico, sociale e linguistico che superava i dualismi tra litorale ed entroterra, sia a Chioggia o Grado che a Rovigno, Montona o Cattaro, rendendo semplicistiche le contrapposizioni nazionaliste dell’Ottocento.
Dopo il 1797 Venezia ha perso la dimensione del mare, anche se, scrive Ivetic, si è illusa di mantenerlo sino alla seconda guerra mondiale, anche grazie ai miti dannunziani e alla nascita di Porto Marghera. «Oggi Venezia e il mare sembrano due cose diverse, per quanto unite», in cui la politica e il resto della regione Veneto sembrano decidere, prendendosi una rivincita sull’antica Dominante, ed escludendo di fatto il mare, e in parte il suo porto, dai dibattiti politici, ridotto a business di crociere, dimenticando, ad esempio, il ruolo dei container. Solo tornando al mare, insomma, conclude Ivetic, si potrà abbandonare la nostalgia per una nuova rinascita.
Riproduzione riservata © il Nord Est




