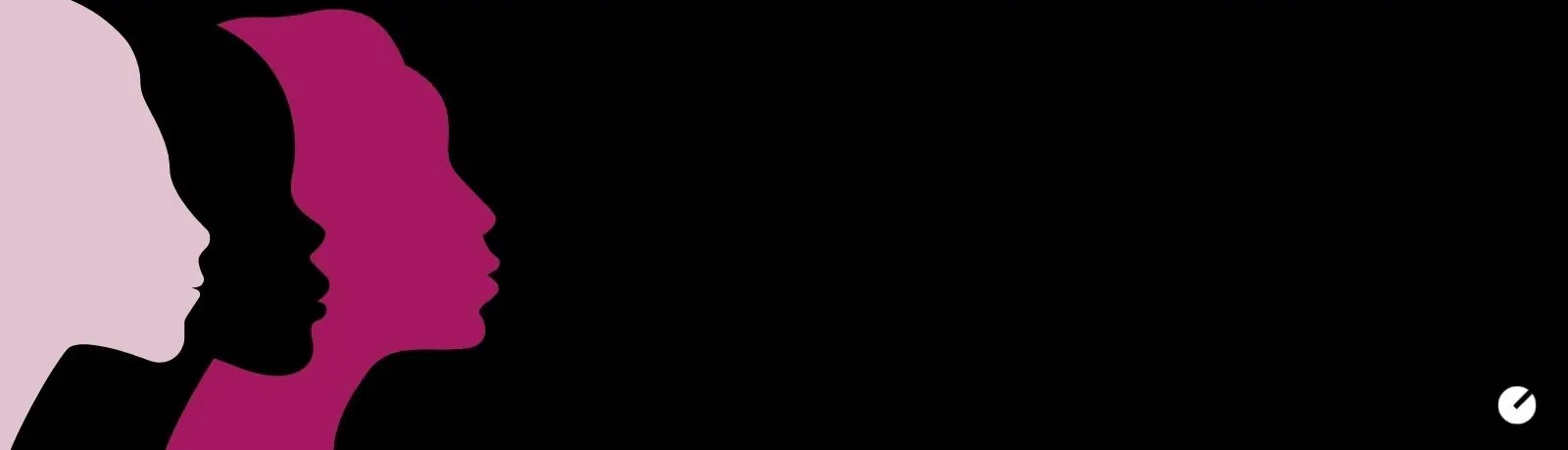Anna, Julia, Silvia e le altre. Una vita dietro le sbarre e il coraggio di raccontarsi
Le testimonianze delle detenute del carcere della Giudecca a Venezia: i fallimenti, i mariti o i compagni violenti, la voglia di riscattarsi. Le parole di Marta, condannata a 30 anni: «Quando sono entrata qua, mi sono sentita per la prima volta libera»

Si passano il microfono, applaudono, spronandosi l’una con l’altra a raccontarsi. Alcune hanno la voce sicura, altre inciampano nella pronuncia di una lingua che non padroneggiano ancora del tutto. Gli interventi sono lunghi, come se volessero cogliere l’occasione di essere ascoltate per tirare fuori quello che hanno dentro. Un passato ingombrante, ferite che diventano voragini e, infine, reati.
Le detenute della casa di reclusione femminile della Giudecca si sono raccontate ai due candidati del Pd alle Regionali, Monica Sambo e Gabriele Bolzoni, e all’eurodeputata dem Alessandra Moretti, che ha rotto il ghiaccio parlando dei propri fallimenti, da quelli personali alla sconfitta politica del 2015, quando era in corsa per la presidenza della Regione. «Quando perdi, sei sola. Vivi una profonda solitudine, io pensavo di lasciare la politica, invece quel fallimento mi è servito e mi ha dato la spinta per migliorarmi».
Una ventina di detenute l’ascoltano, facendo spazio con le sedie alla nuova direttrice Maurizia Campobasso, annuendo quando Moretti dice che «sul corpo delle donne si giocano le guerre più spietate».
Loro, d’altronde, lo sanno bene. Julia viene da Cracovia e dei suoi 35 anni in Italia, 13 li ha trascorsi con un uomo violento, un boss della criminalità organizzata. «Se mangiavo, dovevo farlo fuori, come i cani», racconta, aggrappandosi al microfono per non farsi travolgere dai ricordi. «L’avevo denunciato, ma poi l’ho fatto tornare a casa pensando che fosse cambiato. Lo era, ma in peggio. Smetteva di picchiarmi solo quando vedeva uscire il sangue. Non avevo più la forza per difendermi».
Anna, invece, è mestrina ed è cresciuta immersa nella violenza, con davanti agli occhi l’immagine del padre che picchiava la madre. Poi è arrivata la cocaina, i due anni vissuti in strada, gli stupri, una gravidanza continuando a drogarsi, una bambina che non sapeva di volere e che oggi è stata adottata, ma a cui pensa tutti i giorni. «Sono qui perché ho tirato un pugno a mio padre mentre ero fatta, ma in carcere dovrebbe esserci lui», sbotta.
Silvia, trentenne mestrina, racconta di essere stata due mesi con «un maledetto». Lo chiama sempre così, perché, dice, non sa come definirlo in altri modi. «Ho sempre avuto il coraggio di denunciare», spiega con la voce decisa, «ma le forze dell’ordine non mi hanno mai aiutato e la situazione è peggiorata, si faceva trovare sotto casa mia alle sei di mattina, fuori dal lavoro, ovunque. Ero completamente fuori di me per questa situazione, me la prendevo con mia mamma e mio fratello e solo io so i rimorsi di coscienza che ho, perché loro mi sono ancora vicino».
Sono storie di marginalità, di donne che sono state bambine cresciute ai margini, sempre sull’orlo del precipizio. Ana ha 32 anni, sei figli in Romania ed era solo una ragazzina quando ha iniziato a rubare. «Ho accumulato reati dal 2008, quando ero ancora minorenne. La fine della mia pena sarà nel 2032, per ora ho fatto tre anni».
Per Ana, Silvia, Julia e tutte le altre 97 detenute della Giudecca, il carcere è spesso il primo luogo in cui sentono di avere un ruolo, un’identità, una prospettiva. «Quando sono entrata qua, mi sono sentita per la prima volta libera». È Marta a dirlo, composta e riservata, ha varcato la soglia della casa di reclusione nel 2016 con una pena di 30 anni per aver commesso un grave reato. Dopo una vita immersa nella violenza, ci sono volute le sbarre alle finestre per farle ritrovare la libertà. Ecco, allora, il carcere che rieduca, insegna, ascolta.
Riproduzione riservata © il Nord Est