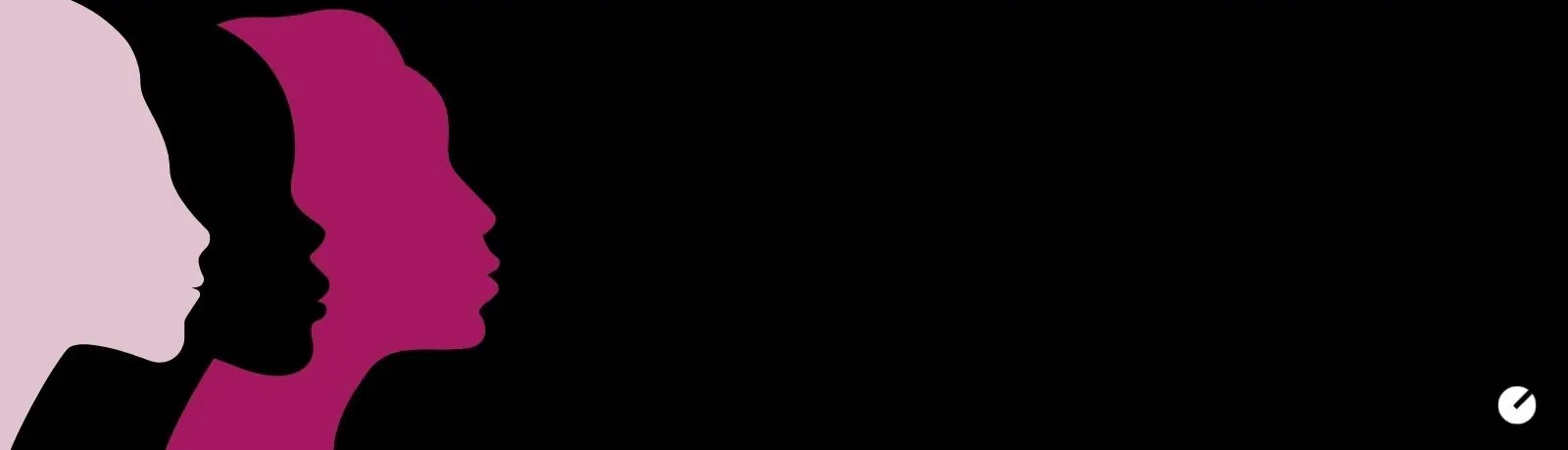Violenza sulle donne: leggi, linguaggio e cultura. Perché la giustizia da sola non basta
Dalla prevenzione al ruolo del linguaggio giuridico: il contrasto alla violenza di genere come responsabilità collettiva

La violenza sulle donne rappresenta una delle più gravi e diffuse violazioni dei diritti umani. Non è solo un tema di genere: è una questione che investe l’intera società, minando i principi di uguaglianza, rispetto e dignità della persona su cui si fonda la convivenza civile. Affrontare questo tema significa riconoscere la sofferenza delle vittime ma anche impegnarsi nel promuovere una cultura del rispetto, della parità e della responsabilità collettiva. L’educazione e la prevenzione devono essere poste al centro dell’azione istituzionale, perché solo il coinvolgimento di tutte le istituzioni può produrre risposte efficaci e durature.
Privilegiare non solo la repressione, ma anche la formazione e la prevenzione, è una scelta lungimirante: significa intervenire sulle cause profonde della violenza, sulle rappresentazioni culturali, sugli stereotipi che ancora la sorreggono. In quest’ottica di competenza, formazione e prevenzione, desidero ricordare che il Consiglio Superiore della Magistratura è fortemente impegnato su questi temi, con iniziative specifiche e linee guida operative.
L’efficacia
Come giuristi, siamo chiamati a interrogarci anche sull’efficacia dell’apparato normativo attuale, oggi ricco e articolato. Basti pensare alle riforme del 2019 con il “Codice Rosso”, che introduce l’audizione della vittima entro tre giorni e nuovi reati come il revenge porn, la costrizione al matrimonio e la deformazione dell’aspetto. O ancora al 2025, con l’introduzione del reato autonomo di femminicidio, punito con l’ergastolo quando motivato da odio o discriminazione di genere. Sorge dunque la domanda: il nostro sistema giuridico è davvero idoneo a rispondere a questa emergenza? E, soprattutto, era necessaria una fattispecie autonoma come il femminicidio?
Dal punto di vista strettamente tecnico, si potrebbe ritenere che tale norma sia in parte superflua: l’ordinamento già prevedeva strumenti idonei a punire severamente omicidi e violenze di genere. Il rischio è sempre quello che nuove fattispecie producano effetti più simbolici che sostanziali.
Come insegna l’esperienza, le norme – pur severe e dettagliate – non sono mai risolutive da sole. La vera sfida è culturale. Le leggi sono necessarie, ma non sufficienti. La giustizia non risana: la giustizia riequilibra. Rimedia al torto, ma la ricostruzione del legame sociale è un compito che non può essere devoluto alla giurisdizione.
All’estero
Per questo, quando si discute di prevenzione generale nel diritto penale, dobbiamo guardare anche alle esperienze straniere. Paesi dove vige la pena di morte non registrano minori tassi di omicidio: spesso accade il contrario. Ciò dimostra che l’inasprimento della sanzione non produce automaticamente sicurezza. Da qui la necessità di evitare un affidamento salvifico alle norme penali. Tuttavia, la funzione simbolica della norma resta importante: il reato di femminicidio ha avuto il merito di accendere i riflettori su una realtà drammatica, rendendola visibile e scuotendo la coscienza pubblica. Anche se tecnicamente non indispensabile, ha rafforzato l’attenzione istituzionale sulla specificità della violenza di genere e promosso un dibattito culturale e giuridico più ampio. Ma il simbolismo normativo, da solo, non basta.
Per comprendere la violenza contro le donne dobbiamo considerare l’intero fenomeno, non solo la sua cornice giuridica.
La violenza non nasce nel vuoto: affonda le radici nella storia del Paese, nei modelli educativi, nelle aspettative sociali che per decenni hanno definito i ruoli maschili e femminili. La violenza contro le donne, d’altra parte, non è un fenomeno circoscritto a determinate aree geografiche o momenti storici: è endemica, trasversale, presente in ogni società, tanto in tempo di pace quanto nei conflitti armati.
Fino agli anni ’70 – e in parte ancora oggi – la giurisprudenza è stata segnata dal “mito dello stupro”: l’idea che un vero stupro abbia caratteristiche precise (uno sconosciuto, la notte, violenza fisica evidente, una donna “perbene” che resiste fino allo stremo). Chi non corrisponde a questa immagine diventa meno credibile. È la donna che “se l’è cercata”. Molte forme di sottomissione psicologica non sono ancora riconosciute come penalmente rilevanti, e sarebbe un errore pensare che tutto ciò che è lesivo, umiliante o oppressivo debba necessariamente tradursi in reato.
Il riconoscimento
Ci sono dimensioni che appartengono alla cultura, non al codice penale, e che devono essere affrontate attraverso formazione, consapevolezza, prevenzione. Ma ciò che conta, oltre agli strumenti giuridici, è la capacità di riconoscerlo culturalmente.
Un aspetto culturale fondamentale è quello del linguaggio. Il linguaggio giuridico non è mai neutro: riflette la visione del mondo di chi lo utilizza e può, consapevolmente o meno, perpetuare stereotipi e discriminazioni, soprattutto di genere.
Il linguaggio non è mai innocente. Le parole modellano la realtà, contribuiscono a renderla visibile o invisibile. In ambito giudiziario, questo effetto è amplificato: una sentenza, un verbale, una motivazione possono legittimare o distorcere ciò che è accaduto. Per anni, la violenza di genere è stata raccontata attraverso espressioni che la normalizzavano: “lite familiare”, “raptus”, “passione incontrollabile”. Queste parole spostano lo sguardo dall’autore alla vittima, o peggio, trasformano l’autore in un soggetto travolto dalle emozioni, attenuando la responsabilità individuale.
Quando negli atti processuali si adotta un linguaggio emotivo che enfatizza lo stato d’animo dell’autore (“era frustrato, esasperato, amareggiato, geloso”), si compie una scelta che sposta lo sguardo dall’atto criminale – botte, insulti, denigrazioni, umiliazioni – al vissuto soggettivo di chi scrive. È un travisamento che sostituisce alla realtà una scala valoriale personale e non un dato oggettivo.
Distorsioni
Un linguaggio distorto – che interpreta il femminicidio come esito di amore travolgente, gelosia, raptus – non solo ostacola il corretto inquadramento giuridico dei fatti, ma offre una lettura stereotipata che riduce la responsabilità dell’autore.
La violenza non nasce mai da un eccesso di amore: nasce da un sistema di dominio, da una visione proprietaria e gerarchica dei rapporti affettivi, da un modello culturale che pretende che l’uomo difenda il proprio ruolo sociale attraverso il controllo della donna.
È un linguaggio che riecheggia quello dell’ambiente culturale da cui il reato trae origine: una narrazione che rappresenta la morte di una donna come l’esito eccezionale – e in parte comprensibile – della sofferenza di un uomo “derubato” della sua identità. In questo rovesciamento simbolico, l’imputato può apparire come un soggetto fragile, ferito dall’autonomia femminile; un uomo spinto dalla società a “reagire”, perché altrimenti verrebbe meno alla propria virilità e al ruolo che la cultura patriarcale gli assegna.
La retorica
È una costruzione retorica che finisce per dissolvere la responsabilità individuale e per occultare la volontà punitiva maturata nei confronti di una donna ritenuta colpevole di avere infranto il ruolo che la tradizione le attribuisce. Ed è un linguaggio che, se non riconosciuto e corretto, rischia di normalizzare, comprendere e perfino giustificare la violenza.
Il magistrato deve, quindi, sempre ricordare che l’esercizio autonomo e indipendente della giurisdizione ha una ricaduta nella società civile. E allora l’esercizio deve essere fatto in modo responsabile, quella che Luciano Violante ha definito “responsabilità sociale del magistrato”. L’uso equilibrato del giudizio e del linguaggio nel processo sono prerequisito di un uso corretto della giurisdizione.
Accanto a queste riflessioni è necessario mantenere saldo un altro principio: il processo penale è costruito sulle garanzie dell’imputato. È sufficiente la sola parola o testimonianza della parte offesa, ancorché coerente nel proprio narrato, in assenza di riscontri esterni (per esempio certificati medici) per ritenersi raggiunta la prova della violenza e, dunque, della responsabilità penale dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio? Pensiamo ai casi in cui la violenza si assume perpetrata sotto minaccia e, dunque, senza l’opposizione della donna all’atto sessuale. A ben vedere si scontrano due narrazioni di segno opposto.
I capisaldi
Per questo dobbiamo promuovere educazione, cultura e formazione – tra magistrati, forze dell’ordine, avvocati – ma senza disperdere i capisaldi del nostro sistema: il primato della libertà, il rispetto della prova formata nel contraddittorio delle parti, il principio del ragionevole dubbio. La giustizia è chiamata a muoversi con umiltà e prudenza. Sentimenti ed emozioni costituiscono un materiale umano “magmatico”, che impone attenzione alle sfumature, ascolto empatico e sospensione del giudizio. Serve un linguaggio che nomini la violenza senza mascherarla. Serve una giustizia che riconosca le vittime anche quando non rispecchiano modelli femminili o culturali precostituiti e socialmente omologati.
Il progresso c’è stato, ed è enorme. Il progresso però non è mai definitivo: è un processo. E questo processo richiede responsabilità collettiva, lucidità culturale e la capacità di guardare alla violenza non come un incidente, bensì come il prodotto di un sistema che dobbiamo continuare a cambiare. Solo così – cambiando cultura, parole e sguardi – potremo cambiare davvero la realtà. E questo è il compito più alto che ciascuno di noi deve assumere come propria responsabilità.
Fabio Pinelli,è il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura: interverrà al convegno organizzato dall’Università di Padova su“Violenza, Salute e Sanità”.
Riproduzione riservata © il Nord Est