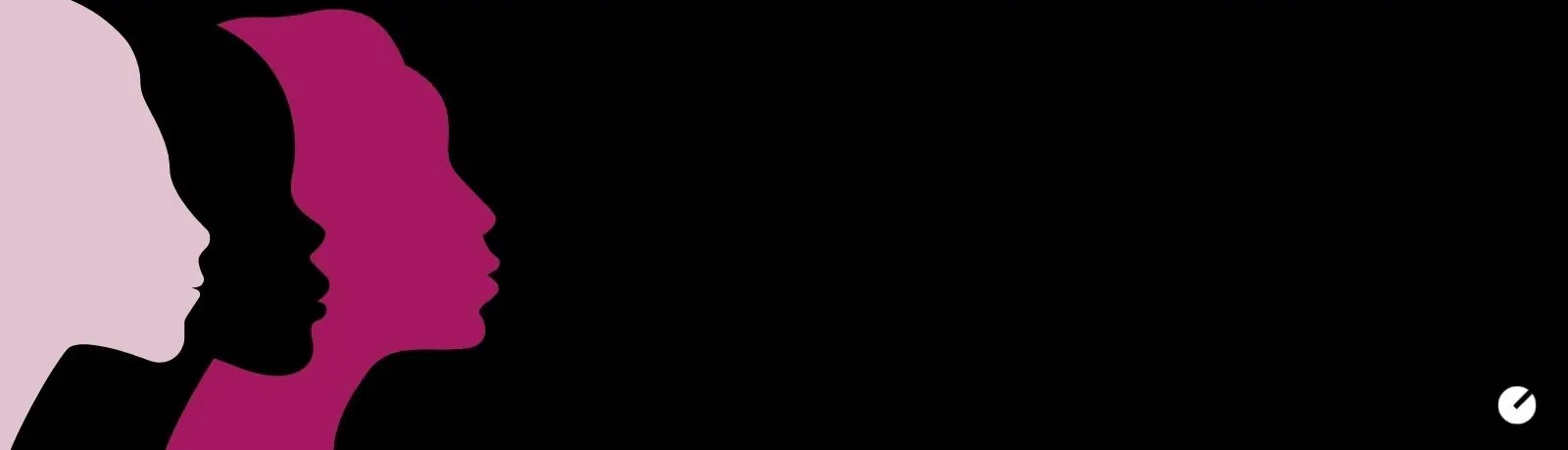Tra cura, potere e sapere: una storia plurale delle donne nella medicina
In “Medicina femminile plurale” Daniela Minerva, giornalista e scrittrice, ripercorre la storia della medicina dal punto di vista delle donne, mostrando come la cura sia stata a lungo pratica senza potere e sapere senza riconoscimento. Un libro che rifiuta miti consolatori e narrazioni binarie, e interroga i criteri con cui la scienza decide che cosa conta come sapere legittimo

La storia della medicina è spesso raccontata come una storia neutra, universale, progressiva. Medicina femminile plurale (Medicina femminile plurale. Il sapere delle donne nella storia, Bollati Boringhieri, 22 euro, 355 pagine) mostra perché questa neutralità è, in realtà, una costruzione.
Daniela Minerva, giornalista e scrittrice, non si limita a chiedere dove fossero le donne, ma interroga le regole con cui, nei secoli, si è deciso che cosa potesse essere considerato sapere medico.
Agnodice, Ildegarda di Bingen: figure spesso evocate come grandi donne della medicina, non c’è dubbio alcuno.
Ma il libro rifugge i santini da sfoggiare e i miti consolatori che sono diventati la cifra di un certo femminismo contemporaneo. Minerva non indulge nelle scorciatoie.
La traiettoria del libro è precisa: la cura delle donne nella storia è prima azione senza potere, poi sapere senza riconoscimento. Viene quindi espropriata, medicalizzata, trasformata in campo di battaglia della biopolitica. Solo più tardi rientra nella scienza, e lo fa cambiandola.
In mezzo, le storie di donne spesso celebrate solo come anticipatrici di una medicina femminile, più utili a costruire miti che a spiegare processi storici. Non a caso, osserva Minerva, «cercare di ridare vita a singole scienziate operanti nei secoli scorsi è anacronistico, perché applica al passato la nozione moderna di “scienziato”. E, comunque, di “scienziato” maschio».
Per l’autrice, queste figure restano ambivalenti: eccezioni rese possibili solo a patto che il sapere delle donne passi attraverso un’autorizzazione esterna, religiosa o simbolica.
Il punto, però, non è dimostrare che le donne “c’erano”, né moltiplicare biografie esemplari. Il cuore del libro sta altrove: nel momento in cui la medicina occidentale decide che cosa può essere considerato sapere legittimo.
Quando la cura quotidiana si separa dalla teoria, quando ciò che è scritto, sistematizzato e istituzionalizzato diventa scienza e ciò che resta pratico, domestico, situato viene retrocesso a empiria o folklore, lo sguardo femminile viene espulso non perché inefficace, ma perché privo di statuto.
È qui che nasce l’esclusione strutturale che Minerva ricostruisce lungo i secoli: non dall’assenza delle donne, ma dalla definizione stessa di medicina.

«Le mani femminili che per secoli hanno nutrito, allevato, curato», scrive, «sono state anche le stesse che hanno sperimentato, osservato, mescolato sostanze». Ma questo sapere, aggiunge, non è mai diventato sapere che conta.
È nell’Ottocento che questa esclusione diventa pienamente visibile nei corpi.
Con la nascita della medicina moderna, degli ospedali e della sanità pubblica, la cura smette di essere soltanto risposta al dolore e diventa strumento di governo.
Il corpo femminile viene definito, classificato, normalizzato: la riproduzione diventa affare di Stato, la maternità una funzione da sorvegliare, le fasi della vita categorie mediche da interpretare e controllare.
Le donne continuano a farsi carico della salute quotidiana, ma perdono progressivamente ogni autorità sul proprio corpo, trasformato in oggetto di un sapere che parla su di loro, raramente con loro. È il momento in cui, come sintetizza Minerva con chiarezza, «la medicina entra nella vita non solo per curare, ma per governare». È qui che la cura diventa biopolitica.
A questa espropriazione segue una reazione comprensibile. Dopo secoli in cui la medicina ha parlato del corpo delle donne senza ascoltarle davvero, cresce una distanza, a volte una diffidenza. Minerva mostra che non nasce dal nulla, né da una presunta irrazionalità femminile: è il risultato di una lunga storia di esclusione dal sapere sul proprio corpo. Ma il libro non si ferma a questa constatazione.
Quando questa distanza diventa rifiuto della medicina in quanto tale, non produce libertà. Al contrario, espone a nuove fragilità.
«Delegittimare la medicina», avverte Minerva, «significa consegnare il corpo delle donne a nuovi rischi». La critica alla medicina è necessaria; la sua delegittimazione, no.
Se la distanza dalla medicina è una reazione, non è però l’ultima parola. Minerva mostra come, tra Otto e Novecento, le donne rientrino nello spazio sanitario da un’altra porta, meno visibile ma decisiva.
Non è ancora l’ingresso nella professione medica, ma nell’organizzazione della cura: infermiere, riformatrici sociali, filantrope, figure che costruiscono ospedali, reti assistenziali, servizi di prevenzione.
È in questo lavoro, spesso considerato “di contorno”, che prende forma l’idea moderna di salute come bene comune. La cura, da pratica privata, diventa una questione collettiva.
È nel Novecento che questo movimento trova finalmente uno sbocco esplicito. Le donne entrano nella professione medica, nella ricerca scientifica, nei luoghi in cui si produce sapere. E il cambiamento non è solo quantitativo.
Minerva insiste su un punto preciso: non è l’ingresso delle donne in sé a trasformare la medicina, ma le domande che portano con sé. Quando il corpo femminile smette di essere una variazione del modello maschile e diventa oggetto di studio a pieno titolo, emergono i limiti di una medicina che si era pensata neutra.
«Il corpo maschile», scrive Minerva, «è stato a lungo assunto come norma, e proprio per questo invisibile».
È il caso, tra gli altri, della cardiologia: sintomi, diagnosi e terapie costruiti su quel modello si rivelano insufficienti a curare le donne. Qui la questione di genere smette di essere rivendicazione simbolica e diventa questione scientifica.
In questo passaggio, lo “sguardo dell’angelo” evocato da Minerva trova finalmente una collocazione storica precisa.
Non come nostalgia di un passato perduto, né come alternativa alla scienza, ma come ciò che accade quando l’esperienza della cura entra nei luoghi del sapere. Per secoli quello sguardo è rimasto accanto ai corpi senza poter incidere sulle regole. Quando entra nella medicina, cambia statuto: diventa attenzione clinica, revisione dei modelli dati per universali, capacità di interrogare ciò che era rimasto invisibile.
La posizione di Minerva è così fuori dal cuore di una narrazione binaria che oggi domina il dibattito su medicina e genere.
Da una parte, la rimozione storica e istituzionale del contributo delle donne, spesso accompagnata da una difesa non problematizzata della neutralità della scienza; dall’altra, una critica radicale che, nel denunciare la medicina come dispositivo di potere, rischia di tradursi in una sfiducia generalizzata verso la scienza stessa.
Medicina femminile plurale rifiuta entrambe le semplificazioni. Non cerca una mediazione rassicurante, ma sposta il piano della discussione: dal conflitto tra posizioni contrapposte all’analisi dei criteri con cui il sapere medico si è costruito e continua a operare.
La conclusione del libro resta volutamente aperta. Medicina femminile plurale non propone una medicina altra, né una riscrittura identitaria della storia.
Propone piuttosto uno spostamento di sguardo: interrogare la medicina nei suoi criteri di legittimazione, chiedersi chi ha potuto parlare, chi è rimasto ai margini, e con quali conseguenze.
È un libro che non consola e non assolve, ma invita a tenere insieme critica e responsabilità. Perché una medicina che ignora una parte dell’esperienza non è neutra: è incompleta. E riconoscere questo limite non significa indebolire la scienza, ma chiederle di essere all’altezza del suo compito.
L’autrice

Daniela Minerva è giornalista e saggista. Dirige la piattaforma Salute, online e in edicola con la Repubblica e La Stampa, ed è editorialista di la Repubblica. In precedenza è stata vicedirettrice di Sapere e caporedattrice de L’Espresso. È tra le fondatrici dell’Associazione Donne e Scienza. Tra i suoi libri: La ricerca di Eva, La fiera delle sanità, Il fuoco dentro e Il bagnino e i samurai.
Riproduzione riservata © il Nord Est