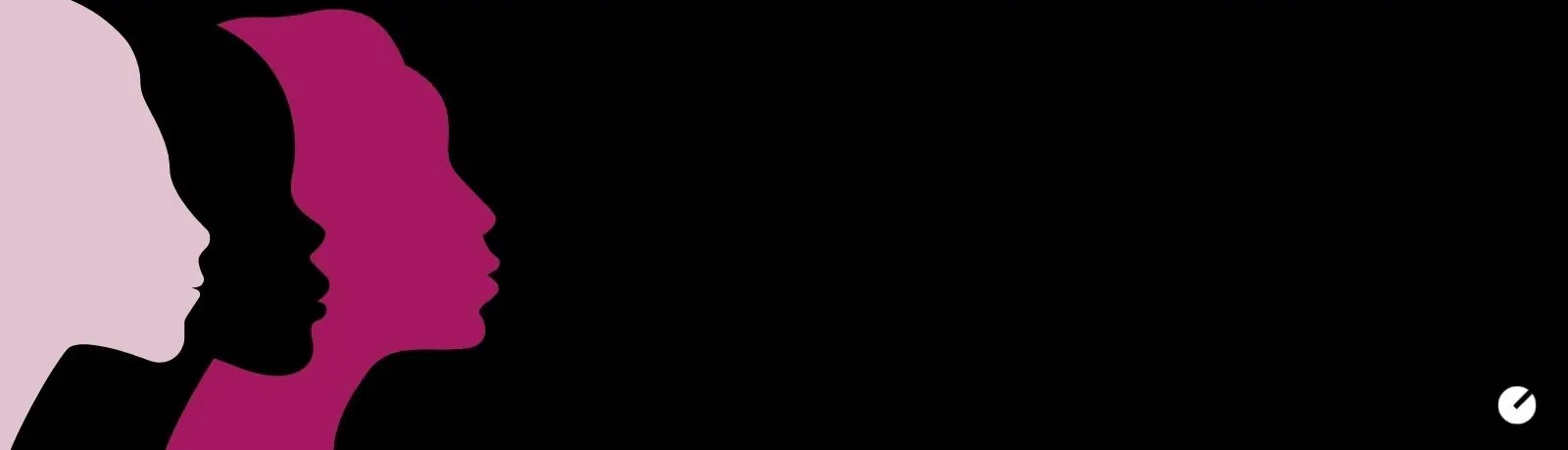Dal Libano in Italia, Rayan Alayan: «Porto la mia casa dentro di me. E ogni giorno combatto per la pace»
Fuggita dal Sud del Libano a 18 anni, oggi mediatrice culturale a Padova, Rayan racconta cosa significa convivere con la guerra, aiutare i bambini palestinesi feriti e credere che anche una sola voce possa cambiare le cose

Lei arriva dal sud del Libano, invaso nel 1982 da Israele e poi di nuovo al centro degli scontri fino ad oggi. Cosa significa per Rayan Alayan convivere con la guerra? Ed è per questo che ha dovuto andarsene dal suo Paese?
«Convivere con la guerra significa convivere con la paura ogni giorno, non sai cosa succederà domani e nemmeno tra un’ora. Ma non sono solo i bombardamenti. La guerra è anche economica, è la crisi che il Libano ha attraversato quando ho deciso di partire. Lasciare il mio Paese è stata una necessità, non una scelta. Quando sogni un futuro che la tua terra non può offrirti, te ne vai. Ed è quello che è successo, avevo 18 anni e mezzo».
Perché ha scelto Padova?
«Qui ha studiato e qui vive una zia. Padova è una città particolare: abbastanza grande da offrire opportunità e abbastanza piccola da non farmi sentirmi persa. E ora è la mia casa».
L’ultima impressione salutando il suo Paese a 18 anni.
«Lasciare il Libano è stata durissima, ho pianto. C’era la nostalgia e c’era la colpa di lasciare la mia famiglia in una situazione di guerra. Ma arrivando qui sapevo di trovare qui il futuro che volevo per me».
E quale futuro vorrebbe?
«Un futuro in cui posso lavorare e avere le opportunità che offrono le cose importanti. Un futuro in cui posso aiutare la mia famiglia. Un futuro dove posso essere libera e soddisfatta di quello che faccio. Vorrei arrivare a 80 anni potendo dire che ho vissuto la mia vita, senza rimpianti».
Ha trovato differenze nei sogni, nelle aspettative, nelle preoccupazioni, rispetto ai suoi coetanei italiani che vivono da 80 anni in un mondo di pace?
«Le differenze sono tante perché partiamo da condizioni diverse, che non abbiamo scelto. Loro sognano il lavoro, il viaggiare, l’essere indipendenti, la libertà e la serenità. Anche noi. Ma noi impariamo a sopravvivere il presente. Le loro famiglie sono al sicuro, la mia è in Libano. Se si esce la sera io telefono a mia mamma: “Hanno bombardato? come state?”, le mie domande. Non riesco a essere serena, a non pensare, a divertirmi e basta. I miei coetanei sì, perché sono cresciuti nella pace, beati loro. Da noi gran parte delle famiglie ha perso qualcuno, io uno zio».
Stanno ancora bombardando a casa sua?
«Sì al Sud, la mia città è devastata e mi chiedo cosa resti da bombardare. La mia famiglia è sempre lì, si è spostata di poco, non vuole lasciare quella terra. La nostra casa è stata distrutta tre volte: nell’82, nel 2006 e poi di nuovo ora. Ma papà sta pensando di ricostruirla. Per la quarta volta. Io volevo tornare a casa quando è iniziata la guerra, papà non ha voluto. Mi ha detto: “Se moriamo tutti, resterai tu”. E mamma mi diceva “mi manchi da morire, ma ti preferisco lontana e al sicuro, piuttosto che vicina e in pericolo”. È da mia madre, Iman, che ho imparato a essere luminosa anche quando intorno era buio e a non abbassare mai la mia testa».
Lei è mediatrice culturale, in questi mesi ha operato accanto ai bimbi palestinesi feriti dalla guerra. C’è una storia, una frase che l’hanno colpita di più?
«L’idea della mediazione linguistica è nata perché ero appassionata di lingue, mandai il curriculum per fare esperienza. Così ho conosciuto il dottor Lobascio che mi ha aperto la porta su questa causa. Aveva una coop con i bimbi di Gaza, cercavano una mediatrice. E lì ho incontrato, Shaymaa, 10 anni. La mia piccolina».
Cosa si porterà di lei?
«Tutto. In un anno mi ha insegnato più di quello che ho imparato in 22 anni di vita. Lei a causa della guerra ha perso un braccio e una gamba: non so spiegare il sentimento che ho provato vedendola camminare per la prima volta con le protesi, dopo un intero anno di interventi e fisioterapia. Tutto quel coraggio in un corpicino così piccolo, così ferito: non lo dimenticherò mai, lo porterò con me per sempre. Shaymaa è un simbolo».
Di cosa?
«Di tutto ciò che la guerra vuole distruggere, ma anche di tutto ciò che la vita riesce a far rifiorire. È fantastica questa bimba: era piccola, terrorizzata, analfabeta ed è diventata una bambina forte che cammina e corre, che scrive. È stato un grande percorso».
Poi sono arrivati gli altri bambini e molti in queste settimane.
«Tra gli altri Ahmed che è rimasto ustionato nei bombardamenti. Ho dormito con lui in ospedale per più di due settimane perché la mamma ha altri due gemelli piccoli da seguire e facevamo i turni. Lui si svegliava durante la notte, piangendo per il dolore. Mi diceva “ho male, ma non chiamare nessuno”, aveva paura».
I medici stanno curando le loro ferite. Ma che futuro li aspetta ?
«I medici a Padova e in tutta Italia hanno fatto un lavoro bellissimo. Le ferite fisiche guariscono, ma quelle dell’anima restano. Sono bambini, hanno bisogno di noi. Hanno il futuro incerto, dobbiamo accoglierli, abbracciarli, amarli, per aiutarli a guarire. È difficile, ma non impossibile. È una sfida».
Ha trovato solidarietà?
«Padova è accogliente e vicina. Nell’ottobre del 2023 siamo scesi in strada per chiedere il cessate il fuoco: eravamo solo arabi e palestinesi. All’ultima manifestazione gli italiani erano più di noi».
Dal palco della biennale di Gaza, a palazzo Zuckermann, ha chiamato tutti a combattere per la pace. Ma che speranza ha la ribellione individuale di fronte all’immobilismo dei Grandi del mondo?
«Anche una goccia scava la pietra, se cade ogni giorno. È una frase che ho sentito all’inizio della guerra e che papà mi ha spiegato quando dicevo che ero da sola, che non potevo fare niente. Non è così. Io, noi, siamo questa goccia e le rivoluzioni più grandi iniziano sempre con un piccolo gesto. Ogni voce, ogni gesto contano. In arabo si dice: una persona con un pensiero giusto e aperto vale più di mille persone con un pensiero chiuso e sbagliato. E anche se è un passo piccolo, facciamo la nostra parte nel come raccontiamo, parliamo, boicottiamo, abbracciamo e proteggiamo i bambini. La strada più lunga inizia con un passo piccolo. E arriveremo al traguardo, anche se i potenti non si muovono».
Ma la situazione, dopo il coinvolgimento dell’Iran, è diventata molto complicata.
«O riusciamo a cambiare qualcosa, a fermarli, o saranno guai per tutti. Non solo per il Medioriente. Credo che nessuno voglia davvero la terza guerra mondiale».
Con questo scenario potrà mai tornare a casa?
«Non ho mai smesso di sentirmi a casa, la porto sempre con me (mostra la catenina con il ciondolo del cedro del Libano). Penso spesso di rientrare, ma vorrei tornarci come donna libera che ha fatto delle cose per il suo Paese. Quella è la mia terra, se io non ci torno e se gli altri se ne vanno a chi la lasciamo? Non la ritroverò come l’ho lasciata, ma sarà sempre la mia terra. E ci tornerò: sono la figlia di un padre che ha costruito la sua casa tre volte nello stesso posto».
Non crede che per una donna sia più facile vivere in Occidente sotto il profilo dei diritti? Pensiamo all’Iran o all’Afghanistan.
«È vero, in Occidente ci sono diritti che altrove molte donne sognano. Ma non possiamo parlare di un Oriente unico. Ciascun Paese ha la sua cultura, la sua legge. E differenze esistono anche nello stesso Paese. Come d’altra parte in Occidente non sempre e non ovunque è così facile: razzismo e sessismo esistono».
Ma qual è la sua esperienza?
«Sono musulmana, ma ho studiato dalle suore e poi ho fatto il liceo in una scuola musulmana. Questo succede in Libano, dove culture diverse convivono in pace. Probabilmente non è lo stesso in altri Paesi arabi. Io non porto il velo perché non lo voglio e i miei rispettano le mie decisioni».
Riproduzione riservata © il Nord Est