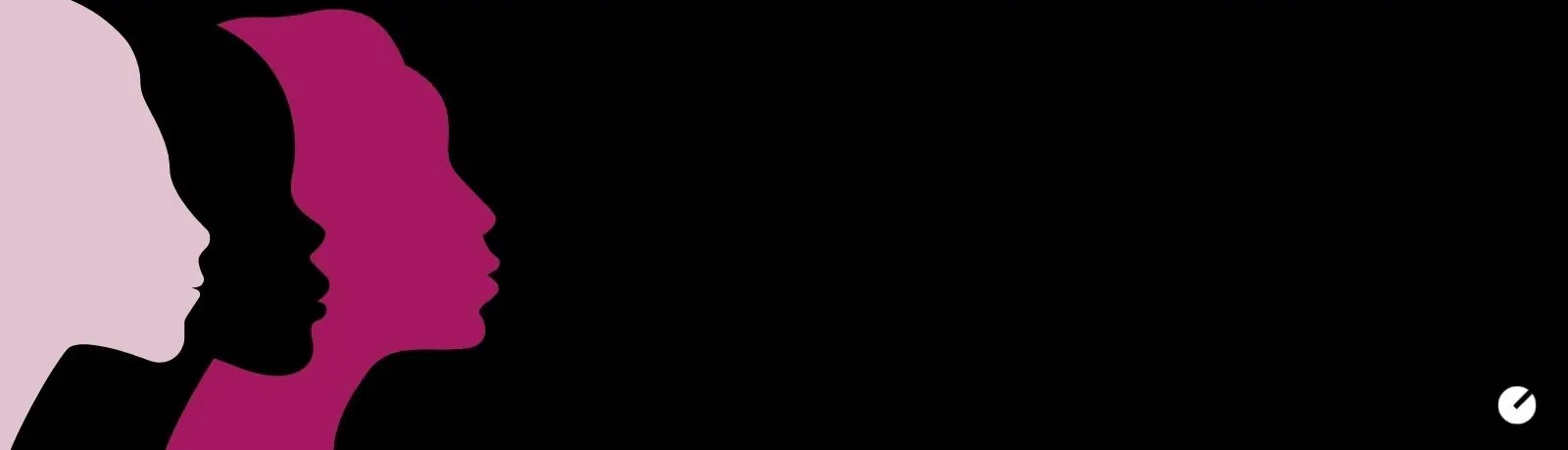Volti rubati e corpi falsi: la nuova violenza digitale colpisce (ancora) le donne
Martina Semenzato, la presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, spiega le nuove frontiere della violenza digitale e il senso del flash mob “Non con la mia faccia”: «Senza consenso è reato, serve una legge veloce come la tecnologia»

Martina Semenzato è la presidente della “Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere”. 52 anni, originaria di Spinea e laureata in Scienze Politiche a Padova, è anche presidente della vetreria Salviati di Murano ed ex presidente della sezione vetro della Confindustria di Venezia-Rovigo. In passato è stata dirigente della Reyer Venezia e per dieci anni presidente della Scuola del vetro "Abate Zanetti".
Il 5 novembre ha avuto luogo a Roma il flash mob "Non con la mia faccia". Quali sono stati gli obiettivi della mobilitazione?
«L’obiettivo è stato quello di portare la voce univoca di donne che non hanno paura di denunciare. E’ stato organizzato dal gruppo dal gruppo Giornaliste Italiane, perché ad essere coinvolte in siti sessisti sono state diverse croniste. Le donne venivano spogliate con l’intelligenza artificiale e la loro faccia veniva messa in un corpo non loro. Questo fenomeno fa parte di un’inchiesta portata avanti dalla Commissione, a partire dai siti sessisti comparsi la scorsa estate. Tra questi la pagina Facebook "Mia moglie" e il caso dei video registrati dalle telecamere di sorveglianza private che sono stati pubblicati sul dark web. Durante la manifestazione ognuna di noi ha messo la propria faccia, affermando che se non diamo il consenso siamo davanti ad un reato. Lo hanno messo anche colleghe molto note, che fanno da testimonial in sostegno alle altre donne che non hanno avuto il coraggio di denunciare».
Lo slogan dell'iniziativa: “Prevenire, sensibilizzare, denunciare”. Come?
«Il fenomeno si può prevenire. Va fatto un lavoro sull’educazione digitale, tema che coinvolge tutte le generazioni: la prevenzione passa anche dall’irrobustire la responsabilità di chi gestisce le piattaforme. La prevenzione passa anche dal nostro lavoro a livello parlamentare, vogliamo che l’accesso su ogni sito avvenga con l'identità. Oggi è fondamentale identificare con più facilità chi si nasconde dietro i profili online, quindi l'accesso deve avvenire con nome e cognome. Dobbiamo cominciare a rendere le maglie di questa rete più strette. Oggi la legge deve essere veloce, per seguire i tempi della tecnologia. Stiamo assistendo nel concreto all’applicazione della Legge 132 dello scorso settembre. Questa punisce con una pena da 1 a 5 anni chi manomette e carica sul web contenuti sessisti».
Sono diversi i casi di registrati a Nord Est nell’ultimo periodo, ne è a conoscenza?
«Non penso che la violenza digitale abbia una territorialità, perché scollina il perimetro delle nostre case. Credo che questo aspetto sia marginale rispetto al ruolo che gioca in altre forme di violenza. Non conosco personalmente i casi delle violenze online, se non quelli più famosi. Il mio lavoro si limita all’inchiesta e a tracciare un percorso, implicando una certa segretezza».
Che fotografia restituisce oggi l'Italia sulla violenza di genere?
«L'Italia rimane tra i paesi più virtuosi nel contrasto contro la violenza di genere, sia dal punto di vista legislativo, che dal punto di vista economico e di investimenti: oggi sono 100 milioni di euro. Nel nostro Paese vedo una profonda reattività sociale, scossa sicuramente da casi come quello di Giulia Cecchettin. Ci sono moltissime iniziative, oggi si parla di violenza di genere tanto e sempre».
Quali sono i dati?
«I dati dei primi nove mesi del 2025, condivisi dall'Unità anticrimine, evidenziano dei numeri in caldo e confermano il trend degli ultimi anni. Sono diminuiti del 20 per cento gli omicidi di donne, del 24 per cento quelli in ambito familiare, e i femminicidi del 18 per cento. I dati comunque non consolano, saremo felici solo quando nessuna donna verrà uccisa o maltrattata. Sono inoltre aumentate le denunce e gli ammonimenti da parte dei questori: anche questa è una forma di prevenzione che viene adottata nei confronti di chi offende, dopo il primo campanello d’allarme».
Tra le linee guida della Commissione vi è una particolare attenzione nei confronti della violenza economica.
«Sì, da parte nostre c’è grande sensibilità sulla violenza economica. C'è ancora tanto da fare ma stiamo tracciano un percorso. Questa è forse la prima forma di violenza e viene difficilmente riconosciuta dalle donne stesse. Infatti, il 72 per cento delle donne vittime di violenza non sono indipendenti economicamente, e non rendendosene conto non denunciano. Inizia questo percorso di isolamento che argina la donna nella sua autodeterminazione».
Qualche esempio?
«Lavorare all'interno di ditte di famiglia, in situazioni nelle quali non si percepisce alcun reddito. Ci sono anche casi drammatici come quello di fare da prestanome al partner, firmando documenti dei quali non si conosce bene natura: multe intestate (pur non avendo commesso l’infrazione), leasing, mutui… Bisogna puntare sull’educazione finanziaria di genere e sui percorsi di empowerment femminile, tante donne non conoscono gli interventi che ci sono a vantaggio di chi subisce violenza. Di solito ci si interessa alle questioni fiscali in coppia, quando è il momento di comprare casa o un’auto».
Quello della violenza di genere è sicuramente un fenomeno a matrice culturale, su quali livelli bisogna lavorare?
«Il rispetto va amplificato nelle aule scolastiche a partire dalle famiglie. Bisogna insegnare a rispettare i “no”, questo vale anche anche alla fine di una relazione. E' una questione di cultura e del rispetto verso il prossimo, che va oltre la violenza di genere. Se impariamo ad avere rispetto dell'altra persona, la violenza di genere non avviene. Siamo diventati una società che risolve con il conflitto, ma invece va fatto nel confronto».
***
La legge 132 alla quale si è fatto riferimento, è stata introdotta il 23 settembre 2025. Reca disposizioni in materiale di intelligenza artificiale e ha previsto l’introduzione, all’art. 612-quater c.p., di una nuova fattispecie incriminatrice di «illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale», volta a sanzionare – con la pena della reclusione da uno a cinque anni — «chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità».
Riproduzione riservata © il Nord Est