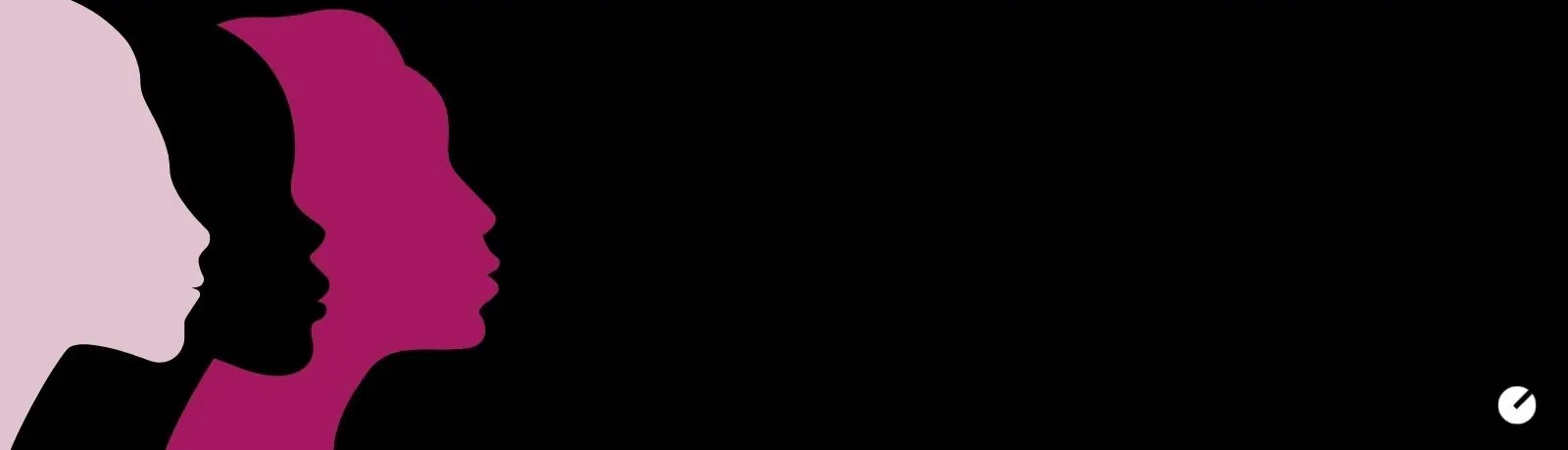La prorettrice Thiene: «Laurea europea, l’università veneta guida la nuova sfida»
La professoressa dell’ateneo padovano partecipa al progetto per il debutto del titolo. E si occupa di ranking: «Danno visibilità mondiale, grande attesa per il Qs»

Mara Thiene, lei ha un ruolo molto rilevante per l’Università di Padova: è delegata per i ranking. Quanto contano per l’immagine di un Ateneo?
«I ranking danno sicuramente visibilità a livello mondiale e hanno un’ottima capacità di rappresentare in modo semplice realtà molto più complesse. Le motivazioni per cui sono importanti non sono legate solo al posizionamento in classifica: certo danno prestigio, ma rendono più attrattiva la sede universitaria per i ricercatori, sono rilevanti per gli studenti, in particolare per quelli stranieri che guardano i ranking in modo sistematico. E ancora: sono un riferimento per le aziende in fase di assunzione che considerano la qualità dell’università. Infine lo stesso Ateneo li usa come “cartine di tornasole”: i dati raccolti sono di supporto alla governance nei processi decisionali».
L’Università di Padova oggi ha ottimi posizionamenti, quali sono i parametri che la rendono forte?
«I principali ranking sono quattro: QS, THE, ARWU, US News Best Global Ranking, quest’ultimo seguito soprattutto dagli studenti americani. I parametri di riferimento sono la produzione scientifica, i dati dimensionali come il rapporto docenti-studenti, le indagini reputazionali con dati raccolti presso le comunità accademiche e le aziende, i premi Nobel. Abbiamo fatto benissimo con ARWU, un salto di fascia, entrando nei 200. Facciamo bene nella produzione scientifica e nelle indagini reputazionali. Mostriamo più difficoltà rispetto alle università americane o cinesi sui dati dimensionali. Sono valori strutturali, legati al fatto che non abbiamo tasse elevate, sistemi di selezione di accesso o elevata disponibilità di fondi. Altro nostro punto di forza è il forte aumento di studenti stranieri, ottenuto ampliando l’offerta formativa in inglese. Abbiamo 62 corsi di laurea interamente in lingua e tra questi molti sono titoli doppi, multipli».
Qual è, fra i tanti, il ranking che attende con maggiore preoccupazione?
«Direi QS perché ha impatto mediatico enorme; il traffico web che viene generato è tre, volte superiore a quello degli altri, l’impatto sulla stampa è più elevato e ha una rete di relazioni internazionali».
Come siete messi con il QS?
«Abbiamo migliorato tre posizioni».
La Commissione europea ha lanciato la laurea europea. Un’opportunità anche per le nostre università?
«Si tratta di una nuova normativa. La Commissione ha stabilito che tale titolo può essere chiesto solo dai joint degreee programs, una tipologia di corsi di laurea internazionali. Per accedervi serve inoltre la rispondenza a certi criteri. L’università di Padova è stata selezionata, con l’alliance ARQUS, per far parte di uno dei sei progetti pilota finanziati dalla Commissione Europea, con l’incarico di testare i criteri. È importante aver contribuito a definire le regole del gioco, fa sì che ci troviamo pronti per proporre corsi di laurea che soddisfino questi criteri».
Importante non è solo attrarre, ma anche trattenere gli studenti stranieri. Il CLA, di cui lei è presidente, cosa può fare?
«Il CLA si occupa della certificazione linguistica e in quest’ultimo anno ha offerto corsi di lingua italiana per gli studenti stranieri, con oltre 2.600 iscritti. Un modo per trattenere qui gli stranieri che si formano da noi. Un investimento».
Lei è presidente del corso di laurea in Food&Health. Quali sono oggi le sfide più urgenti nel collegare alimentazione e salute, e come la ricerca universitaria può contribuire ad affrontarle?
«La qualità degli alimenti e la loro composizione, influenzano la salute, questo lo sappiamo. Una nutrizione corretta permette di prevenire importanti patologie, impattando sulla salute pubblica. Faccio riferimento per esempio a obesità, diabete, problemi cardiovascolari, che incidono sull’economia pubblica. La sfida è creare figure nuove, capaci di coniugare saperi che derivano dalla formazione agro-alimentare con quella medica. Il nostro corso coinvolge otto dipartimenti, per garantire tutte le competenze. Siamo partiti nel 2021 con più di 500 domande da studenti stranieri e negli ultimi due anni le domande sono più di mille».
Qual è un mito o un malinteso comune sul cibo sostenibile e la nutrizione che vorrebbe sfatare?
«C’è un dibattito molto forte sui cibi ultraprocessati. Senza negare gli aspetti negativi, i docenti medici a Food&Health insegnano che i derivati del latte come lo yoghurt, per esempio, non vanno osteggiati a priori. Hanno sì ingredienti che servono ad aumentarne la durata, ma possono essere fortificati con micronutrienti, calcio, vitamine per migliorare la qualità dell’alimentazione. Insomma, serve un approccio scientifico. Penso anche al dibattito sull’importanza delle etichette nutrizionali, che rischia di essere un po’ sterile. Chi le legge davvero? Probabilmente chi è già attento alla nutrizione. Invece bisogna escogitare altre modalità per raggiungere tutti».
In un’epoca di cambiamento climatico e crisi ambientali, come può la quantificazione del valore delle risorse naturali, su cui lei fa ricerca, guidare le scelte politiche ed economiche?
«Le risorse ambientali, come per esempio l’acqua, hanno un valore economico. Che non è la tariffa, ma che è legato al concetto di bene pubblico e risponde a più bisogni: l’acqua serve per bere, ma anche per fornire cibo alla fauna ittica, per la purificazione, per il sequestro del carbonio, per il benessere ricreativo... Sono tutte componenti multifunzionali che sfuggono ai meccanismi di mercato. Con la nostra ricerca quantifichiamo i benefici sociali dal punto di vista economico. In Inghilterra hanno modificato la tariffa dell’acqua, che ora è calcolata non solo su parametri tecnico ingegneristici, ma anche su alcune di queste componenti sociali. Come quantificarle? La tariffa tiene conto, tra le altre cose, della qualità ecologica dei fiumi o dell’utilizzo per balneazione. In questo modo le componenti ambientali cominciano a essere introdotte per definire il valore del bene».
Qual è il gesto più semplice che ciascuno di noi può fare ogni giorno per valorizzare e proteggere le risorse ambientali?
«Stiamo lavorando a un progetto di ricerca europeo per sviluppare un mercato di crediti blu con venditori e compratori di crediti. Oltre ad agricoltori e aziende, principali attori di questo mercato, anche noi cittadini possiamo essere chiamati a generare dei crediti, mettendo in atto una serie di azioni volte, per esempio, a risparmiare acqua. Come? Utilizzando smart meters per efficientare l’uso dell’acqua oppure dotandosi di sistemi di rilevazioni delle perdite. I Comuni potrebbero in qualche modo incentivare i cittadini sostenendoli economicamente».
Lei è impegnata con la ricerca, con l’insegnamento, e i ruoli istituzionali. Come fa a tenere tutto in equilibrio, anche con la vita privata?
«Ho una famiglia molto comprensiva. E sono fortunata, perché lavoro con gruppi di ricerca giovani e molto bravi. Così come il personale amministrativo. Non fai niente da solo. Poi, certo, riesco a ottimizzare le tempistiche».
Ma le resta tempo libero?
«In qualche modo lo ricavo, mi piace molto la montagna, cerco di trovare il tempo per le escursioni».
Una proiezione sul futuro: come vede le nostre università fra 50 anni?
«Ci attendono sfide importanti, come il declino demografico, ma ci stiamo attrezzando bene. La visione del futuro è impegnativa, ma positiva». —
***
Chi è
La professoressa Mara Thiene, vicentina , è laureata a Padova in Scienze Agrarie. È diventata professoressa ordinaria nel Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (Tesaf) dell’Ateneo patavino nel 2018. È delegata ai joint degree e ranking internazionali e ha ricoperto incarichi internazionali come visiting professor in Australia.
È inoltre prorettrice delegata ai programmi Erasmus e ai Joint degree. È coordinatrice del corso internazionale magistrale Food and Health e responsabile di gruppi di ricerca su scenari energetici sostenibili.
Riproduzione riservata © il Nord Est