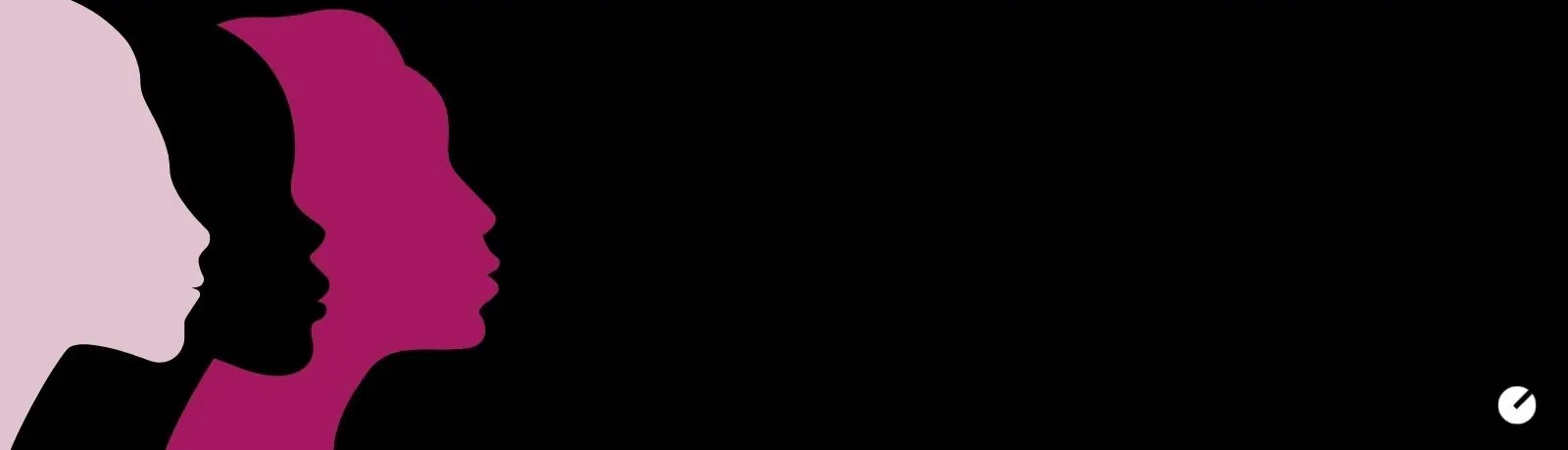Maria Gabriella Lusi: «Il carcere che vorrei è fatto di umanità e gioco di squadra»
La direttrice del carcere Due Palazzi di Padova: «La leadership femminile esprime una forza che non è muscolare ma che è capace di incidere sul sistema». E sui suicidi in cella: «Sono una sconfitta che mai vorremmo subire. Occorre prenderci cura delle persone»
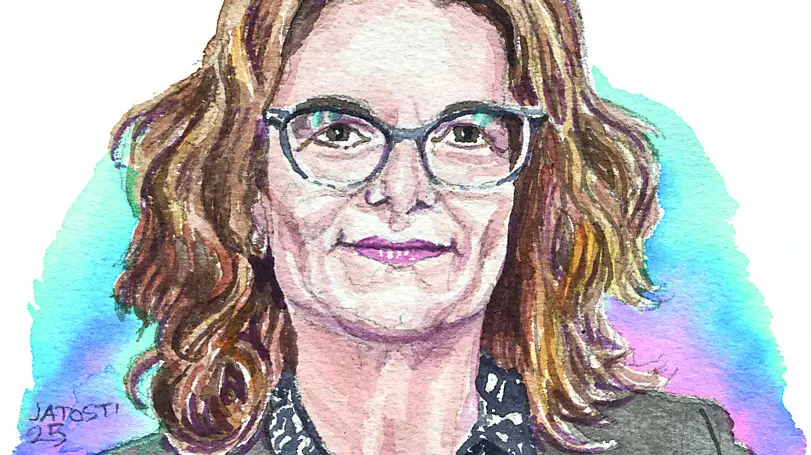
Maria Gabriella Lusi quanto ha influenzato la sua scelta professionale l’ultima, indimenticabile, scena del film Brubaker, con l’illuminato direttore del carcere (Robert Redford) costretto ad andarsene, ma accompagnato dagli applausi dei detenuti?
«Le narrazioni sul carcere mi hanno sempre incuriosita, stimolata e, da cittadina, a tratti anche preoccupata. Nel tempo, con l’esperienza professionale, ho maturato la convinzione che il direttore possa e debba essere un riferimento per la struttura anche sul piano delle relazioni e dell’umanità. Tutte le volte che ho percepito di aver raggiunto questo obiettivo, allora, la spinta emozionale che ne ho ricavato è stata davvero grande. Sono convinta che ogni direttore debba puntare al benessere dell’organizzazione nel suo complesso e che possa farlo agendo a un tempo sia sul personale che sui detenuti. Gli applausi degli uni favoriscono gli applausi degli altri. Quando si agisce sul benessere delle persone si favorisce quello dell’intero contesto umano e organizzativo. E il benessere non è mai scontato ma è sempre raggiungibile, costituendo il fil rouge delle nostre giornate di lavoro».
Ci racconti la prima emozione del primo giorno del primo carcere in cui è entrata.
«È accaduto a Parma, 28 anni fa, era settembre. La prima cosa che ho percepito è stata la curiosità che il contesto mi rivolgeva. Mi colpì l’attenzione con cui mi accolsero, in termini di garbo e di preoccupazione affinché l’impatto fosse positivo. E di questo ancora ringrazio il direttore dell’epoca. Ebbi la sensazione che mi sarei trovata di fronte a una sfida personale importante: restare me stessa in un contesto nuovo e complesso, per quanto quel contesto fosse molto più civile di quanto immaginassi. Capii subito che i miei sforzi professionali dovessero mirare a non lasciare che il contesto prevalesse sul mio modo di essere, ma che dovessi usare ogni energia affinchè io potessi agire sullo stesso per orientarlo verso gli obiettivi dell’amministrazione».
Ancora Brubaker: «Si possono accettare i compromessi sulle strategie non sui principi». A lei è capitato?
«Certamente sì, ma parlo di compromesso in termini non negativi, intendendolo come possibilità di gestione, ovvero di “chiusura” ordinata, composta e pacifica di situazioni problematiche. Se è sostenuto da principi “sani” declinati in obiettivi di lavoro, il compromesso è utile se non necessario. D’altronde in un’organizzazione complessa occorre tenere in equilibrio le diverse esigenze; inoltre attraverso il compromesso si definisce la possibilità di nuove alleanze, individuando nelle stesse non già l’idea di “movimenti contro altri”, ma di relazioni che servono a fare squadra, a sviluppare intese, sinergie. Il compromesso inoltre significa spesso uso del buon senso».
La leadership femminile può portare cambiamenti nel sistema penitenziario?
«Credo che in generale la donna sappia esprimere una forza che non è muscolare, autoritaria, ma capace di incidere sul sistema perché trova le sue “gambe” nella capacità di motivare, di essere coerente, resiliente, trasparente e soprattutto nella volontà di comunicare e di farlo con coraggio».
Nella relazione 2024 il Garante per i diritti della persona del Veneto indica nel circondariale di Padova un sovraffollamento del 126%, a Treviso del 183% a Verona del 179%. Un direttore non può risolvere problemi in capo ad altri. Però si deve misurare quotidianamente con essi. Come li gestisce?
«Non saremmo dirigenti se non dovessimo affrontare problemi anche molto significativi. E un’organizzazione complessa come il carcere raramente prospetta assenza di problemi importanti come è appunto il sovraffollamento. Alla Reclusione di Padova i numeri sono ancora tollerabili, inoltre dietro a ciascun numero - ergo, detenuto - è possibile intravedere “vita”, seppur penitenziaria, grazie ad un importante investimento sulle attività del trattamento. La vita dei detenuti assume aspetti di qualità diversi - anche - in base a come si svolge la giornata, a come gli operatori lavorano, all’organizzazione e a come il territorio si esprime nei confronti del contesto penitenziario. La nostra è una realtà virtuosa, i numeri rispettano la tollerabilità e la maggior parte dei detenuti è impegnata in attività grazie allo sviluppo di sinergie territoriali davvero molto significative, nel solco di attive e propositive, ancorché “antiche”, collaborazioni e di forte attenzione da parte dell’Amministrazione Penitenziaria. Sono convinta che solo attraverso le condivisioni e il lavoro di squadra, le grosse difficoltà si possono affrontare e alleggerire. È ugualmente importante nell’applicazione delle norme la valutazione del contesto, nella misura in cui ciò è possibile. Con l’esperienza si capisce come declinarle sul piano operativo, posto che anche la nostra operatività risponde immancabilmente a due obiettivi: la rieducazione del condannato e l’ordine e la sicurezza penitenziaria».
Suicidi in carcere, una cinquantina, da inizio anno in Italia. Come prevenirli?
«È un tema importante su cui l’amministrazione lavora da molto tempo. La prevenzione si può mettere in campo attraverso la conoscenza del detenuto, del suo percorso di vita, anche penitenziaria, nel tentativo di intercettare il disagio e le fragilità. Indispensabile in tal senso è la multidisciplinarietà degli interventi degli operatori, attraverso incontri, condivisioni e ponendo la persona al centro del nostro lavoro. Il tema è complesso, il suicidio è un trauma sia per gli affetti del detenuto che per gli operatori penitenziari e per l’organizzazione. È una sconfitta che mai vorremmo subire. La soluzione? Prenderci cura delle persone ancor più se versano in condizioni di difficoltà».
Come lo state facendo?
«Con progetti di varia natura: formazione professionale, lavoro, istruzione, teatro, sport, religione e tanto altro. Si riproduce in questa realtà lo spirito di una vera e propria comunità che vive e respira anche grazie alle sinergie territoriali».
Tre giorni prima di morire Papa Francesco ha scelto di far visita ai detenuti di Regina Coeli. Messaggi così dirompenti possono far crescere una cultura di sensibilità verso i più fragili?
«Papa Francesco ci ha insegnato che di fronte all’esempio, le parole perdono di importanza. E che comunque, anche quando si preferisce agire con le parole anziché con i fatti, ne devono essere usate poche, ma di peso. Gli esempi sono fondamentali, ancor più se provengono da chi ha una linea di pensiero coerente e profonda. Una gran parte del nostro compito educativo è assorbita nella nostra capacità di essere da esempio a chi ha sbagliato. Va detto che il carcere non contiene solo i più fragili, ma anche una fetta di umanità a cui comunque gli operatori sono abituati a guardare con rispetto e senza pregiudizio».
Il carcere ideale: come lo immagina?
«L’organizzazione del carcere è troppo complessa per raggiungere l’idealità, è sempre perfettibile. Troppe diversità, imprevisti, sfide, con un’operatività h24. Più che a un modello di carcere preferisco pensare a giornate di lavoro “ideale” in cui il personale sia sereno e orgoglioso del lavoro che svolge in funzione della rieducazione e della sicurezza sociale; a giornate di lavoro che io possa sentire - come pure accade spesso - leggere, nonostante la fatica e l’impegno, perché motivate e motivanti in quanto ciascuno è pronto a riconoscere l’impegno dell’altro e il suo valore; a occasioni di tangibile ravvedimento delle persone detenute».
Quando è maturata l’idea di questa carriera?
«Dopo la laurea in Giurisprudenza, anche se per sensibilità familiare sono sempre stata attenta alle persone e alle relazioni. Ciò non toglie che in famiglia si siano meravigliati della mia scelta e del mio impegno».
Lo confessi: ha simpatizzato in qualche momento per Papillon?
«Simpatizzo per la giustizia, per l’amicizia, per i legami costruiti nelle difficoltà, per la lealtà».
Riproduzione riservata © il Nord Est