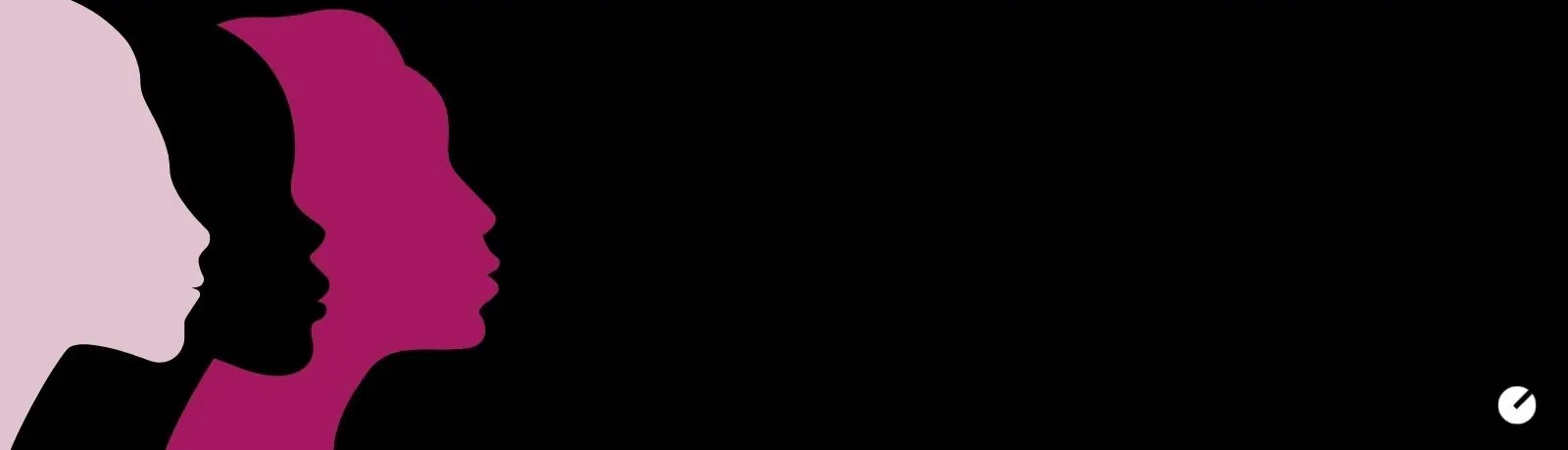Luciana Caenazzo: «Nel Dna la voce delle vittime, ma la genetica forense non è Csi»
La professoressa Luciana Caenazzo racconta il lavoro della genetica forense tra scienza, etica e responsabilità. Dai grandi casi di cronaca come la Mala del Brenta e Isabella Noventa ai femminicidi, fino alle nuove frontiere del Dna e ai limiti delle serie tv. «Il Dna è una prova fondamentale, ma non è mai l’unica»

Professoressa Luciana Caenazzo, nel suo laboratorio di genetica forense lei dà voce al Dna aiutando così a scoprire gli assassini. Si sente più scienziata o più investigatrice?
«Non mi sento investigatrice perché non faccio parte delle forze di polizia; quanto allo scienziato, per me è quello che punta al Nobel. Io piuttosto sono una ricercatrice nel campo della genetica forense. Ricerco sempre nuove metodologie per riuscire a recuperare il Dna, per studiarlo e compararlo».
Serie tivù come Csi hanno reso popolare il suo lavoro, peraltro facendolo apparire come lo snodo risolutorio di ogni caso criminale complesso. È così?
«Più di dieci anni fa partecipai a un importante convegno negli Usa e una delle sessioni riguardava proprio l’effetto di Csi sulle scienze forensi. La serie ha reso popolare il Dna e però, al contempo, le persone che delinquono hanno imparato come funziona e trovato strategie relative. Csi nella ricerca forense ha sicuramente avuto il suo impatto, l’ho sentito citare anche in dibattimento. Certo, scene come quelle di chi prende in mano un capello e dice subito chi è il colpevole fuorviano rispetto alle potenzialità della genetica forense. E comunque non è detto che in un determinato caso sia essenziale il Dna: esso è una delle prove, è oggettiva ed è scientifica. Però non è l’unica modalità per risolvere un caso, le scienze forensi vanno applicate a tutto campo».
Sente la responsabilità di un ruolo che oggi è così in primo piano?
«Csi ha sicuramente impattato. Bisogna essere sempre performanti. È importante aggiornarsi, ma c’è anche l’aspetto etico».
A cosa si riferisce?
«Non è possibile fare tutto, bisogna stare attenti a non superare il rispetto del diritto e dei diritti umani».
Parliamo di alcuni casi che ha seguito direttamente. Mala del Brenta: insieme alle analisi le arrivarono anche le minacce. Ha pensato, per un istante, che forse era meglio dedicarsi solo alle ricerche di paternità?
«Mi arrivò un pacco sospetto mentre stavo lavorando sulla banda Maniero. Avevo due figli piccoli e pensai che se fosse stata una minaccia, allora, avrei fatto un altro lavoro. Non intendevo in alcun modo mettere in pericolo la mia vita e quella dei miei familiari. Poi invece continuai su questa strada: il pacco non conteneva ordigni, ma un angioletto di ceramica. Era il ringraziamento di una signora a cui avevo trovato chi era il suo papà».
Isabella Noventa, nessun Dna e nessun corpo. Gli assassini, i Sorgato, hanno beffato gli investigatori?
«Isabella è il mio cruccio, ho lavorato sei mesi e non sono riuscita a trovare il suo Dna. Alcuni reperti non sono mai stati rinvenuti. Noi siamo intervenuti sulle auto e nelle case tempo dopo che era scomparsa. Il Dna è una molecola solubile, se uno pulisce e pulisce bene, non si trova più, inutile farsi illusioni. Ma non direi che ci hanno beffato, hanno semplicemente avuto il tempo di pulire».
Che reperti avrebbe voluto esaminare che non sono stati rinvenuti?
«La famosa giacca del video della passeggiata, quella non è stata trovata. Quando andai nella casa di Freddy avevano cambiato le lenzuola e lavato i pavimenti».
Da Isabella a Giulia Cecchettin, se ne è occupata?
«Di lei no, ma contemporaneamente mi sono occupata di altri femminicidi. Per me rappresentano un grande impegno morale, si tratta di dare voce a chi non ce l’ha più. E quindi la possibilità di ritrovare il Dna, di aiutare nella costruzione delle prove che dimostrino che una donna è stata uccisa, per me è un impegno morale fortissimo».
Ricorda alcune donne, tra le altre, a cui ha dato voce?
«C’è Giada Zanola, buttata dal cavalcavia. A Nicoleta Rotaru di cui era stato simulato il suicidio. Quando mi occupo di questi casi mi impegno con tutta me stessa per dare giustizia a chi non l’ha avuta. E credo che questo valga per tutti, per le forze dell’ordine che indagano in primis. Poi però cerco di non portarmi dietro tutte queste vittime».
Una forma di difesa?
«Sì. Mi porto invece dentro il rammarico perché nel 2026 siamo ancora qui, con questo tipo di reati che non dovrebbero più esistere».
Isabella Noventa è il caso che è diventato il suo cruccio, invece quello più complicato e quello che le ha dato più soddisfazione?
«Il caso più complicato è anche quello che mi ha dato più soddisfazione: l’omicidio del Portello a Padova del 2001. Riuscii a dimostrare chi era l’assassino senza avere il suo Dna, lui era nelle Filippine. Il corpo di Michael Lat venne trovato nel suo appartamento dalla moglie rientrata dal lavoro. A ucciderlo fu il connazionale James Briz che fuggì subito dopo il fatto, tornando nelle Filippine, che non hanno l’estradizione. Venne a sua volta ucciso. Come risalimmo a lui? Qui lui aveva una figlia. Esaminai una piccolissima traccia di sangue trovata sul corrimano delle scale e riuscii a dimostrare che apparteneva al papà della bambina, all’assassino che nel frattempo era scappato. Dimostrai attraverso i suoi familiari che era lui: questo oggi si fa abitualmente, ma all’epoca non ancora».
Quali saranno a suo avviso i prossimi sviluppi della genetica forense? Le prossime conquiste che oggi sembrano fantascienza?
«Il futuro relativamente immediato è quello di riuscire a stabilire che una traccia di Dna è stata lasciata da un soggetto con un certo colore di capelli, di pelle, con una certa altezza e così via, insomma con caratteristiche fenotipiche, che gli altri vedono. Per cui se la comparazione non è possibile, si procede con questo tipo di riconoscimento. Alcuni Stati lo stanno già facendo, ma io sono perplessa nell’applicare tale metodo perché non individua un solo soggetto, ma un gruppo di persone che si trovano a essere sospettate pur essendo innocenti, solo perché presentano quel determinato tipo di caratteristiche. Va fatta ancora un po’ di strada. Il futuro sarà riuscire a dire con precisione le caratteristiche visibili di un soggetto e addirittura riuscire a farlo nel contesto di sopralluogo con un apparecchio dotato di microchip: inserisci il materiale biologico e individui la sua provenienza».
Nel frattempo: com’è messo il vostro laboratorio quanto a risorse?
«Le risorse sono fornite dall’Università e dall’ospedale per il quale facciamo anche altro tipo di attività. Per esempio controlliamo come attecchisce il trapianto nei bambini trapiantati con cellule staminali. Certo, continueremo ad avere bisogno di apparecchiature nuove per fare ricerca, è una battaglia difficile».
La sua opinione su Garlasco con i colpi di scena sul Dna.
«Non ho seguito...».
È probabilmente l’unica in Italia a non averlo fatto.
«Faccio fatica a seguire i casi non miei perché penso che alcune notizie riportate potrebbero non essere precise. Ricordo che quando seguivo il caso di Isabella Noventa qualcuno scrisse che era stato trovato sangue in casa di Freddy. Non c’è mai stato. Ecco perché sono prudente. Su Garlasco, di fronte a questa riapertura e a questa dimensione mediatica in cui i colleghi si accapigliano, penso che forse quell’indagine è stata molto centrata su Stasi. E che forse valeva la pena di esaminare altri reperti. Una domanda che io mi faccio sempre è: ma i reperti li abbiamo esaminati tutti? ».
Cosa fa fuori dal laboratorio, nel suo tempo libero? Non dica che legge i libri di Patricia Cornwell...
«Certo che sì, io adoro i gialli, purché ci sia una storia credibile». —
Riproduzione riservata © il Nord Est