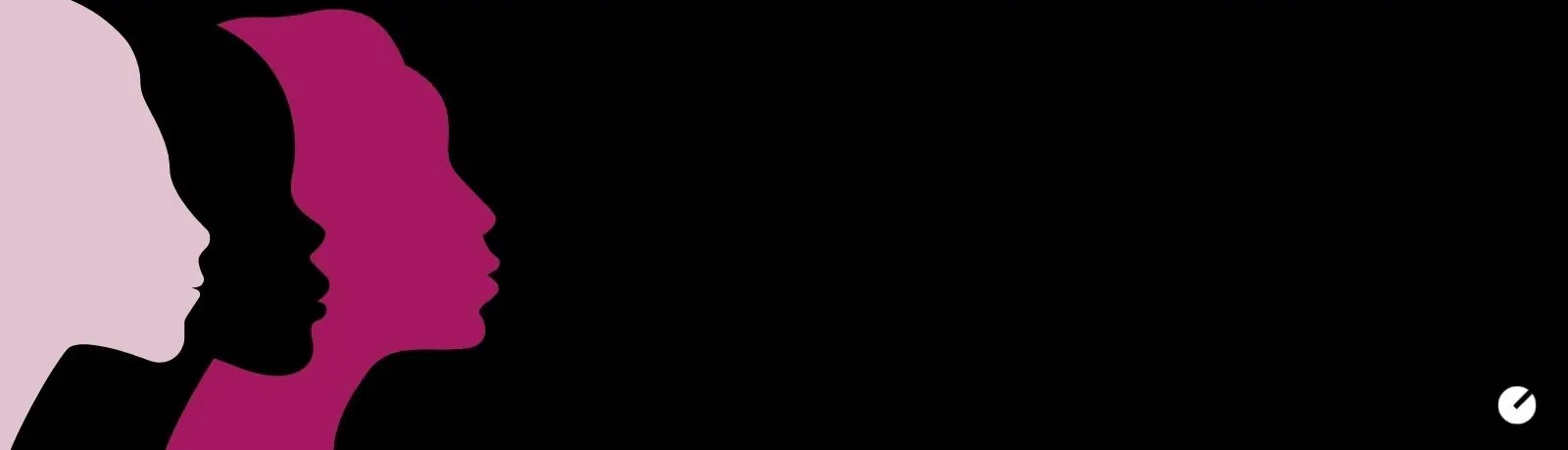La prima donna sfregiata dall’acido in Italia: «Le cicatrici restano ma ora sono libera»
L’intervista a Filomena Lamberti: «Ancora troppe vittime non hanno la forza di denunciare, dobbiamo aiutarle»

«Non mi sorprende che anche a Trieste il fenomeno della violenza sulle donne sia diffuso al punto da essere considerato un’emergenza. Non mi sorprende perché ho potuto constatare, girando l’Italia come testimonial, che la violenza di genere è un fenomeno che purtroppo accomuna tutto il Paese, dal Sud al Nordest. Ed ecco perché è vitale parlarne, diffondere la consapevolezza, aiutare le vittime a denunciare. Insomma, fare prevenzione».
“Prevenzione” è la parola chiave secondo Filomena Lamberti, prima donna sfregiata dall’acido solforico in Italia e presente a Trieste per l’inaugurazione della mostra itinerante “Women for Women Against Violence” dove compare come testimonial, immortalata in uno splendido scatto in bianco e nero assieme all’attrice Antonia Liskova. “Prevenzione” che significa presa di coscienza di come affrontare un nemico, che sia un marito o un compagno violento, o una malattia come il tumore al seno.
In cosa si assomigliano la violenza di genere e la malattia?
«Il tumore al seno può perseguitare una donna per anni, è sempre lì con te e allora diventa proprio come lottare contro un compagno troppo possessivo da cui non riesci a fuggire. Ho pianto tante amiche che hanno perso la loro battaglia con la malattia dopo averci convissuto forzatamente per anni. E io per tanti, troppi anni sono stata accanto a un uomo che mi maltrattava e dal quale non sono riuscita ad allontanarmi, fino a subire un’estrema forma di violenza. C’è una grande differenza, però: la malattia, nei casi peggiori, diventa un nemico insuperabile se non viene diagnostica in tempo, mentre bisogna essere consapevoli che contro la violenza è solo questione di forza di volontà. Dipende tutto da noi. È una battaglia che noi donne possiamo vincere sempre».
Perché è ancora così difficile trovare la forza per fuggire da un contesto di violenza familiare?
«È difficile perché nella mentalità della nostra società resistono troppi condizionamenti e pregiudizi. Le donne sono spinte a pensare che porre fine a una relazione sia comunque un fallimento personale, oppure temono di andare incontro a ripercussioni dal punto di vista della stabilità economica e del legame con i figli. O ancora, soprattutto nelle comunità più piccole, si vergognano di denunciare le violenze subite perché temono di essere malgiudicate, di ritrovarsi addosso uno stigma sociale».
La Procura di Trieste nel 2025 ha aperto quasi 1.300 nuovi fascicoli per casi di violenza di genere, con una parte consistente di Codici rossi, e sono aumentati i maltrattamenti in famiglia...
«Sì, non esistono isole felici. Anche in una città civile ed evoluta come Trieste il fenomeno c’è, così come esiste in tutta Italia, senza eccezioni. Certo, l’aumento del numero di casi può significare anche che un numero maggiore di donne trova il coraggio per fuggire da una situazione di violenza. Ma ancora non basta».
Cosa manca per riuscire a combattere la violenza di genere in modo davvero efficace?
«L’introduzione del Codice rosso e l’inasprimento delle pene sono passi importanti, ma ancora più importante è promuovere un salto di qualità culturale, anche attraverso la comunicazione sociale. In questa mostra qui a Trieste ne troviamo un esempio secondo me molto efficace, perché viene usato il linguaggio universale delle immagini per accendere le coscienze e ricordare che dalla violenza si può e si deve uscire. Il punto è che bisogna cominciare a educare sul fenomeno della violenza di genere fin dai primi anni della scuola, io ho fatto degli incontri addirittura con bambini che frequentano la quinta elementare. E la scuola non può bastare, perché l’educazione al rispetto deve partire anzitutto dalle famiglie. Questa dovrebbe essere la priorità».
Da anni partecipa a incontri pubblici in tutta Italia nei quali racconta la sua storia, mostrando fino a che punto può arrivare la violenza, ma anche che si può sopravvivere e trasformare quelle ferite in un messaggio di forza. Come ci è riuscita?
«È grazie alla sensazione di libertà. È grazie a questa se riesco ogni giorno ad andare avanti, a testimoniare quello che mi è successo perché non accada ad altre, a ignorare le cicatrici fisiche e psicologiche che ancora mi porto addosso. Sono una sopravvissuta, ma soprattutto mi sento finalmente una donna libera. Non lo sono stata per troppo tempo. Io ho subito una violenza terribile, ho affrontato un calvario fatto di trenta interventi chirurgici, ho sperimentato un dolore fisico che non si può spiegare, ma ho ritrovato la mia libertà e adesso nessuno potrà mai più portarmela via».
Riproduzione riservata © il Nord Est