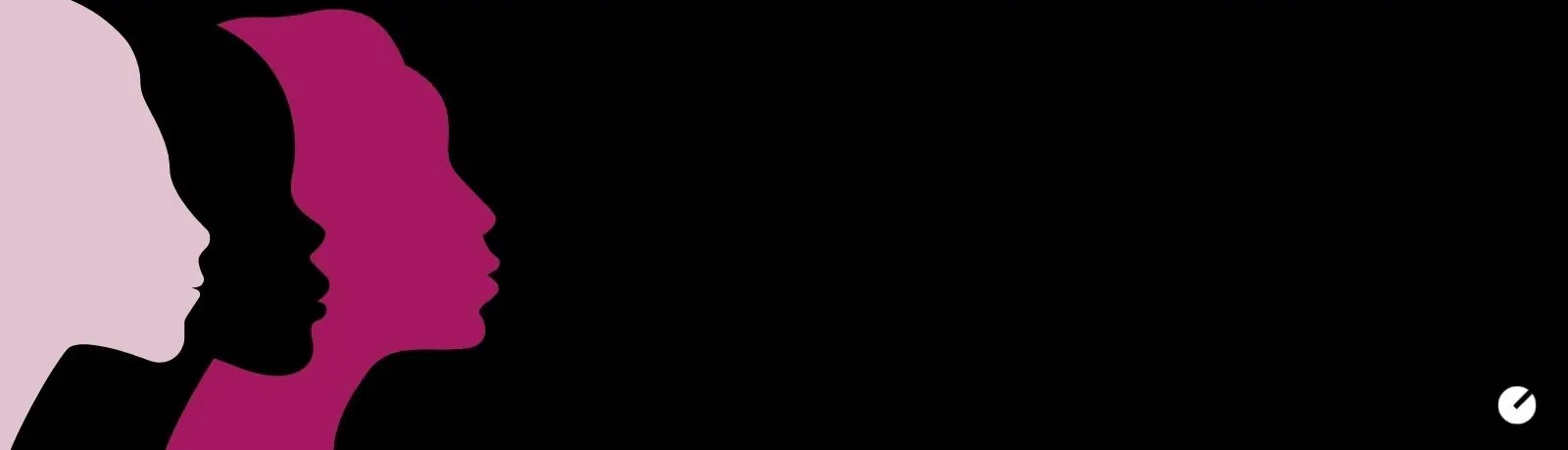La primaria Cattelan: «Abbiamo sconfitto l’Aids e il Covid. Ma quante cicatrici»
Annamaria Cattelan, primario di Malattie infettive in Azienda Ospedale Università di Padova e docente universitaria, combatte in prima linea da 38 anni: «Il Coronavirus è stata come una partita a scacchi: con i vaccini si è mossa la regina. E abbiamo vinto»

Professoressa dell’Università di Padova, Annamaria Cattelan, 62 anni, nata a Treviso e residente a Padova, è direttore di Struttura Complessa di Malattie Infettive presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.
È uno dei volti e dei nomi della lotta al Covid: con il suo staff e il suo reparto è stata in prima linea nei mesi drammatici dell’offensiva del Coronoavirus. E lo è stata precedentemente, nella lotta contro l’Aids, quando i farmaci per contrastarlo non erano ancora disponibili. Una vita dedicata alla Medicina. Sposata con un medico infettivologo, ha un figlio che ha deciso di seguire le orme dei genitori.
***
Annamaria Cattelan, laureata con il massimo dei voti e con la lode nel 1988. Fin da allora promessa della medicina.
«La scelta l’ho fatta l’ultimo anno di liceo, dopo un sacco di altre idee: dall’architetto alla professoressa di musica. Poi ho pensato a Medicina perché volevo fare la psicanalista, influenzata dalle letture di Svevo, Joyce e dalla cultura mitteleuropea».
E invece è a Malattie Infettive.
«Ero nel collegio del Cuamm, Medici con l’Africa e ho iniziato a sentir parlare della patologie dei migranti, di quelle dell’Africa. Sono arrivata alle Malattie Infettive nel ’90, quando c’era la grande ondata di Aids e la necessità di avere nuove risorse mediche. Ho fatto lo switch».
Trentotto anni al servizio della sanità. Ha la macchina del tempo: lo rifarebbe?
«L’attività di medico l’ho sempre considerata una missione, probabilmente anche influenzata dai sei anni nel collegio Cuamm. E ho sempre avuto grande passione per quello che facevo».
Il momento più esaltante.
«La fase più esuberante è quando abbiamo iniziato ad avere le terapie per il trattamento delle infezioni da Hiv. Nel ’90 l’Aids stava esplodendo, non avevamo armi per combatterlo, era uno strazio. Quando facevo i turni di guardia di 12 ore, contavo anche 7-8 decessi. Erano persone giovani, della mia età, spesso abbandonate dai familiari, che avevano noi medici come unico sostegno. Sono tantissime le storie che mi hanno colpito, che mi hanno segnata e che hanno costruito la mia personalità, ancora più dell’Università. Poi improvvisamente, dal ’96, abbiamo avuto a disposizione i farmaci che hanno cambiato il destino dei nostri pazienti. Una conquista che non ha più avuto uguali nella storia. A quel punto è arrivata la consapevolezza di essere esattamente laddove dovevo essere».
Il momento più difficile?
«Ogni volta che devo comunicare una diagnosi infausta. Le parole non sono mai quelle giuste, il tempo non è mai sufficiente. Hai in mano le sorti di una persona e sai che non puoi offrire speranze».
E poi c’è il Covid.
«Le prime due-tre settimane avevo paura di non farcela: le risorse umane erano ridotte, nei primi giorni mi chiamavano a casa di notte dicendomi che non riuscivano ad andare avanti. Fuori da Malattie Infettive avevamo le code di persone che venivano a farsi il test. E c’era la paura che se un collega si fosse ammalato ci sarebbe stato l’effetto domino su tutto il personale, con conseguenze catastrofiche. Sentivamo che nonostante il nostro impegno, le conoscenze, l’esperienza non potevamo cambiare l’esito per alcuni pazienti».
Ha mai pensato che avrebbe vinto il virus?
«All’inizio il virus ha avuto il suo momento di gloria. Non lo conoscevamo e anche il semplice fatto che una persona contagiata potesse infettare quando ancora non aveva i sintomi sembrava un’eresia».
Poi avete vinto voi, per tutti noi.
«È stata come una partita di scacchi: si è mossa la regina e sono arrivati i vaccini e le terapie. Anche se c’era comunque tutto quel rincorrersi: uscivano i monoclonali e il virus nel frattempo cambiava. Ma non ci siamo mai arresi».
Come vede oggi il Covid?
«Come una cosa lontana, c’è il prima e c’è il dopo, in mezzo è tutto nebuloso. Il peso emotivo delle decisioni prese, delle vite salvate, di quelle che nonostante tutto ci sono sfuggite: ecco, sembra impossibile che tutto questo sia successo. Resta la testimonianza che abbiamo vissuto intensamente, che abbiamo combattuto per qualcosa che poi siamo riuscito a sconfiggere».
Le sono rimaste cicatrici?
«Ancora oggi, quasi tutti i giorni, ho un rimbalzo di memoria che riguarda due pazienti. Li avevamo salvati da gravi patologie, dopo un percorso durissimo. E sono morti per il Covid».
Una vita dedicata a curare il prossimo. Cosa ha lasciato indietro nel suo privato?
«Tanto. Ho un profondo senso del dovere che mi viene dall’educazione ricevuta. Mio marito è medico infettivologo e quindi non trovo confini tra vita lavorativa e privata. Anche fuori dal lavoro ci troviamo a parlare di casi clinici. Ma è un privilegio avere qualcuno che possa comprendere la mia missione, cosa voglia dire avere una giornata pesante, dover fare scelte difficili, oppure più semplicemente accettare il weekend che salta. Alcune sfide mettono a prova la resilienza, però se mi guardo indietro rifarei tutto quanto. È un lavoro sempre diverso, a contatto con le persone, hai rapporti empatici, senti di aiutare e di ricevere».
Lei è primario, è stato difficile diventarlo o esserlo in quanto donna?
«Lo sono diventata nel 2007 a Rovigo, all’epoca non ci pensavo proprio. Volevo solo provare un concorso per capire come funzionava, in attesa del mio turno. Per una serie di coincidenze quello è diventato il mio turno. Poi, quando hai una posizione di leadership in settori prevalentemente maschili, ti rendi conto che non è facile e che devi superare pregiudizi e aspettative sociali. Devi fare dieci volte più di un uomo per essere al pari suo. Devi essere sempre impeccabile. Se alzi la voce tu sei un’isterica, se lo fa lui è segno di forza e determinazione. Ti muovi un po’ nelle sabbie mobili».
Come non farsi risucchiare?
«Credo ci voglia determinazione e competenza. Quando vedono che le cose le sai, che ti sai muovere bene, la tua posizione viene accettata e rispettata».
Un consiglio a una studentessa di Medicina.
«Dev’essere determinata, ma anche audace e instancabile, pronta ad affrontare le sfide. La Medicina è un viaggio, non è solo un orario lavorativo. E coinvolge tutta la vita. Bisogna avere sempre la volontà di voler imparare, aperte ai cambiamenti e alle innovazioni».
Ha figli?
«Uno, è al secondo anno di Medicina. Io sono molto contenta e orgogliosa della sua scelta, mio marito un po’ meno perché è strada lunga e piena di difficoltà».
Considerate le difficoltà della sanità, suo marito non sembra avere torto: stipendi non sempre adeguati, fughe di alcune figure, aggressioni....
«Il problema è complesso e frutto di anni di scelte strategiche non sempre lungimiranti, con crescenti pressioni sui sistemi di cura, con tutti che voglio tutto e tutto subito, con il malcontento tra gli operatori che si sta trasformando in disaffezione per le professioni mediche e infermieristiche anche a causa di condizioni lavorative sempre più gravose, con turni sempre più pesanti. Le retribuzioni spesso non sono adeguate alla responsabilità di ruolo. Poi c’è la percezione sociale che non sempre riconosce chi è in prima linea, con i fenomeni delle aggressioni, fisiche e verbali. Inoltre siamo soffocati da una burocrazia che non diminuisce: speriamo che l’Ia cambi le sorti».
Ha fiducia nei robot?
«L’Ia dovrebbe aiutarci a fare tutto quello che non è strettamente medico e dovrebbe essere indirizzata in tal senso. L’Ia fa molti scivoloni che noi riconosciamo: per continuare a riuscirci occorrere pensare con la nostra testa. Bisogna dare dignità e valore a chi lavora nella sanità, come peraltro a chi lavora nella formazione dei ragazzi e nel welfare in generale. Altrimenti la sanità rischia di perdere il bene più prezioso: le persone che sanno farla funzionare».
Riproduzione riservata © il Nord Est