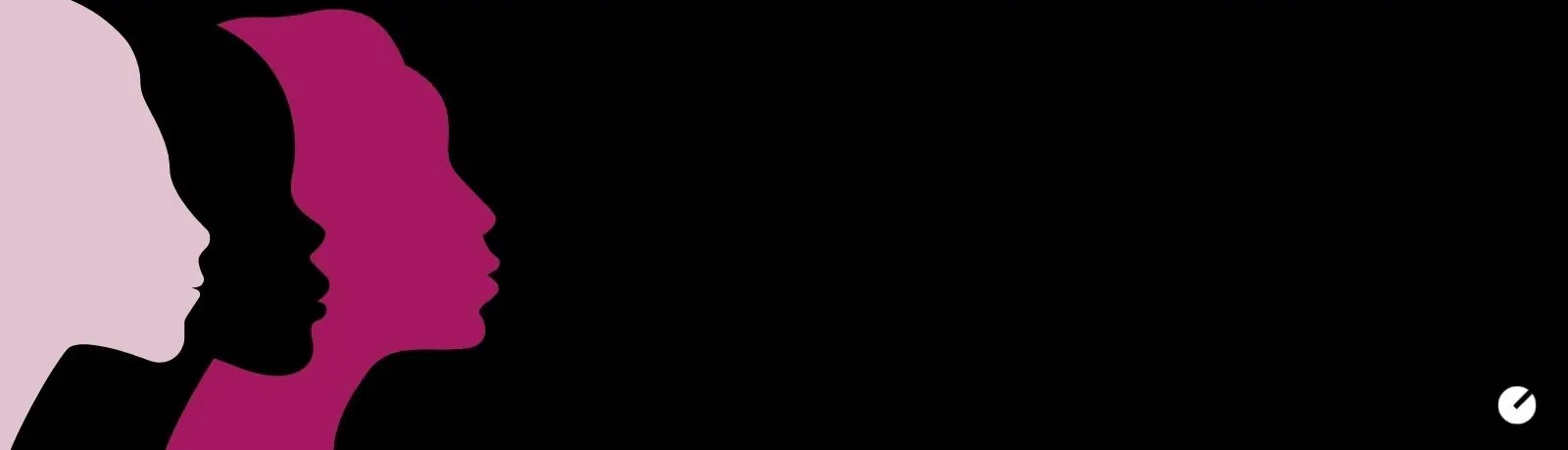Arianna Farinelli: «Per salvarmi sono partita, ma il sessismo non conosce passaporto»
In libreria con Storia di una brava ragazza, la scrittrice romana vive da 25 anni negli Stati Uniti: «Con Donald Trump è in atto una vera e propria misoginia di Stato. Lottiamo per un futuro diverso»

Arianna Farinelli, scrittrice, politologa, editorialista, ha insegnato per dieci anni Relazioni internazionali alla City University of New York. È in libreria con Storia di una brava ragazza (Einaudi): dal passato al presente, per immaginare un futuro diverso per le donne. È così?
«Il mio libro è un memoir, racconta la mia storia: sono nata all'estrema periferia di Roma nel 1975 e quando ero adolescente pensavo che per potermi salvare dalla violenza del quartiere - dove il racket, la prostituzione, le rapine a mano armata erano all'ordine del giorno - dovessi diventare molto brava, impegnarmi molto nello studio, essere brava a scuola. Poi negli anni dell'università ho capito che per riuscire veramente a salvarmi, soprattutto dal sessismo, dalla misoginia, dalla violenza di genere, dovessi andare il più lontano possibile: non solo dal mio quartiere, ma anche dalla mia città e dal mio paese. E in quel momento la strada per l'estero - infatti io vivo negli Stati Uniti da 25 anni - mi sembrava in qualche modo più percorribile e meno accidentata della strada che andava dal mio quartiere al centro di Roma».
E invece?
«Purtroppo, quando sono arrivata qui negli Stati Uniti, nella Manhattan colta e opulenta tra professionisti prulilaureati, ho ritrovato lo stesso sessismo, la stessa misoginia, la stessa violenza di genere che avevo conosciuto crescendo in periferia, a Roma. E questo perché le disuguaglianze di genere non conoscono passaporto, religione, etnia. Non sono prerogativa soltanto delle classi meno abbienti o delle persone che hanno studiato di meno, sono fenomeni trasversali e globali».
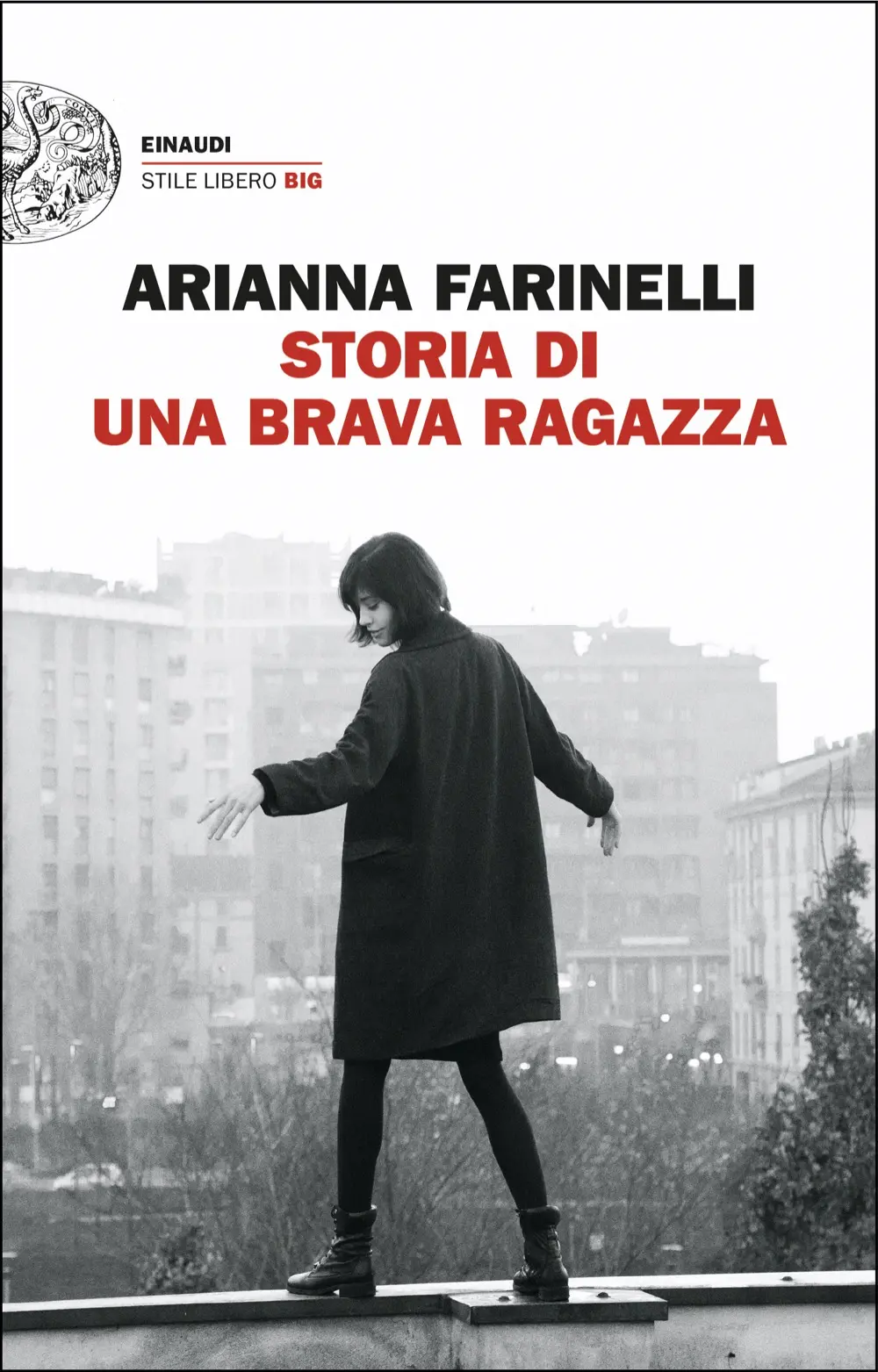
Il libro si apre con una scena, che oggi diremmo “forte”: lei, piccola, che scopre il sesso di sua madre in bagno, mentre sta facendo il bidet. Cosa ha rappresentato in questo percorso a ostacoli quella prima scoperta?
«Racconto questa scena di me bambina intorno ai tre anni e mezzo-quattro che in bagno vede la mamma nuda e soprattutto guarda il sesso di sua madre e lo paragona al suo. Un'immagine molto semplice e naturale, un'immagine di vita quotidiana. Eppure, come lei ha detto, la prima scena del libro è forte e questo mi è stato detto per esempio anche dal mio editore, è una scena forte. Io, certo, non avevo intenzione di essere disturbante, perché appunto il sesso femminile è una cosa assolutamente naturale: è l'origine del mondo. Però il corpo delle donne è stato sempre un corpo oggettificato e sessualizzato. A noi insegnano fin da bambine a dividere il corpo in parti - il seno, la pancia, i glutei, le cosce - e a giudicare queste parti a seconda che corrispondano o meno a determinati modelli di bellezza. È stato molto difficile per me, come per tante donne, separarsi da questa immagine così oggettificata, sempre soggetta a giudizio, a scrutinio nostro e altrui. Dobbiamo amare il nostro corpo per quello che è. E spero che le ragazze delle nuove generazioni abbiano un rapporto diverso con il loro corpo e soprattutto non sentano che il loro corpo debba essere sempre oggetto di commenti anche molto volgari».
La preoccupa il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca?
«Negli Stati Uniti è in atto una vera e propria misoginia di Stato, l'aborto non è più un diritto garantito dalla Costituzione da tre anni. Ci sono Stati, come il Texas e la Florida, dove non si può abortire dopo la sesta settimana, e da quando questa amministrazione si è insediata a gennaio del 2025, sono sparite dal sito del ministero della sanità tutte le informazioni riguardanti non solo l'interruzione di gravidanza, ma anche la contraccezione. Questo governo porta avanti una vera e propria battaglia per far sì che le donne mettano al mondo più figli e lavorino di meno. E alcune parole come “donna”, “genere”, “femmina”, ma anche “gravidanza” e “allattamento” sono considerate dall'amministrazione Trump parole pericolose, quasi sovversive, per cui ricercatrici e scienziate sono costrette a non utilizzarle se vogliono accedere a finanziamenti pubblici per il loro lavoro. Stiamo proprio assistendo a un vero e proprio ritorno al passato. Paradossalmente la generazione di mia figlia, adolescente, ha meno diritti oggi della generazione delle nonne che cinquant'anni fa si batté con coraggio perché l'aborto diventasse legale. Purtroppo, noi donne abbiamo impiegato secoli per vederci riconosciuti i nostri diritti e poi li abbiamo persi in pochissimo tempo. E questo per perché da sempre ciò che non si protegge si perde».
In Italia come siamo messi?
«Io sono contenta che ci sia una donna Presidente del Consiglio, anche se non condivido le idee di Giorgia Meloni. Però l'Italia è in una situazione in cui soltanto il 53% delle donne lavorano, il 40% delle donne non torna a lavorare dopo la prima gravidanza, in cui per abortire spesso bisogna cambiare regione, ci sono più di cento femminicidi l'anno, sono decine di migliaia le richieste di aiuto per violenza domestica o per molestie sessuali. Quindi c'è ancora moltissimo da fare. Il fatto che in Italia, per esempio, non ci sia un'educazione sessuale ancora nelle scuole è una cosa che mi lascia molto perplessa. Qui negli Stati Uniti almeno si fa educazione sessuale che poi si chiama Health class, cioè classe della salute sia alle elementari che alle medie che al liceo, e questo è molto importante. Per smantellare la cultura patriarcale, dobbiamo anzitutto passare dalla conoscenza e dall'educazione, a cominciare dalle generazioni più giovani».
C’è stato un femminicidio, quello di Giulia Cecchettin, che ha cambiato qualcosa nella percezione del problema, diventando simbolo di una lotta che riguarda tutti. Qui è stato sentito moltissimo, lei come l’ha vissuto dagli Stati Uniti?
«Sono state settimane e mesi molto dolorosi, anche i giornali americani hanno parlato di Giulia Cecchettin e di tutto quello che è accaduto dopo, dalle proteste al dibattito politico nella società civile».
Che spiegazione si dà?
«Quello che più ha colpito, secondo me, di quel femminicidio è stato che l'autore del delitto era un ragazzo coetaneo di Giulia, un ex fidanzato, un ragazzo che però non sopportava che lei si stesse per laureare e volesse cambiare città, iniziare la sua carriera, andare avanti con la sua vita. Questo fa molto riflettere: le ragazze oggi sono molto consapevoli di loro stesse, sanno cosa vogliono, sanno dove vogliono arrivare. Invece i ragazzi sono rimasti un po’ indietro. Dobbiamo lavorare perché tutti capiscano che la parità fra uomini e donne è un valore aggiunto per tutti, non è solo per le donne, perché la cultura è patriarcale, come fa male a noi, perché ci sessualizza fin da quando siamo bambine, fa male ai ragazzi».
In che modo?
«Li obbliga a conformarsi all’ideale di maschio forte sessualmente dominante e a non mostrarsi diciamo vulnerabili, anche sensibili, a non mostrare la sofferenza emotiva. Usano violenza perché vogliono riaffermare il loro dominio, la loro superiorità. È un fatto estremamente culturale».
La strada è lunga…
«Se vogliamo costruire un domani diverso dobbiamo lavorare sul presente, dobbiamo batterci davvero perché la parità fra uomini e donne non faccia più paura a nessuno».
Riproduzione riservata © il Nord Est