Piacentini: «Competenza e cultura diffusa del digitale possono fare la differenza»
Finita l’epoca del patto di stabilità, del debito vissuto come un tabù intangibile, si impone una visione più aperta alle esigenze di una solidarietà globale. Alcuni passaggi saranno cruciali, a cominciare dalla riforma fiscale
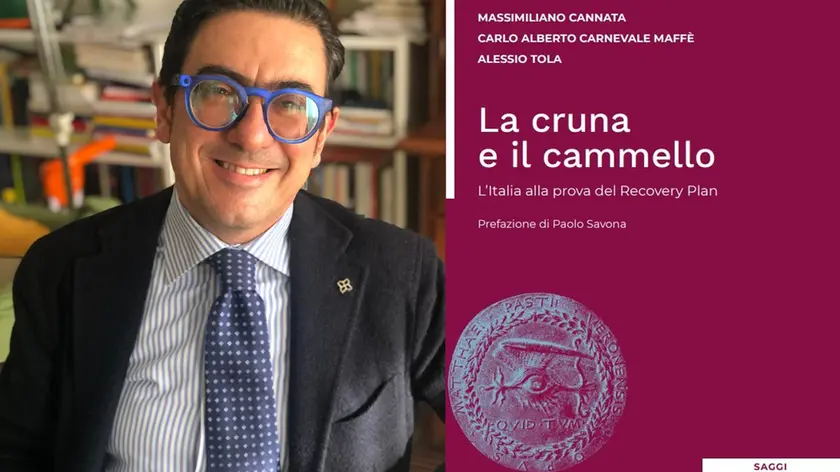
Competenze tecnologiche e di gestione di processi complessi; disegno, sviluppo e implementazione di programmi digitali su larga scala, snellimento dei processi di procurement tecnologico, per Diego Piacentini, manager con un amplissima esperienza internazionale sono questi i termini chiave su cui il PNRR deve puntare per uscire dall’emergenza.
Dottor Piacentini che idea ha maturato relativamente ai contenuti del PNRR, che rimane al centro di questa vivace campagna elettorale?
Il PNRR ha il pregio di presentare sia nuove idee sia alcuni programmi giá avviati che necessitano di una forte spinta per raggiungere gli obiettivi previsti. Penso alla focalizzazione sull'anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR), sulla piattaforma dei pagamenti pagoPA, delle identitá digitali SPID e CIE, quest'ultima gestita direttamente ed efficacemente dal Poligrafico dello Stato. Se guardiamo più in dettaglio le componenti dell’indice DESI riportate nel PNRR si può vedere come le voci con migliori performance siano quelle relative alla connettività e alla PA digitale, mentre colpisce negativamente la curva piatta che l’Italia fa registrare sul fronte del capitale umano e dell’uso di Internet e sul fronte dell’integrazione tecnologica, dove siamo purtroppo penultimi in Europa a dimostrazione che dobbiamo fare in modo che possa affermarsi una cultura diffusa del digitale per dare corso alla svolta che tutti auspichiamo.
Durante la sua esperienza di Commissario Straordinario del governo per l’attuazione dell’agenda digitale (Settembre 2016- Ottobre 2018 esecutivo Renzi n.d.r) tra i tanti progetti che ha portato avanti vale la pena ricordare: la app “Io”, e tre di back-end in ottica di piattaforma aperta a terze parti: rilancio di pagoPA, SPID e ANPR (anagrafe centralizzata). Ha scelto non a caso di fare “l’idraulico” occupandosi di filettare e montare i tubi, facendo comprendere che non esiste nessun “Mr. Wolf” del Digitale e che per arrivare a una convergenza di competenze e di eccellenze bisognerà saper aspettare la maturazione di diverse componenti di sistema. Resta di questo parere?
Si. Siamo partiti con 7 anni di ritardo rispetto, ad esempio, al Regno Unito è c’è ancora molto da fare per colmare il divario, considerato anche la maggiore complessità del sistema amministrativo italiano “analogico” rispetto a quello britannico. 7 anni possono sembrare pochi, ma nel mondo tecnologico sono tantissimi. Questo non vuol dire arrendersi e desistere. La trasformazione digitale é un programma di lungo periodo, siamo solo all'inizio. É fondamentale impegnarsi per rendere sempre più capillare la trasformazione digitale all'interno della PA, dalla gestione dei dati, ai pagamenti e alla certificazione dell’identità, all'interoperabilitá dei servizi e delle piattaforme tecnologiche sviluppate, perché sono prerequisiti essenziali della “quarta rivoluzione”.
Un cammino non semplice, con molteplici tappe. Non le pare che siamo ancora in messo al guado?
Bisognerà accelerare i tempi, mantenendo rigore do metodo e chiarezza di visione. Risulterà inoltre importante individuare una figura chiave di cui il settore pubblico è sprovvisto: lo Chief data officer che abbia la responsabilità di gestire l'immenso patrimonio in termini di know-how e di BIG Data. Sarebbe utile anche valutare gli impatti dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale sull’ecosistema sociale e produttivo, che deve trarre vantaggio dalle politiche pubbliche, altrimenti tutto quello che viene detto è destinato a rimanere nel “mondo delle idee”, con le conseguenze del caso. Non dimentichiamoci che quando parliamo di “piattaforme abilitanti”, parliamo di strumenti che rappresentano la condizione necessaria, ma non sufficiente, per rendere più efficienti ed efficaci i rapporti tra cittadini, imprese e stato. Sono questioni che la “buona politica” non potrà ignorare, se solo pensiamo che sono i contenuti delle policies, dei programmi, e delle norme, che ne sostanziano la qualità.
Nel PNRR sono stai messi in cantiere ingenti risorse per le infrastrutture di rete fissa e per l’interoperabilità, su entrambi questi versanti avremmo dovuto intervenire da tempo. Intanto langue la progettazione di piattaforme per l’approvvigionamento dei dati, che sono la valuta della digital economy, né si intravede uno sforzo concreto per l’implementazione di nuovi servizi. Come si spiega tutto questo?
Che siamo ancora all’inizio di un percorso. La “rivoluzione tecnologica” richiede investimenti mirati e chiarezza di idee. Guardando al settore pubblico va detto che la vera grande carenza sul fronte delle competenze è quella del project management. Dobbiamo creare le condizioni, come ho detto più volte anche in passato, per portare nella PA eccellenze anche dal privato, anche per periodi transitori perché questo può realmente fare da catalizzatore per un cambio di marcia. Organici congelati, rigidità contrattuali, tetti di spesa anacronistici che limitano le assunzioni, burocrazia opprimente, scarsa propensione all’innovazione: gli aspetti da migliorare sono noti e vanno affrontati con immediatezza, altrimenti nessun progetto di qualità potrà trovare realizzazione. Pensiamo al grande tema della transizione ecologica, un grande capitolo su cui non solo l’Italia, ma l’Europa avrebbero l’opportunità di creare una piattaforma unica per l’idrogeno, a patto di imparare a governare processi complessi, che hanno tante sfaccettature: giuridico – burocratico, oltre che culturali e organizzative. Per il momento questo scenario appare lontano, con il risultato che l’Italia rimane un consumatore, più che un produttore di energie alternative.
***
Governare la value chain a monte e a valle
A una lettura attenta del Piano emerge come un’Italia che tende ad “accontentarsi” di incentivare l’adozione del digitale con interventi “a valle” rapsodici, non sempre coerenti, mentre ci sfugge quello che succede a monte. Così non si fa molta strada, non crede?
Serve equilibrio. Intendo che bisogna cercare di governare la value chain a monte definendo obiettivi e linee guida della progettazione, e nel contempo attuare policy che possano determinare uno spostamento delle attività produttive verso fonti alternative. Faccio un esempio: nel caso dello bonus cultura e dello spid sono stati gli incentivi a spingere la popolazione a fare un salto che credevano faticoso e soprattutto non necessario. Credo che il problema vero si annidi nel Procurement, che congela ogni iniziativa rendendo impervio ogni percorso verso il cambiamento.
Il PNRR esplicita tra gli obiettivi la riduzione della complessità dei processi di procurement, specie per l’acquisto delle soluzioni tecnologiche. Un segnale positivo. Saremo in grado di coglierlo?
Speriamo non rimanga un semplice auspicio. Nel corso del mio lavoro di Commissario mi sono confrontato più volte con Raffaele Cantone (Magistrato, Presidente ANAC n.d.r). Ho trovato il suo zelo nel contrasto alla corruzione assolutamente da ammirare - dico con forza a scanso di equivoci, - persino esagerato, nel senso che l’eccessiva preoccupazione di sterilizzare e controllare che non ci fosse alcuna infiltrazione mafiosa nelle attività produttive, se da un lato è una garanzia di trasparenza e correttezza, dall’altro è un ulteriore freno a un’attività di procurement che presenta troppi intoppi e vischiosità. La riforma del codice degli appalti, promessa da Draghi, in questo senso aiuterà, ma c’è molto ancora da fare. L’impressione generale è che l’Italia preferisca la certezza dell’arretratezza tecnologica al minimo rischio di lasciar spazio a possibili fenomeni di corruzione, perfino nell’adozione di soluzioni standard globali, si avverte una sorta di timore nel prendere qualsiasi iniziativa.
In più occasioni Lei ha denunciato una generale mancanza di cultura nella gestione dei progetti, la superficialità di alcune decisioni politiche prese spesso senza la dovuta consapevolezza, insieme alla necessità di creare un Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che potesse godere di una reale autonomia rispetto ai palazzi della politica. Si possono cogliere segnali di cambiamento in tal senso?
Vi sono luci e ombre. Abbiamo modelli virtuosi come SOGEI e modelli molto negativi, non è neanche il caso di fare nomi, che generano esternalità negative peggiorando la performance e i fattori di sistema. Se vogliamo cambiare il corso delle cose dobbiamo innanzitutto cominciare col mettere alla guida talenti con competenze tecnologiche e manageriali precise, non certo rappresentanti del sottobosco della politica, nominati con obiettivi clientelari. Talenti tecnologici, strategie e obiettivi ben definiti, finanziamenti trasparenti, processi snelli di procurement; sono questi gli ingredienti da mettere in campo.
***
Il nuovo orizzonte “Cloud”
Lo sviluppo del Cloud Computing sarà un interessante banco di prova. Nel PNRR si legge: “la trasformazione digitale della PA seguirà un approccio “cloud first”, orientato alla migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni verso un ambiente cloud… le amministrazioni centrali potranno migrare sul Polo Strategico Nazionale, quale nuova infrastruttura dedicata completamente “privata” o “ibrida”, localizzata sul territorio nazionale e all’avanguardia in prestazioni e sicurezza, oppure migrare sul cloud “public” di uno tra gli operatori di mercato certificato”. La convince l’adozione di questo modello misto pubblico-privato?
Se lo scopo preciso è quello di far migrare in cinque anni le amministrazioni centrali e locali, questo paradigma che prevede la realizzazione di una tecnologia cloud multipiattaforma ibrida può funzionare. In altri paesi pensiamo all’Inghilterra ci sono voluti 7-8 anni, ma sono riusciti nell’intento. Adesso tocca a noi. Personalmente avrei voluto dare una spinta più forte in questa direzione durante il mio mandato. Mi auguro che in futuro si possano creare le condizioni per arrivare all’obiettivo. Rimane tuttavia cruciale, se vogliamo ottenere risultati, sviluppare una cultura manageriale, per attuare una governance e una implementazione dei progetti rapida, efficace, senza rimpalli di responsabilità, e soprattutto senza quelle ridondanze che generano “entropia”, traducendosi inevitabilmente in spreco di risorse.
Quali azioni vanno intraprese per rendere trasparente ai cittadini e alle imprese i vantaggi che deriveranno dall’adozione del PNRR?
Comunicare questo grande momento di trasformazione è una grande occasione che non dobbiamo perdere. C’è un vento nuovo, bisogna condividere con i cittadini questa delicata fase che dovrà portarci fuori dal tunnel della negatività entro cui l’emergenza ci ha trascinati. Serve un’etica della responsabilità diffusa. Evitare messaggi superficiali e roboanti aiuterebbe tutti. Per quanto poi concerne la comunicazione verso il mondo esterno, e quindi il posizionamento dell’Italia in questa difficile partita che si sta giocando, dobbiamo sfruttare la credibilità internazionale del nostro premier, che conferisce autorevolezza a ogni mossa e decisione. Non illudiamoci però: “la luna di miele” con la UE é temporanea, e se latitassero risultati concreti potremmo poi pagare un prezzo molto alto.
Rimanendo sul fronte internazionale, va detto che la strategia di Biden, che nei mesi scorsi ha messo in campo una quantità di risorse senza precedenti sta dando impulso a una ripresa (si calcola +7,1% un dato certo eclatante) mette all’angolo un’Europa che al contrario appare lenta e farraginosa quando c’è da prendere ogni decisione. Dobbiamo pensare che il Covid dopo aver gettato il pianeta nell’emergenza, si tradurrà in un fattore di riequilibrio del sistema geopolitico?
Non possiamo certo escluderlo. Di certo anche l’Europa ha bisogno di una riforma della sua Governance. Finita l’epoca del patto di stabilità, del debito vissuto come un tabù intangibile, si impone una visione più aperta alle esigenze di una solidarietà globale. Alcuni passaggi saranno cruciali, a cominciare dalla riforma fiscale, che dovrà conferire una maggiore omogeneità non solo economica ma anche politica al vecchio Continente. Raccomandazioni e linee guida insomma non basteranno, bisogna andare oltre questa “sintassi” che alla lunga si rivela sterile. Più pragmatismo e centralità della cultura scientifica e tecnologica; la classe dirigenti europea, dovrebbe apprendere questa “lezione” dagli USA, impegnandosi concretamente a capire e intercettare il futuro, faccenda molto delicata che riguarda noi tutti.
* questa intervista è tratta dal libro “La cruna e il cammello – L’Italia alla prova del Recovery Plan” edito da Tab Edizioni e scritto da Canata con Carlo Alberto Carnevale Maffè e Alessio Tola
La cruna e il cammello
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un patto tra generazioni, un impegno reciproco tra Italia ed Europa, tra politica e cittadini di oggi e di domani. Come tutti i contratti, è insieme impegnativo e incompleto, vincolante ma anche elusivo.
Gli autori hanno sollecitato dieci opinion maker di livello internazionale a offrire un contributo interpretativo, attraverso l’analisi competente e non convenzionale dei rischi e delle opportunità di questo passaggio cruciale per il Paese. Dopo l’anno della “paura nera”, con economia e società globali semiparalizzati dalla pandemia, è il simbolo ufficiale della ripartenza. Ma mentre Usa e Oriente hanno mostrato reattività tornando rapidamente a correre, in Europa e particolarmente in Italia, dove la crescita langue da vent’anni, la ripresa è resa incerta dalla criticità dei fattori di contesto e da assetti istituzionali tuttora inefficienti e incompleti.
Chiaro il quadro che si sta profilando: dopo aver modificato il paesaggio economico e sociale delle città occidentali, la pandemia sta ridisegnando gli equilibri geopolitici. Per non rimanere ai margini dello sviluppo il vecchio continente dovrà affinare una lucida strategia di rilancio, perseguendo con chiarezza gli obiettivi del programma Next Generation EU. La sfida ha una ricaduta precisa sull’Italia che deve mettere a punto capacità di governance dei processi del cambiamento e definire le metriche e gli strumenti adatti per non perdere questo appuntamento decisivo per realizzare quelle riforme strutturali da troppo tempo annunciate e mai attuate.
Saperi e tecnologie, capitale umano e innovazione applicata alla qualità delle infrastrutture e dei servizi, se classi dirigenti preparate e consapevoli sapranno guidare gli investimenti in questa direzione, un futuro di progresso sarà realmente possibile da Nord a Sud, in tutti i nostri territori asfissiati dall’emergenza che ha finito col congelare non solo l’attività economica, ma anche la normale vita di relazione. Non rispettare questo patto significa derubare i giovani del loro futuro, consegnando il Paese a un declino ineluttabile.
Riproduzione riservata © il Nord Est








