La prima indagine digitale e i colpevoli incastrati con i tabulati: rogo della Fenice, la storia del processo
Trent’anni fa l’incendio del Teatro: solo grazie alla nuova tecnologia la procura riuscì a raccogliere le prove di colpevolezza. Il fuoco studiato a tavolino
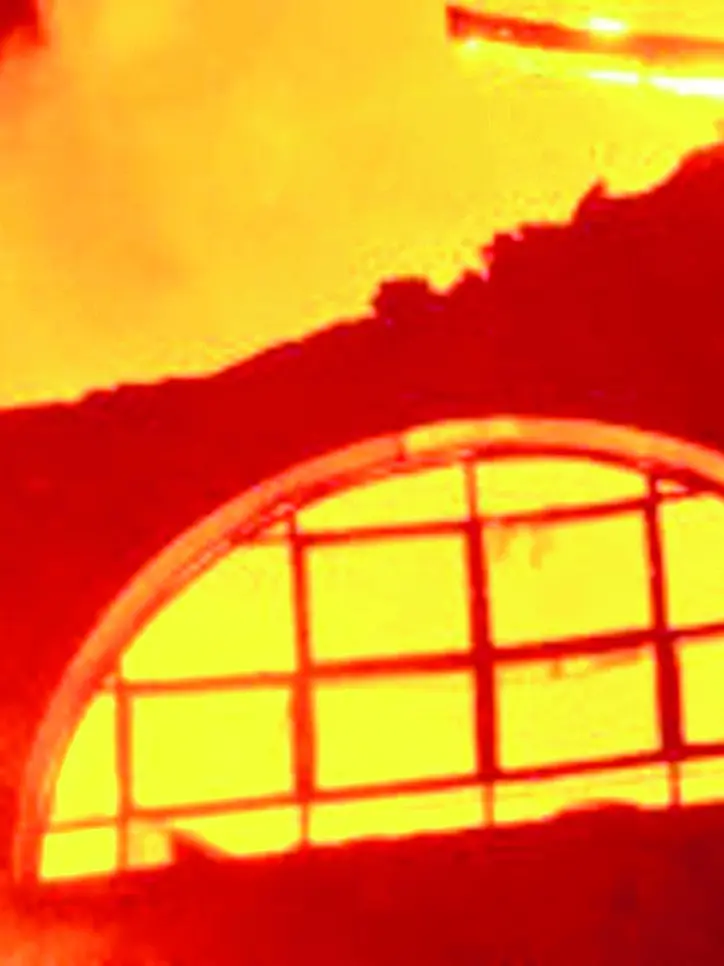
Fu un’inchiesta che per la prima volta si affidò alla tecnologia quella che rivelò che, nella notte del 29 gennaio 1996, La Fenice venne ridotta in cenere «Per quattro schei», per non pagare una penale per i ritardi nei lavori di ristrutturazione che erano stati affidati a una piccola ditta di elettricisti in subappalto.
La verità emerse grazie a quella “mappatura” delle celle alle quali si agganciano i cellulari: oggi atto automatico in molte indagini, quasi banale, ma allora assolutamente sperimentale, intuitivo. Ma facciamo un passo indietro e andiamo per ordine.
Chi quella notte era lì, davanti alla Fenice che ardeva, ha ancora nelle orecchie il suono sordo e potente del fuoco: una fornace infernale. Ha negli occhi le sagome dei vigili del fuoco arrampicati sui tetti per salvare le case, per salvare Venezia: il teatro, ormai, era destinato alla cenere. Il buio del blackout tutto attorno e l’abbaglio di un rogo spaventoso e ipnotico.
Il Teatro bruciava senza controllo, con fiamme alte decine di metri, mentre i canali attorno erano prosciugati perché l’edificio era chiuso per restauro. Serviva acqua, tanta, e l’acqua non c’era, mettendo in pericolo tutto: la vita dei pompieri e di quanti abitavano accanto al teatro.
I vigili fecero il loro miracolo laico: salvarono le case e la città. Prima di mezzanotte l’incendio era stato domato, ma - dopo il fragoroso crollo del tetto - della Fenice restava solo il guscio annerito e fumante dei soli muri perimetrali.

Nei giorni successivi, tra lo smarrimento della città e l’eco internazionale della tragedia, l’inchiesta giudiziaria prese avvio nel segno dello sgomento. Emerse per primo che il cantiere di ristrutturazione era un labirinto di responsabilità: impianti idrici smantellati, sistemi antincendio disattivati, materiali infiammabili accatastati, sorveglianza lacunosa. Il primo fascicolo ipotizzò così l’incendio colposo. Tra i quindici indagati finì anche il sindaco Massimo Cacciari – il primo ad accorrere la sera della tragedia: «L’abbiamo persa» - i vertici della Fenice, funzionari comunali, tecnici, titolari delle imprese al lavoro e lo stesso custode. In quella prima fase, emissioni e superficialità sembravano poter spiegare una tragedia senza precedenti.
Ma l’indagine coordinata dal pubblico ministero Felice Casson non si fermò alle apparenze. Il 26 giugno 1996 arrivò la svolta destinata a cambiare per sempre la storia giudiziaria del rogo. I consulenti della Procura chiamati a dare un “perché” e un “come” alla tragedia, affiancati da polizia scientifica e carabinieri, conclusero infatti che la Fenice non era morta per il caos di un cantiere. Le analisi sulle macerie, condotte anche con sofisticate simulazioni informatiche, rivelarono almeno una mezza dozzina di focolai collegati tra loro e l’uso di liquidi infiammabili.

L’incendio era doloso, era stato studiato a tavolino, appiccato in punti strategici: platea, ridotto del loggione, aree attorno al palcoscenico. Qualcuno conosceva il teatro e ne aveva scelto il giorno più vulnerabile: orchestra assente, edificio chiuso, canali asciutti. Forse non voleva distruggerlo, ma fargli male di sicuro sì. Perché?
Fu in quella fase che il pm Casson decise di spingersi oltre le tecniche investigative tradizionali. Oggi, tracciare un cellulare è uno dei primi atti di un’inchiesta. Allora era quasi fanta-giudiziaria. Per la prima volta, la Procura si rivolse direttamente alle compagnie telefoniche per i tabulati. Non fu semplice, ma quei dati permisero di smontare gli alibi di Enrico Carella e del cugino Massimiliano Marchetti, due elettricisti di una ditta in subappalto non si trovavano dove avevano dichiarato - l’uno al Lido dalla fidanzata, l’altro in terraferma - bensì ancora all’interno della Fenice, nelle ore cruciali.
«Per quattro schei el gà brusà ea Fenice»
Ai tabulati seguirono le intercettazioni ambientali con cimici all’avanguardia per l’epoca, una delle quali venne piazzata nella Fiat 126 di Marchetti. Fu così che venne captata una frase destinata a diventare simbolo dell’intera vicenda: «Per quattro schei el gà brusà ea Fenice», pronunciata dalla fidanzata di allora. Tecnologia, intuizione investigativa e lavoro della polizia giudiziaria e scientifica iniziarono a stringere il cerchio. Nel gennaio 1997, a un anno dall’incendio, i sospetti sui due elettricisti si erano fatti fondati. A maggio sarebbero stati arresti.
La Viet, piccola impresa veneziana, stava lavorando all’impianto elettrico sotto il palcoscenico come subappaltatrice. Era in ritardo di due mesi e il contratto prevedeva una penale di 250 mila lire al giorno: quindici milioni di lire in tutto, 7.500 euro. Una cifra assolutamente modesta. Ma l’azienda navigava in cattive acque, sommersa dai debiti, incapace di pagare stipendi e bollette. Secondo l’accusa - per cancellare le tracce dei ritardi - Carella aveva pensato di provocare un danno limitato, tale da giustificare una proroga. Il fuoco, però, divorò tutto.
Il 29 marzo 2001 arrivò la sentenza di primo grado. Enrico Carella venne condannato a 7 anni di reclusione, Massimiliano Marchetti a 6, per incendio doloso. Tutti gli imputati per responsabilità colpose, compreso il sindaco Cacciari, furono assolti. Nelle 124 pagine di motivazioni depositate dalla giudice Licia Marino si parlò di un’azione pianificata, di un «patto scellerato» mosso da interessi economici. Il caos del cantiere restava sullo sfondo, degradato a semplice occasione.
Il “colpo di teatro” della testimonianza di un compagno di cella di Carella, che disse che l’elettricista gli aveva raccontato che gli erano stati promessi soldi (non si seppe mai da chi, né si trovarono riscontri) per bruciare il teatro, dopo lo scossone iniziale, svanì nel nulla.
Le condanne furono confermate in Appello nel 2002 e rese definitive dalla Cassazione nel luglio 2003. Marchetti iniziò subito a scontare la pena. Carella, invece, fuggì. Sparì alla vigilia della sentenza definitiva e si rifugiò in Messico, tra Chiapas e Yucatán, sotto falsa identità, lavorando in un ristorante a Cancún. Per anni la Digos di Venezia non smise di cercarlo. Lo sapeva in Messico. A tradirlo fu una telefonata ai familiari: un filo con l’Italia che non riuscì a spezzare.
Ma a costargli l’arresto nel 2006 fu una lite in un pub, che portò la Polizia messicana a controllare i documenti dei presenti. Anche i suoi: falsi. Le impronte digitali rivelarono la verità. Con l’arresto di Carella si chiudeva uno dei capitoli più dolorosi della storia recente di Venezia: quello di un teatro distrutto non dal destino, ma dalla paura di pagare “quattro schei”. Oggi, pene scontate e dimenticate. E La Fenice è rinata dalle sue ceneri.
Riproduzione riservata © il Nord Est

